
I Personaggi
INTRODUZIONE
di
Marcello Ignone
La nostra Mesagne è decisamente più complessa e stratificata di quanto, a prima vista, possa apparire ad un osservatore poco attento. Eppure solo pochi anni fa non sembrava dovesse prendere una simile piega, almeno fino a quando sono venuti meno molti tradizionali riferimenti sociali. Nel paese sembrano coesistere due spinte: la prima è provocata dall’iniziativa individuale in campo economico e sociale, auspicabile e attesa da tempo in aiuto di quella pubblica; l’altra dalla necessità di sempre maggiore qualificazione professionale, culturale e personale. Del resto migliori affermazioni in campo economico e sociale si dovrebbero ormai ottenere solo ed esclusivamente con maggiori e continue riqualificazioni professionali e culturali, ineludibili in un mondo sempre più tecnologicamente e culturalmente avanzato. In caso contrario, eventualità purtroppo ancora presente, il paese non riuscirebbe a sprovincializzarsi e a soddisfare queste due spinte, quanto mai necessarie se si desidera che Mesagne sia in Europa non soltanto per la posizione geografica.
Le due spinte non sono, quindi, in antitesi; anzi, cercare una sintesi tra di esse è una sfida che può produrre risultati positivi in una comunità come la nostra, in crescita disordinata per evidenti strappi mal ricuciti e problemi non risolti e non facilmente risolvibili.
A nostro avviso i risultati saranno di gran lunga più fruttuosi per la nostra comunità se quest’ultima, oltre a coniugare le due spinte, saprà conservare gelosamente anche la memoria del passato e degli uomini che lo fecero. Troppi oggi credono che questo nostro passato sia superato, mentre altri, ipocritamente, lo utilizzano per operazioni nostalgiche i cui fini sono o economici (ma è poi vero che la storia locale tira?) o propagandistici (ma non era stato soppresso il Minculpop?) o autoreferenziali (oggi tutti scrivono, soprattutto il loro nome).
Noi vogliamo proporre uno spazio nel quale far conoscere alcuni degli uomini che ci hanno preceduti, nativi mesagnesi o acquisiti per altre ragioni, per sapere chi eravamo e chi siamo ma, soprattutto, per capire che cos’è la mesagnesità (si perdoni l’ardire, ma non conosciamo un altro termine capace di indicare lo spirito e il modo di essere tipico dei mesagnesi) che ci ha contraddistinto e ci contraddistingue ancora, nel pieno del “villaggio globale”. Crediamo sia importante far coesistere le due spinte precedenti con una maggiore comprensione di noi stessi.
I “medaglioni” e le biografie, più o meno canoniche, di mesagnesi di ieri e di oggi, relativamente ad un passato recente, rappresenteranno forse un obiettivo per alcuni o un esempio per altri; siamo convinti però anche di un’altra loro funzione: possono essere idealmente un comune denominatore, una guida per costruire un futuro di progresso e sviluppo che parta dall’uomo ed approdi all’uomo.

(1888 – 1954)
di
Marcello Ignone
Giovanni Aristide Antoniano Antonucci, di Cosimo e Cosima Schifone, nacque a Mesagne “in un giorno rosso, il primo di maggio”, ma all’anagrafe fu registrato “il giorno cinque, anniversario della morte di Napoleone”, dell’anno 1888. Trascorse l’infanzia e l’adolescenza a Mesagne (gli anni buoni, come ebbe a definirli successivamente) e si trasferì a Lecce per gli studi medi. Per gli studi universitari, invece, si recò a Roma, dove si laureò in legge nel 1913. In “Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti” del 1913, si legge: “Una tesi storica importante. Il giovane Giovanni Antonucci di Cosimo, da Mesagne in provincia di Lecce, si è laureato il legge presso la Regia Università di Roma, svolgendo con esito felicissimo una tesi intorno a: La magistratura baiulare nell’antico comune napolitano. Speriamo che il pregevole lavoro del colto giovane pugliese verrà [sic!] presto dato alle stampe”.Ancor prima di laurearsi aveva pubblicato alcuni lavori su varie riviste pugliesi, tra le quali “La Democrazia”, “Rassegna Pugliese”, “Il Corriere Meridionale”, “Apulia”, “Il Corriere delle Puglie”. Se si eccettua il suo primo lavoro (Saggio di una bibliografia crociana, in “Rassegna Pugliese” del 1911) gli argomenti dei suoi lavori sono tutti di interesse locale. Nel 1912, “durante la guerra di Libia”, scrive un saggio di toponomastica su Mesagne (Mesagne e il problema della sua antica denominazione). In precedenza, e precisamente nel 1909, si era posto all’attenzione dei suoi compaesani quale promotore di una importante iniziativa culturale: fu tra coloro che fondarono una biblioteca popolare, che ebbe però vita breve perché molti volumi, dati in prestito, non fecero più ritorno. Questo episodio non scoraggiò il giovane Antonucci tanto è vero che, pochi anni dopo, lo ritroviamo tra i fondatori della biblioteca popolare intitolata alla memoria di Ugo Granafei, caduto nella guerra per la conquista della Libia.
Nel 1914 diede vita ad un periodico locale, “Castrum Medianum”, che ebbe vita breve, solo due numeri, sia a causa dello scoppio della Grande Guerra che dell’esiguità dei fondi a disposizione. Del resto a quei tempi non era impresa facile dare vita non effimera ad una rivista che si proponesse di “risollevare il culto delle memorie patrie”. Un simile problema sarà avvertito dall’Antonucci anche in altri momenti e per altre riviste ed in special modo per una “regolare rivista storica tarentina”. Partecipò alla prima guerra mondiale e ne uscì vivo ma la vita di trincea gli lasciò in regalo una fastidiosa e dolorosa malattia reumatica che lo tormentò per tutta la vita. A Genova sposò, il 16 ottobre 1919, Giulia Visconti, dalla quale ebbe un figlio. Lo stesso giorno del matrimonio emigrò a Bergamo. Entrato in magistratura, ricoprì dapprima l’incarico di pretore a Cava Manara (Pavia) e, dal 1923, di pretore dirigente a Bergamo, dove curò l’unificazione delle preture locali, reggendo poi il nuovo ufficio non senza preoccupazioni. A Mesagne ritornò poche volte e sempre per motivi dolorosi: la morte della madre nel 1933, la “sciagura più grande che ad un uomo può capitare” e la morte del fratello, medico a Fasano, nel 1936.
Anche “per non pensare troppo ai tanti guai” iniziò a dedicarsi con passione agli studi e alla ricerca, oltre al lavoro, “spugna insaziabile”, che gli darà alcuni problemi, oltre a richiedergli molto impegno. Rimase a Bergamo sino al 1941, anno in cui fu trasferito a Sampierdarena (Genova) dove espletò le funzioni di pretore sino al 1951, quando fu chiamato a presiedere una sezione della Corte d’Appello di Genova. Morì a Sampierdarena l’8 marzo 1954. Sin qui la vita, in breve ma sufficiente a capire che non c’è nulla di eccezionale in essa. Sono eccezionali, invece, l’ingegno e l’erudizione dell’Antonucci. La sua è, infatti, “pura erudizione”, una vocazione, il cui “scopo principale è quello di studiare seriamente la storia” e di “riavvicinarsi ai documenti”. Quasi “un lavoro da fornaciai” con l’intento di erigere “muri solidi” e duraturi a tutto vantaggio della ricerca e della comprensione storica.
L’Antonucci fu un particolare tipo di giurista con alcuni “sogni” nel cassetto: pubblicare un volume sul folklore giuridico italiano ed uno sul medioevo pugliese, precisamente sulle vicende del principato di Taranto. Scrisse moltissimi articoli riguardanti sia il folklore giuridico, sia il principato di Taranto, ma i sospirati volumi restarono “un sogno e gli articoli rimasero articoli”. Le sue intenzioni, tante volte palesate, erano di usare “il diritto medievale” come un’arma, perché, a suo avviso, questo “povero” e “maltrattato” diritto dell’età di mezzo era “ricco di tremende energie” non appieno sfruttate. Un campo quasi inesplorato per quanto concerneva la Puglia e, a dire dell’Antonucci, anche esplorato male. Famosa fu, all’epoca, la polemica che vide contrapposti, sul principato di Taranto, l’Antonucci e Gennaro Maria Monti; quest’ultimo, sfruttando le sue posizioni di forza nel mondo accademico e universitario pugliese, pose addirittura una sorta di veto alle pubblicazioni degli articoli e dei saggi del magistrato mesagnese sulle riviste pugliesi. La polemica, in verità spesso pretestuosa e infantile, angustiò non poco l’Antonucci. Una cosa però è certa: il magistrato mesagnese, anche se non fu un addetto ai lavori (del resto l’antico vizio del mondo accademico, presunto unico detentore della cosiddetta cultura “alta”, di esercitare anacronistici quanto deleteri imprimatur, non è mai del tutto scomparso), nel senso che non ricoprì cariche universitarie o accademiche, fu però uno storico di razza che non giudicò mai in modo strumentale i fatti storici ma cercò sempre con ostinazione il vero, ad onta di “tutte le strombazzature”. Infatti per l’Antonucci sono i documenti e non altro ad avere “diritto a parlare” e la stessa indagine non deve mai “avere fretta né mire spaziose” ma deve, pena l’inconcludenza, “svolgersi in profondità, su zone limitate”.
In definitiva per lo studioso mesagnese fu molto più importante il metodo e non solo i risultati. Cercò, infatti, di abituare il lettore ai testi, ai quali dava una breve e semplice “avviata con un preliminare riassunto” e alle fonti “pazientemente ricercate” e per le quali ebbe un gran fiuto, da vero storico di razza. Questa fu l’ossatura di ogni suo lavoro, piccolo o grande che fosse, dal semplice trafiletto, all’articolo di giornale o di rivista sino al saggio più complesso. Non gli fu facile reperire documenti riguardanti la sua regione, ma in ciò ebbe l’aiuto di amici, tra i quali va ricordato Cosimo Acquaviva, con cui si tenne sempre in contatto. Cercò dappertutto e recuperò documenti e carte che spaziavano in ogni epoca, non disdegnando, anzi ricercando, carte di processi, sentenze, lettere, testamenti, fonti attestanti costumi ed usi da cui, per il Nostro, le leggi traevano origine. Infatti le leggi dell’oggi affondano le loro radici in antiche consuetudini e tradizioni, affiorando spesso nei motti, nei proverbi e nella cultura popolare. Ecco allora l’Antonucci studiare con grande fervore i motti, i proverbi, le carte processuali, le sentenze, le usanze legate al matrimonio, le origini del carnevale, del capodanno, della quaresima, del calendimaggio, delle credenze cristiane ma anche delle usanze barbariche. La sua grande preparazione giuridica e l’ottima tempra di storico, miste ad una non meno eccezionale capacità critica, lo portarono ad affrontare studi diversi, da erudito completo.
I documenti trovati erano analizzati minuziosamente e quando non si sentiva profondamente preparato o esperto, cercava umilmente aiuto, poneva quesiti, sottoponeva ad attenta verifica le soluzioni, mai totalmente pago. Questo avveniva specialmente in campo epigrafico e paleografico perché non le possedeva in modo completo. Occorre constatare, ad onor del vero, che nel leggere i suoi scritti si ha la percezione della loro vastità, che potrebbe essere la causa di questo avvertibile senso di frammentarietà. L’Antonucci scrisse molto e si occupò di molte cose, anche se riuscì benissimo in alcune e bene, talvolta meno bene, in altre. Fu un uomo di vasti orizzonti, aperto, sensibile, e stupisce non poco il fatto che molte problematiche del suo tempo non trovarono posto alcuno nei suoi studi e nelle sue ricerche. Un breve accenno merita il particolare carattere dell’uomo: schivo e polemico, non si curava di nomi famosi o di tradizioni consolidate. Quando un dubbio lo assaliva, dopo un’attenta e meticolosa ricerca, ad esso faceva seguire immediatamente la polemica, e non era mai il primo a smettere. Un grande merito dell’Antonucci, frutto più della sua capacità di indagine critica che di metodo scientifico, fu la non esaltazione o condanna delle tradizioni folcloriche. La sua concezione delle tradizioni popolari e della “cultura tradizionale”, per dirla con il Bronzini, fu idealistica, in linea con la tradizione ottocentesca. Per Mesagne nutrì un profondo e sincero amore, reso acuto e nostalgico per colpa della lontananza.
I suoi studi di “cultura tradizionale” non seppero mai, in nessuna circostanza, indicare i veri bisogni del popolo, in particolare di quello mesagnese. E dire che non gli facevano difetto né lo spirito critico né la polemica. I bisogni e le aspirazioni, del resto, sono evidenti, tra l’altro, proprio negli usi e nei costumi, come nei proverbi e nei motti di scherno. Non intraprese mai nessuna indagine in tal senso né manifestò mai tale desiderio. Seppe, con grande perizia ed acume, studiare le tradizioni legate al folklore giuridico (sono illuminanti in tal senso gli studi sulle tradizioni bergamasche) non come fatti isolati, lontani nel tempo, ma come componenti basilari di una maggiore comprensione della cultura di un determinato territorio. Gli scritti di “cultura tradizionale” del Nostro sono compresi in un periodo di tempo che va dal 1911 al 1934. Ciò non vuol dire che l’Antonucci non si occupò, dopo il ’34, di riscoprire e valorizzare la “cultura tradizionale”, sia essa salentina o bergamasca, ma soltanto che tale ricerca si affinò e perfezionò su singoli temi, spesso troppo specifici. Del resto il suo metodo di studio consisteva nel raccogliere tutto il materiale che in qualche modo potesse essergli un giorno utile o dal quale trarre una notizia, anche piccolissima. Con il tempo, quindi, recuperava i documenti raccolti e ne traeva degli articoli o affinava i precedenti già pubblicati, arricchendoli di nuovi elementi, mai veramente pago del lavoro svolto. Non riuscì, infatti, mai a raccogliere in volume, almeno com’era nei suoi sogni, l’enorme mole di documenti e di scritti, creando così un corpus sul medioevo pugliese, ed in particolare sul principato di Taranto, del quale si occupò per molti anni, producendo tantissimi articoli e molti saggi che se non esauriscono la vicenda storica di quel principato, ne chiariscono molti aspetti. Una bibliografia non completa degli scritti di Antonucci è in P.F. PALUMBO, Patrioti, storici, eruditi salentini e pugliesi, Lecce, Milella 1980; ancora meno completa è quella del mesagnese LUIGI SCODITTI, Bibliografia di Giovanni Antonucci, Galatina, Editrice Pajano & C. 1957 (estratto da “Studi Salentini”, vol. II, dicembre 1956). Oltre al già citato Saggio di una bibliografia crociana (1911), e al famoso Mesagne e il problema della sua antica denominazione (1912, ampliato e pubblicato in volume l’anno seguente), ricordiamo alcuni dei suoi scritti, tra quelli che ci sono sembrati più interessanti (tra parentesi riportiamo l’anno della prima edizione):
- Aneddoti e figure mesagnesi durante il Risorgimento (1916);
- Aneddoti e figure del Risorgimento salentino (1917);
- Gli sponsali di fanciulli (1917);
- Il folklore giuridico (1921);
- Adversus Lombardos: note ed appunti sulla satira politica italiana nel periodo delle origini (1923);
- Curiosità storiche mesagnesi (1929);
- Le vicende feudali del Principato di Taranto nel periodo normanno-svevo (1931);
- Sui principi di Taranto (1931);
- Note critiche: Una data topica – Il “Concistorium Principis” degli Orsini di Taranto – La fortuna di una dottrina (1932);
- La leggenda di San Giorgio e del drago (1932);
- Il Principato di Taranto (1932);
- Note critiche: Il Limitone dei Greci – Il principato angioino di Acaia (1933);
- Medioevo salentino: Un Collegium Pistorum in Otranto? – Sulla antica diocesi di Brindisi – Sulla antica diocesi di Oria (1933);
- Per la storia giuridica della Basilica di S. Nicola di Bari (1934);
- Le decime in Terra d’Otranto (1935);
- Miscellanea salentina (1938);
- Il principato di Taranto: Le origini normanne – Le origini sveve (1938);
- Per la biografia di Francesco Nullo (1939);
- Agiografia e diplomatica (1940);
- Ottone di Brunswich, principe di Taranto (1940);
- Sull’ordinamento feudale del principato di Taranto (1941);
- Nomina locorum (1942);
- Miscellanea epigrafica (1942);
- Curiosità storiche salentine (1943);
- Robertus de Biccaro, conte di Lecce (1943).
Questi scritti, tra i più importanti e noti, possono solo dare l’idea della prolificità dell’Antonucci. La cifra definitiva non è nota, ma dovrebbe essere superiore ai 400 scritti, forse 450 (dalla semplice nota di poche pagine al saggio più impegnativo), anche perché molti rimasero inediti.
Roberto Antonucci (1912-1943)
di
Tranquillino Cavallo
Roberto nacque a Mesagne il 12 novembre 1912 da Oreste, farmacista, e da Maria Nacci. La fanciullezza fu il momento più felice della sua vita, trascorsa tra famiglia e scuola, come sono soliti fare i bambini. Terminate le scuole di primo grado e siccome faceva ben sperare, frequentò gli studi secondari al Collegio Argento di Lecce e al Convitto Nazionale Palmieri. I genitori, naturalmente felici, incoraggiarono Roberto negli studi. A 25 anni si laureò in Medicina e Chirurgia Generale presso l’Università di Pisa (1937) e successivamente, per approfondire gli studi, si iscrisse al corso di specializzazione in Pediatria, presso la Facoltà di Medicina di Bologna. Nel 1938 entrò giovanissimo nella Scuola Allievi ufficiali Medici di Firenze per uscirne sottotenente. Fu assegnato al 3° Reggimento Alpini. Con questo grado fu trasferito in Spagna, dove si distinse, come ufficiale medico di artiglieria, durante la guerra civile che portò al governo il dittatore Franco Bahamonde, leader della Falange espagnola tradicionalista y de la las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Una guerra assurda anche per noi, ché alla fine del conflitto tracciava un bilancio negativo di 5.000 morti ed 11.000 feriti, tra i soldati italiani.
Assegnato nuovamente al Corpo degli Alpini della 4ª Armata, fu trasferito sulle Alpi, dove infuriava una battaglia che in appena quattro giorni, dimostrò l’impreparazione bellica dell’esercito italiano. Durante quei terribili giorni l’Antonucci, benché ferito due volte, continuò la sua opera di assistenza medica ai feriti, non comunicando alla famiglia le sue precarie condizioni di salute. Erano momenti di grande tensione per le nostre truppe che operavano in un terreno montano che raggiungeva, in qualche punto, altitudini superiori ai 3.000 metri con situazioni atmosferiche proibitive ed avverse. Intanto il 28 ottobre 1940 si era aperto un nuovo teatro d’operazioni, il fronte greco. Nell’estate del 1940 si trovavano in Albania, alle dipendenze del Comando superiore d’Albania, tre divisioni di fanteria, una divisione alpina, una divisione corazzata, il 3° reggimento granatieri di Sardegna e tre reggimenti di cavalleria, con il compito di provvedere alla difesa dei confini tra l’Albania e la Jugoslavia. In questo periodo Roberto Antonucci venne assegnato alla 3ª Divisione Alpina Julia – 34ª batteria.
Le operazioni contro la Grecia iniziarono il 28 ottobre e, mentre la difesa del Korciano restava affidata al XXVI Corpo d’Armata, le forze rimanenti operarono nell’Epiro e sul Pindo. Poiché fra la zona epirota e quella macedone si eleva la massa montuosa del Pindo, la divisione alpina Julia avrebbe dovuto occupare il passo di Metzovo, con lo scopo di proteggere il fianco sinistro delle unità avanzanti in Epiro e di assicurare il possesso delle comunicazioni fra i due settori. Malgrado le gravi difficoltà opposte dal terreno e dalle avverse condizioni atmosferiche, nonché dalle numerose interruzioni stradali effettuati dai greci, i raparti italiani avanzarono ordinariamente. Alcuni di essi dovettero compiere, sotto una pioggia torrenziale, marce di oltre 40 km. E, anche se i risultati conseguiti furono inferiori a quelli sperati, nei primi giorni della campagna le divisioni italiane riuscirono ad attestarsi e a resistere vittoriosamente nel Korciano. Forte di queste vittorie l’Antonucci chiese il trasferimento sul fronte russo non presagendo l’epilogo della sua vita. Ed il fato volle che l’intera divisione Julia fosse inviata in Russia a sostegno del II Corpo d’Armata, dove tra il 19 dicembre 1942 ed il 16 gennaio 1943, riuscì a contenere l’avanzata russa nella breccia aperta a sud delle posizioni del Corpo d’Armata alpino.
Il 14 gennaio 1943, i russi iniziarono una nuova grande offensiva, attaccando l’ala destra del Corpo d’Armata e raggiungendo, il giorno seguente, Rossosc, sede del Comando alpino. Nei giorni successivi l’operazione sovietica continuò in profondità con forze corazzate e il 17 gennaio raggiunse Ostrogozsk completando l’accerchiamento degli alpini che, per evitare l’annientamento, iniziarono il ripiegamento, sganciandosi dal contatto con l’avversario sull’intero fronte e abbandonando la linea ancora intatta.I nostri soldati cominciarono a ritirarsi, aprendosi la via con le armi nel cerchio di ferro e di morte che i russi avevano ormai saldamente stretto alle loro spalle, dilagando dalle opposte ali dello schieramento. Furono undici combattimenti, undici cerchi di ferro astiosamente saldati dal nemico, e undici volte spezzati dall’impeto irrefrenabile degli alpini. Furono quattrocento chilometri di marcia nella steppa bianca e sconfinata, sulla neve farinosa, agghiacciati dal vento gelido, flagellati dalla tormenta con 40 gradi sotto zero, senza viveri, con poche munizioni, faticosamente trascinati sulle slitte superstiti, bivaccando all’aperto, spesso marciando anche di notte, attaccati rabbiosamente dal nemico sotto l’incubo delle incursioni aeree. Gli autocarri si arrestavano per mancanza di carburante, le artiglierie rimanevano bloccate dalla neve, i muli cadevano estenuati dal freddo e dalla fatica, le armi s’inceppavano per il gelo, la fila dei combattenti andava man mano assottigliandosi per i caduti, i feriti, i congelati. Furono quindici giorni di marce, di combattimenti, di veglie, di fame, di stenti.
Fra tutti quei soldati vi era anche un sacerdote, cappellano degli alpini, che sosteneva i più stanchi, si chinava a benedire e ad assolvere quelli che cadevano sfiniti, che correva dall’uno e dall’altro come gli permettevano le sue deboli forze, che raccoglieva i lamenti di coloro che invocavano per l’ultima volta la propria mamma. Il suo nome era don Carlo Gnocchi. A noi piace pensare che, in quell’epica ritirata, don Carlo abbia potuto impartire l’ultima benedizione anche al nostro Roberto, prima che egli si addormentasse definitivamente. Successivamente tutte le divisioni furono trasferite nella zona di Gomel-Bobrujsk, da dove rimpatriarono entro il maggio del 1943. Ancora oggi non è possibile fornire cifre esatte delle perdite. I calcoli più attendibili indicano 43.282 feriti, mentre 89.838 furono i caduti ed i dispersi. Vista la profonda commozione, che la scomparsa di Roberto aveva lasciato nei cuori di amici e parenti, si volle cantarne la lode innalzando un monumento ad egli dedicato, alla cui realizzazione furono in molti a dare il loro contributo, in forma veramente partecipata. Esso venne realizzato dallo scultore livornese Giulio Guicci negli stabilimenti di Giorgio Puliti in Pietrasanta. Modello della statua sembra sia stato uno degli stessi fratelli Antonucci. Il 27 novembre 1947 ebbe luogo l’inaugurazione del monumento, alla cui erezione, con assidue laboriose ed intelligenti cure, provvide – oltre naturalmente al padre – un apposito comitato, del quale fecero parte amici e professionisti mesagnesi. L’austera cerimonia riuscì imponente e al cadere del panno che copriva il monumento, la commozione invase l’immensa folla, che accompagnò con applausi interminabili il getto di fiori intorno alla statua, la quale si profilò sullo sfondo del cielo in tutta la sua bellezza. In alto una epigrafe:
Amor patrio mi vinse – Il gelo mi uccise
ma vivo risorgo indicando la via del dovere
Tenente Medico n. Mesagne, 12 nov. 1912
Roberto Antonucci † Russia, Febbraio 1943
La benedizione fu impartita dal reverendo don Daniele Cavaliere, già tenente cappellano del 20° Reggimento Fanteria. Seguirono i discorsi degli amici: il dott. Fabio D’Alonzo, ufficiale medico ed il dott. Eugenio Cutrì, anch’egli ufficiale medico e reduce della campagna di Russia, e del dott. Giovanni Mengano. Il discorso commemorativo fu tenuto dall’avvocato Leonardo De Guido, il quale, con la sua smagliante parola, commosse l’auditorio. Per ultimo prese la parola il notaio Alceste Capodieci, che pronunziò frasi vibranti di sentimento patriottico salutate d’applausi scroscianti. Oltre a tutte le autorità e personalità convenute e all’immensa folla, ci fu anche un picchetto armato che fece gli onori militari. Ad oltre mezzo secolo di distanza quel monumento è ancora lì a ricordare a tutti noi l’inutilità della guerra, la sua irrazionalità e la sua barbarie; ma, nel contempo, può aiutarci a capire meglio e ad apprezzare, il sacrificio, la sofferenza e la morte, di quanti vi parteciparono, obbligati o volontari.
Vale la pena leggere l’ultimo scritto che il padre Oreste volle dedicare all’amato figlio Betto:
A noi non la vittoria, ma dei fiacchi lo scherno; non i felici oroscopi, ma il pallido dover (Cavallotti).
Roberto! Sul fronte di Francia riportasti due ferite e mai me ne rendesti edotto, e per due volte, sempre a mia insaputa, domandasti far parte della spedizione in Russia, come volontario.
Destino orrendo era il tuo! Vani furono i miei consigli, vane le mie insistenze e le mie preghiere; non volesti desistere dal tuo proposito. Partisti, soffristi, ne avesti la morte che orribile morte! Come fiore reciso cadde la tua giovane vita! Moristi nell’età delle soavi illusioni e degli affetti generosi quando l’anima ha slanci irrefrenabili, quando la vita appare tutta gioia! Moristi quando più lieto e più bello ti sorrideva l’avvenire lasciandomi, con “larga eredità di affetti” il dolore più cocente, lo strazio più atroce.
Ed ora, per me, da tanto tragico fato percosso, gelidamente affranto dall’angoscia, tutto il mondo è lutto e tutto ciò che mi circonda è pianto!
Forte stringendo l’affannoso petto
con la bruna vela
nel mar del dolore io mi sospingo!
Possa il tempo spiegare le sue ali consolatrici su questa mia grande sventura, lenirmi lo spasimo, mitigare l’immenso dolore! Ma quando, quale fu la tua fine? Mistero!
Soccombesti forse a Balasov sulla gelida terra d’un fetido “unnker” disteso su di un ghiacciato gradino, con le ginocchia appiccicate nell’incavo delle ginocchia d’un altro già morto, fra le scorie dei dissenterici, il lezzo morboso della cancrena che indisturbata ed inesorabile avanzava sugli arti congelati già in disfacimento, tra i gemiti strazianti, gli urli spaventosi, i deliri ossessionanti dei feriti e dei morenti che, giorno e notte, senza conforto, senza aiuto né speranza di tregua, spasimavano con la certezza d’una orrenda disperata fine?
Ove trascinarono i Mongoli il tuo cadavere, completamente nudo, legato per il collo? Quanto tempo rimanesti insepolto sulla neve, sotto il cielo spietatamente diaccio? La tua carne fu pasto di belve o di tuoi simili, che più di quelle, erano rabbiosamente affamate? E le tue povere ossa? Disperse sulle orrende steppe di Russia e senza pace di tomba. O fosti uno dei tanti che nella desolata, nevosa, sconfinata tundra disseminata di morti, al pallido chiarore lunare, al tenue lucore della neve sterminata, nella cupa turbinosa tempesta, esaurito dalla fame, dal freddo, dalle forzate interminabili marce, esausto, rattrappito, congelato, ti accovacciasti ai lati della lunga teoria di prigionieri, fantasmi nel grigiore della tormenta e, stremato dalle tue ultime energie, rimanesti li a Kalacì aspettando la morte col sistematico proiettile alla nuca?
Ed in quell’ora estrema, con la tristezza infinita della gioventù che si sente morire, quanti cari ricordi balenano nella tua mente, velata dalle sofferenze, già prossima ad offuscarsi, ed evocasti i tuoi cari, le persone amate e chiamando tua madre prorompesti in disperato pianto! Era l’ultimo, ineluttabile, fatale momento del tuo orrendo avverso destino!
Carne stanca e dolorante fuor di tempo e spazio! Non umanità, non amore, né carità, né speranza di aiuto confortarono i tuoi ultimi istanti di vita, “senza baci moristi e senza lacrime”!
Povero figlio, cui fu negato aver chiusi gli occhi da carezza materna o da mani amiche!
Pur sapendoti morto, mi risorgi quotidianamente in affermazione di vita e mi è di conforto ricordare un tuo gesto, una tua parola ove risuoni l’eco del tuo cuore che non ha battute più e che va al mio, che non si consolerà mai più.
Come da mare furente sospinto ad un porto, a te sempre torna il mio pensiero. Parmi sentire la tua voce, e, desioso, ti attendo mentre ho battiti di affetto e sussulti di amore; parmi che tu mi debba apparire improvvisamente per abbracciarmi e ti sento, Betto mio, vicino a me; ho la dolce illusione che l’amor tuo non potrà mai illanguidirsi o mancare; credo che tu , figlio mio, intendi tutti i miei dolori segreti e le pie memorie venerate nel sacrario del cuore! Ma , ahimè! Vaneggio. Invano ti attendo; tu, Betto, non torni più!
Anima eletta, cui non sorrise il sognato avvenire, ti chinasti al fato!
Betto, tu, che mi guardi dal lontano regno dei morti, vedi che tuo padre beve in silenzio la cicuta del pianto e lascia nel tuo ricordo, tutta l’anima sua!
Oh! non senti il sospiro dell’alma
che attraverso gli spazi , desolata, ti anela, ti chiama
lucente di amor patrio cadesti, nella lieta fioritura degli anni,
lasciando orgoglio a noi e agli amici grata Spirito angelicato
dal dovere, il tuo volto mi staglia nel cuore come lampada eterna!
A te penso, per te prego!
Non esiste che una sola virtù : l’eterno sacrificio
un sol fine ha la vita: il dovere.
(Mazzini)
E per il dovere, o infausti politicanti, gentaglia miseranda ed iconoclasta dei valori morali e spirituali che furono la stella orientatrice di tutti i martiri lungo l’ascesa dei loro calvari di strazi, di scempi e di morte, pel dovere tanti giovani lasciarono la loro patria per andare al sacrificio; partirono per andare a sentinella della loro tomba; nella gelida terra seppellirono tutti i loro sogni, tutte le loro speranze, tutti i loro affetti nel momento più bello delle loro aspirazioni verso l’avvenire, ebbero il martirio più infame e “ l’abbandon fraterno!”.
Ma più che la morte puote l’amor! La tua fede nei destini d’Italia; l’orrenda tua fine, le tue povere ossa sperdute in terra straniera, esacerbando il dolore, sublimando il mio affetto per te e perciò, prima di raggiungerti nel regno dell’infinito, ti elevo questo lacrimato marmo, inno, perenne dell’amore umano- ma ben triste e meschino conforto alla mia disperazione – perché il dolce tuo ricordo duri!
Tuo padre

(1913-1993)
di
Marcello Ignone
Francesco Lazzaro Bardicchia nacque a Mesagne il 2 novembre del 1913 ma, come spesso succedeva a quei tempi quando i bambini nascevano in casa, fu registrato all’anagrafe il quindici dello stesso mese. Il padre Augusto, commerciante d’origine leccese, tenne a Mesagne, in piazza Criscuolo, un piccolo negozio di generi alimentari; la madre Pia Cellino, mesagnese, era nipote dell’omonimo cartapestaio che lasciò tracce del suo passaggio in molte opere e restauri. La coppia ebbe sei figli, cinque femmine ed un unico maschio, Francesco. Durante l’adolescenza Francesco si ammalò di tifo e le sue condizioni si aggravarono a tal punto che la famiglia fu costretta a preparare il necessario per il funerale. La madre si rivolse allora a Sant’Antonio che in cartapesta aveva in casa, opera del nonno, pregandolo di salvare l’unico figlio maschio che aveva e di prendere, in cambio, la migliore delle sue figlie. Francesco inspiegabilmente e in pochi giorni guarì dal tifo ma non molto tempo dopo morì la sorella Teresa. L’evento fu interpretato dalla famiglia in modo miracoloso e condizionò non poco il giovane che, infatti, fu legatissimo alla madre, con la quale ebbe un rapporto intenso, basato su di un affetto sincero e forte ma talvolta esagerato.
Il giovane Francesco frequentò la scuola elementare, senza brillare molto ma conseguì ugualmente la licenza. In seguito frequentò da privatista e per alcuni anni la scuola media, ma senza successo. Ritiratosi da scuola preferì lavorare dapprima nel negozio del padre e in seguito ne aprì uno suo, prima in Piazza Porta Piccola e poi in Piazza Coperta. Dopo un fidanzamento durato dieci anni, nel luglio del 1939, Francesco si sposò con Dora Catarozzolo, nonostante che la madre del futuro poeta avesse manifestato intenzioni contrarie. Francesco fu a Brindisi, arruolato in Marina, durante gli anni della seconda guerra mondiale e precisamente a Forte a Mare. Fu durante questa esperienza che probabilmente maturò in lui la passione per la poesia e l’enigmistica. Risalgono, infatti, a questo periodo (1940-42) le sue prime esperienze poetiche in lingua, per lo più sonetti . Il poeta conservò gelosamente tali componimenti sotto alcuni titoli comuni: Ricordi militari, Sonetti agli amici, Sonetti a tempo perso. Nella raccolta manoscritta il poeta inserì anche un sonetto in lingua, Romanticismo, sotto il titolo comune de I miei primi sonetti, nonostante che in questa raccolta ci sia solo questo componimento a farne parte; a piè di pagina lo stesso poeta, come del resto fu sua abitudine, riportò la seguente indicazione: Mesagne P.P.P. 932. Se l’indicazione è precisa, e non c’è motivo per non ritenerla tale, questo sarebbe uno dei primi componimenti, se non il primo, del Bardicchia, composto all’età di 19 anni. Da rilevare, anche, la presenza, sotto il titolo comune di Sonetti dialettali, appunto di un sonetto in vernacolo mesagnese, Tiello a 14 mesi, dedicato al figlio Augusto, datato maggio 1942 e successivamente ristampato con il titolo di Scapulatieddu. Questo dovrebbe essere uno dei primissimi componimenti in dialetto del Nostro che nella raccolta riporta anche un acrostico, scritto per partecipare ad un concorso indetto dalla “Rassegna enigmistica” e pubblicato nel marzo 1942.Molte strofe o addirittura interi componimenti di questa raccolta come di tante altre, saranno successivamente “presi” e “rifatti”, come scrive lo stesso poeta, in pratica ripubblicati e riadattati in tempi successivi.
Subito dopo la guerra ebbe inizio l’amicizia con il dott. Angelo Ribezzi di Latiano. Fu un lungo sodalizio destinato a durare sino alla morte del medico, avvenuta l’ultimo giorno di ottobre del 1975. Ossatura del sodalizio fu l’amore comune per l’enigmistica, le riviste specializzate del settore, la soluzione e la creazione di sciarade, crittografie, intarsi, incastri, anagrammi. Bardicchia fu molto bravo nel crearli, il Ribezzi, che usò lo pseudonimo di Piccolo Bruno, ebbe, invece, un grande acume nel risolverli. I due amici coinvolsero anche altri in questa passione. Quasi tutte le domeniche, infatti, presero l’abitudine di portarsi, con la lambretta del Ribezzi, a Lecce presso l’abitazione di un loro amico, altro grande appassionato di enigmistica, costretto a vivere su di una sedia a rotelle. Di lui conosciamo solo lo pseudonimo, Marmi, che usò nella produzione di giochi enigmistici. Per i tre amici i pomeriggi domenicali vollero dire una sola cosa: compilare e decifrare complicati enigmi, risolvere e creare indovinelli e una miriade di giochi enigmistici che inviarono ad alcune riviste del settore perché fossero pubblicati. Alla morte di Marmi, i due amici superstiti continuarono a riunirsi, sempre di domenica, nella bottega di generi alimentari del poeta per risolvere e creare i loro amati rompicapi. Con la morte dell’amico latianese, con il quale condivise per decenni la passione per l’enigmistica, il poeta mesagnese smise di scrivere sciarade, anagrammi e quant’altro e chiuse definitivamente con l’enigmistica, che da quel momento lo impegnò principalmente come lettore e compilatore passivo de “La settimana enigmistica” e talvolta come compilatore di alcuni aforismi, paradossi, doppi sensi, chiapparelli che pubblicò, in lingua o in vernacolo, in alcuni dei suoi tanti opuscoli.
Con gli pseudonimi di Basco, Fioralbo e Lazzaro, collaborò, da solo o con gli amici, ad alcune riviste del settore , quali “Penombra”, “Corte di Salomone”, “La sfinge”. Lo pseudonimo Basco, formato da parte della prima sillaba di Bardicchia e dall’ultima di Francesco, rappresenta anche il classico copricapo dei contadini meridionali, degli artieri e della povera gente, usato in contrapposizione al “cappello” dei nobili. Bardicchia imparò, quindi, presumibilmente a partire dagli anni Trenta e, con maggiore complessità e convinzione, sicuramente dagli anni Quaranta, la difficile arte di “ridurre in scansioni rigidamente prefissate la ridondanza concettuale e la ricchezza semantica” (Alfonsetti). La poesia del Nostro ebbe comunque un forte sviluppo a partire dalla morte del Ribezzi, quando cominciò a staccarsi dalla produzione enigmistica per divenire finalmente autonoma. In precedenza la produzione poetica era stata, per così dire, funzionale a quella enigmistica. Francesco, per vivere e mantenere la famiglia, non disdegnò di fare l’ambulante all’interno della piazza coperta, al di fuori del negozio di generi alimentari gestito dalla moglie. Tra gli altri generi alimentari vendette anche baccalà e spesso il poeta, preso dalla frenesia di scrivere, per non perdere l’ispirazione poetica e non trovando o non avendo altra carta, scrisse anche su quella del… baccalà e su qualunque altra carta a sua disposizione.
Tutte le poesie prodotte furono personalmente lette dal poeta alla moglie e quando la famiglia aumentò, con l’arrivo dei due figli, Augusto e Teresa, chiamati così in ricordo del padre e della sorella “sacrificata” perché lui potesse vivere, le poesie furono regolarmente lette dal poeta a tutti. Bardicchia non amò il verso libero e il componimento che non fosse soggetto a schemi ritmici rigidi. Scrisse soprattutto nella forma metrica del sonetto e quando non compose in questo metro, ne produsse sempre uno soggetto a rima e a precisi schemi. Compose anche lunghi componimenti in quartine e talvolta in ottave, ma sempre in endecasillabi o settenari legati tra loro da rime disposte in modo vario (alternate, incrociate, baciate). Frequente l’uso di enjambement, ma anche di cesure. Non organizzò mai la sua poesia in schemi ritmici originali anche se il libero gioco di ripetizioni, di parallelismi e di richiami, tipico della poesia moderna e contemporanea, si può individuare in Bardicchia non all’interno del singolo componimento ma tra una serie di componimenti non autonomi che formano una fitta trama di rimandi che stabiliscono rapporti di affinità sia a livello del significante che del significato, quest’ultimo spesso attinto dalla tradizione locale o da avvenimenti e personaggi presi dal contesto familiare ma più spesso dal vicinato e dal più ampio mondo sociale, economico, politico, sportivo e religioso.
La formazione enigmistica si fece sentire molto nella sua composizione poetica anche perché il poeta dovette, durante la sua esperienza enigmistica, affrontare in lingua altri poeti, spesso agguerriti, e l’aspetto formale delle sue composizioni, cioè il significante, fu volutamente portato a livelli abbastanza complicati. Per Bardicchia solo il componimento chiuso, schematicamente rigido, classico, rimato e con forte ispirazione artistica, che lui non sempre avvertì negli altri poeti locali, fu degno di essere chiamato poetico. Predilesse un lungo e continuo lavoro sulla poesia prodotta, che riprese spesso pubblicandola in più testi o frantumandola a piacimento. Produsse anche componimenti su richiesta per matrimoni, nascite o altri eventi, sia privati che pubblici. La ricerca della massima adesione possibile dell’espressione linguistica al pensiero reale, divenne per lui quasi ossessiva, al punto di esagerare, talvolta, nella originalità e preziosità dei termini. Questa ricerca ebbe anche una conseguenza positiva: lo studio degli aspetti ortografici e fonici dei termini dialettali, cosa non facile per l’assenza di scritti in dialetto mesagnese. Bardicchia fu, infatti, capace di indugiare per molto tempo su di un singolo termine dialettale, alla ricerca di tutti i significati possibili, orientandosi talvolta verso parole inconsuete, quasi scomparse dal vernacolo, ormai dimenticate o semplicemente poco usate anche nel passato. Fu a questo punto che nacque un altro sodalizio, quello con Simone Murri, per tentare di capire e di tramandare per iscritto il lessico storico del vernacolo di Mesagne.
Da questa esperienza, non priva di errori, e dalla necessità di avere a disposizione le parole del dialetto mesagnese, specialmente quelle inconsuete, con grafia e significato precisi, il poeta trasse l’uso di conservare per iscritto i termini che poi utilizzò nei suoi componimenti, accarezzando, forse, l’idea di creare un dizionario del nostro vernacolo a disposizione di tutti, in particolare delle giovani generazioni. Cominciò allora a produrre, in particolare negli anni Ottanta, una mole veramente impressionante di componimenti poetici dai temi più svariati spesso legati tra di loro da qualche filo logico ed appartenenti, talvolta, ad una serie facente capo ad un soggetto o ad un tema. Sono rimasti famosi i componimenti contro gli altri “poeti” locali che tentavano malamente di emulare il Nostro, quelli sulla vedovanza, sul Centro storico e su personaggi mesagnesi, veri o inventati. Molti scritti del poeta, e in particolare tre manoscritti già pronti per la stampa donati dalla famiglia, insieme ad altre carte, alla Biblioteca di Mesagne dopo la morte del poeta, sono ancora da esplorare e pubblicare. Sono pure da recuperare, in quanto in parte sicuramente registrati, gli interventi che per un certo periodo Bardicchia fece alle due radio locali di Mesagne, dapprima a Radio Libera 102, poi a Radio Mesagne 101 ed infine di nuovo a Radio Libera.
Non vanno nemmeno dimenticate le tante pubblicazioni, per lo più opuscoli, e le molte raccolte di semplici fotocopie, che il poeta distribuì, recitando spesso personalmente le sue poesie, nelle scuole mesagnesi. Molti di questi interventi, sia radiofonici che scolastici, contengono anche cenni di tradizioni locali e riferimenti a scritti di autori mesagnesi, in particolare Scoditti e Antonucci. Per inciso va detto che il poeta, oltre alle tradizioni locali, amò molto la ricorrenza natalizia, al punto da produrre un gran numero di componimenti poetici, per adulti e bambini, sul tema. Ebbe una vena polemica innata, al punto che bastava poco perché rispondesse per le “rime”, nel vero senso della parola, se credeva di aver subito delle offese o delle umiliazioni a cui, inevitabilmente, fu soggetto per via del particolare carattere, degli argomenti presenti nella sua poesia e per il suo modo tenace e per alcuni forse assillante, anche se comunque sempre garbato, di “donare” le sue pubblicazioni. Queste pubblicazioni ebbero un costo che il poeta non sempre riuscì a sopportare. Le distribuì nel tentativo, quasi mai pienamente riuscito, di pareggiare le spese e questo problema lo angosciò sempre e comunque tutte le volte che fu pubblicata una sua opera.
Lo si vide in giro molte volte, intento a distribuire pazientemente, celando l’imbarazzo dietro un sorriso amaro, le copie della sua ultima pubblicazione, per le quali chiese sempre un “omaggio” da lui stesso quantificato dividendo il costo della pubblicazione per il numero di copie stampato. Non sempre, però, fu possibile coprire i costi delle pubblicazioni e il poeta ci rimise spesso di tasca sua. La cosa che più lo angustiò fu, comunque, vedere le pubblicazioni accatastate nel suo studio e non ancora distribuite. Ci furono anche dei mecenati che gli fecero dono del denaro necessario per pubblicare un’opera e lui cercò sempre di sdebitarsi in un modo o nell’altro non dimenticando mai chi aveva reso concretamente possibile la pubblicazione di una sua opera. Uno di questi mecenati fu il radiologo Angelo Raffaele Devicienti che donò al poeta una somma sufficiente a pubblicare una delle sue primissime opere. Il poeta, appena ebbe raccolto il denaro necessario, in pratica dopo la pubblicazione e la vendita dell’opera, riportò la somma al Devicienti, il quale non volle però rientrarne in possesso. Il gesto commosse molto il poeta che non lo dimenticò mai. Occorre sottolineare che le pubblicazioni non furono mai in vendita, nel senso che non ci furono mai editori o librerie che posero in vendita le opere del Nostro. Fu sempre lo stesso poeta a vendere capillarmente le sue opere, dopo aver tolto un numero di copie sufficiente per i figli e i nipoti, copie regolarmente intestate con i nomi di ognuno e personalmente firmate.
Era, inoltre, di una parsimonia esemplare e nel suo sonetto più famoso, Lu pizzenti, il poeta volle rappresentare un po’ anche se stesso. La moglie e i figli dovevano, infatti, faticare non poco perché fosse presentabile ad una qualche serata in suo onore o ad una conferenza o semplicemente durante il giorno, dal momento che il poeta ebbe un’idea molto personale del vestire. Ecco il sonetto, datato 1972:
LU PIZZENTI
Štirnuta. Cu la coppula štrazzata,
ssittatu a llu pisùlu a soli chinu,
si fuma lu muzzoni a lu bbucchinu
cu ‘na mmalaria ormai ncaddarisciata.
Surchia, poi sputa. Totta llardisciata,
la giacca vecchia comu nnu luštrinu
ti spampana li štampi ti lu vinu
sotta a la barba longa, vavisciata.
No teni nienti. Non avanza nienti.
Non ava ddà e no cerca. A la sciurnata
tira cu tanti suenni ca ncatašta.
Tossa. Si cratta. L’ori sua cchiù lienti
li passa cu la fami a la nuttata,
ma a l’arba mbevi l’aria… e campa… e bašta.
La sua stanza privata, più simile ad un campo di battaglia che ad un luogo di studio, fu tabù per il resto della famiglia e nessuno vi ebbe facilmente accesso. Il questo luogo “sacro” il poeta ebbe l’abitudine di appartarsi, non solo per scrivere ma anche per “sfuggire” a qualche passeggera tempesta familiare. Ebbe un alto concetto della famiglia e preferì perciò di gran lunga un clima sereno e lieto anche ad una semplice burrasca passeggera. Raccolse di tutto, non solo la carta necessaria per scrivere le sue poesie, e conservò come reliquie i premi vinti nei numerosi concorsi di poesia ai quali partecipò. Non ci sarebbe nulla di strano con premi normali come coppe, targhe e diplomi, ma Bardicchia conservò anche i premi… in natura, come i tacchini e gli agnelli vinti nei concorsi ai quali partecipò durante le festività natalizie e pasquali. Dopo aver mangiato i premi in natura con tutta la famiglia, ebbe l’abitudine di conservare alcune… reliquie. Così fece con il tacchino vinto ad un concorso poetico a San Vito dei Normanni del quale conservò la zampa e dopo averla ben pulita e verniciata l’appese ad una parete del suo studio! In pratica di ogni cosa non doveva perdersi il ricordo; l’oblio a cui uomini e cose sono inevitabilmente soggetti fu per lui una vera ossessione, scolpito chiaramente nella sua poesia. Infatti il termine farfugghi, cioè cose inutili e di nessuna importanza, sarà usato dal poeta per ben quaranta volte come titolo comune delle sue pubblicazioni, a partire dal 1979.
Raccontò alla moglie e ai figli ogni cosa rendendoli partecipi dei suoi problemi, delle gioie e delle delusioni. Quando poi sentì avvicinarsi l’ora della definitiva partenza e cominciò a constatare l’inevitabile declino fisico, non volle scrivere più nulla, ma non abbandonò l‘amata enigmistica, che regolarmente continuò a dilettarlo sino agli ultimissimi giorni di vita. Fu la sua amata Dora a portargli in ospedale, due giorni prima della morte, l’ultima copia de “La settimana enigmistica”. Il poeta diede l’addio alla compagna della sua vita con un gesto ondulatorio e continuo del suo basco, quasi presagisse l’imminente fine. Non volle scrivere più nulla subito dopo la prima crisi della malattia che lo avrebbe poi portato alla tomba. Questa prima crisi avvenne nel 1991 e il poeta, terrorizzato dalla morte, per la quale aveva nutrito sempre timore e rispetto, tanto da esorcizzarla con ironia in alcuni suoi sonetti, si rifugiò definitivamente nel suo studio, senza però comporre altre poesie, ma solo a riordinare le sue cose.
Per inciso il tema della morte in Bardicchia compare in “un modo…tutto laico e di una moralità in apparenza machiavelliana se non addirittura boccaccesca…”(Alfonsetti). In verità nei suoi versi, più che il Machiavelli e il Boccaccio, si avverte molto l’ironia, e a tratti anche la satira mordace, del Belli. Per il poeta mesagnese lo studio aveva sempre rappresentato un luogo intimo ed appartato nel più ampio rifugio della casa, degli affetti e della famiglia. Francesco Bardicchia, che sorrideva sornione quando lo chiamavano con il nomignolo Ciccio (che per inciso non amò mai), morì di edema polmonare il 4 aprile del 1993, poco dopo le ore 8, nell’ospedale di Mesagne, nel quale era stato ricoverato al ripresentarsi della malattia. Sul comodino il suo basco e la copia de “La settimana enigmistica” che la moglie gli aveva portato qualche giorno prima. I temi che caratterizzano la poesia del nostro maggiore poeta locale sono in particolare la memoria e la nostalgia, spesso dolorose, talvolta ironiche e disincantate, per luoghi, persone, cose e vicende di un tempo che fu e di un mondo perduto per sempre. Questi temi influenzano molto la poesia più matura di Bardicchia.
Bardicchia ha scritto molto e la non organicità del lavoro non è dovuta solo all’impressionante mole di opere pubblicate e di materiali ancora da pubblicare, ammesso che sia possibile reperirli, ma al modo stesso di fare poesia di Bardicchia, il quale era solito scrivere su qualsiasi pezzo di carta gli capitasse per le mani e con sufficiente spazio vuoto per contenere una poesia o un appunto, come la carta per incartare il baccalà o le fotocopie, delle quali riutilizzava il lato rimasto bianco. Molte poesie, dedicate a qualche personaggio noto di Mesagne o scritte per sottolineare, quasi sempre polemicamente, alcune situazioni o particolari vizi ed abitudini, fanno bella mostra su pareti di studi e laboratori oppure giacciono in qualche cassetto. Sarà sicuramente difficile poterle recuperare tutte. E’ comunque più che sufficiente il materiale reperito o facilmente reperibile, come quello consegnato dal figlio Augusto alla Biblioteca di Mesagne perché fosse a disposizione degli studiosi o come disse lo stesso poeta “a disposizione di chi vorrà interessarsene”, per pubblicare una seria e completa antologia del nostro poeta dialettale più bravo e conosciuto. Bardicchia collabora a varie riviste enigmistiche e da queste esperienze, che coprono un arco di tempo, desumibile dai dati sin qui posseduti, che va dal 1940 al 1975, oltre che dalla frequentazione dell’inseparabile amico Ribezzi, trae linfa per le sue poesie e per un miriade di altri “giochi” enigmistici quali “sciarade, anagrammi, incastri o intarsi, crittografie mnemoniche e molte altre simili composizioni”.
E’ questo un vero laboratorio di tecnica compositiva che arricchisce Bardicchia che inizia a crearsi, così, una sorta di banca dati, nella quale troveranno posto parole, modi di dire, motti, proverbi e molte altre espressioni dialettali utili per il suo lavoro poetico. Inoltre, il dover affrontare continuamente il giudizio del pubblico delle riviste enigmistiche, particolarmente esigente e preparato, e l’inevitabile confronto sia con altri cultori del genere enigmistico che con veri poeti, peraltro in lingua italiana, portarono il Nostro a prepararsi in modo puntiglioso e quindi con la massima precisione formale e contenutistica possibile. A questa banca dati, sempre aperta, il poeta attingerà continuamente. Il laboratorio di idee lo trova altrove e precisamente nell’opera di Gozzano e Corazzini, che Bardicchia ama ed ammira pur non avendo una conoscenza approfondita dell’opera e del pensiero di questi due poeti crepuscolari. Le somiglianze con Gozzano sono molte e talvolta sbalorditive, proprio perché non si può parlare di influenze. Bardicchia può essere, infatti, accostato a Gozzano per la perdita di ogni fede e certezza, per il senso di uno scorato rifugio nella grigia quotidianità.
Si notano forti somiglianze tra la sua poesia e quella colloquiale e prosastica del Gozzano con il quale il poeta mesagnese ha in comune la particolare ironia e l’amara consapevolezza di appartenere ad un tempo colto ma arido e senza miti, con la differenza che in Gozzano si sente, nell’apatia senza speranza, una chiara impronta leopardiana, tanto che si può giustamente parlare di poesia dell’assenza, di vita mancata, di stanca aridità, mentre in Bardicchia c’è una incrollabile fede nei valori familiari, un notevole attaccamento alla vita e una forte paura della morte. Il poeta mesagnese è però, talvolta, assalito da un forte scoramento e da una certa rassegnazione, imputabili ad una perdita di fiducia nella capacità della poesia di poter cambiare le cose, anche solo in minima parte. Allora la poesia di Bardicchia si fa dolente, amara, riflessiva e l’ironia spesso sfocia in spunti polemici contro aspetti, figure, posizioni e persone appartenenti tanto all’ambiente mesagnese quanto ad una sfera più alta, valida universalmente. Bardicchia è un poeta stanco e perplesso dell’assurdità della vita, in particolare di quella moderna; esprime il suo dolore con amara ironia, talvolta con sarcasmo anche crudele, quasi sempre polemicamente. Ha uno stile ironico e mordace, talvolta molto corrosivo, ma mai ribelle, perché il Nostro, in definitiva, è per una vita semplice e sana, una serena esistenza “piccolo borghese” che mal si concilia con la ribellione.
Ecco allora la ricerca spasmodica del rifugio, trovato nel mondo umile e pettegolo del paese natio, dove la gente è forse meno povera di un tempo sul piano economico, ma sicuramente più povera sul piano umano per la perdita di alcuni valori tradizionali. Il poeta cerca quello che resta dei genuini sentimenti di un tempo ma quando si accorge che questo mondo sta irrimediabilmente cambiando e in peggio, allora si rifugia ancora di più negli affetti familiari, nella storia e nelle tradizioni paesane, nei tiempi passati e nella cara infanzia, fatta di sogni e di povere cose. E’ una fuga dalla realtà e dall’impegno politico perché, anche se talvolta può essere forte la presenza sociale e culturale della poesia , un povero poeta non può cambiare nulla a colpi di versi. Ecco allora farsi quasi prepotente il desiderio di un ritorno al mondo dell’adolescenza e dell’infanzia, che altro non è che un desiderio di pace, di disimpegno e di certezze semplici, anche se talvolta di pessimo gusto. Bardicchia rievoca le buone cose di un tempo, la Mesagne di una volta, le vecchie strade, le atmosfere ormai scomparse, gli interni poveri delle case, gli oggetti, le figure umane, personaggi veri o di fantasia, immagini, sentimenti, emozioni capaci di travalicare l’esperienza personale ed acquisire esperienza collettiva.
Tutto è rievocato e descritto con precisione puntigliosa e nostalgica, spesso con una ironia che non disdegna di farsi satira, ma che inevitabilmente sfocia nella polemica, dalla quale il poeta non si tira mai indietro per trasformarsi, con sempre maggiore frequenza e specialmente nella sua opera più matura, quasi subito in un sorriso amaro, appena accennato, ma sofferto e preoccupato. Lo stile della sua produzione in vernacolo, talvolta ricercato e complesso, è generalmente piano, dimesso, discorsivo quando non addirittura antipoetico, formato da parole povere, se non banali e volgari, a causa della ricerca continua ed assillante di un lessico il più possibile simile alle espressioni e al ritmo del parlato quotidiano. Questo è un altro aspetto che lo avvicina molto ai Crepuscolari. Diverso è, invece, lo stile della produzione in lingua, più stucchevole, lezioso, pieno di preziosità e di parole ricercate e poco spontanee perché troppo legate ad un tecnicismo di maniera. Bardicchia è mosso, nella sua produzione in lingua italiana, più dall’apparire che dall’essere e perciò la sua produzione migliore è decisamente quella in vernacolo.
Il mondo del Nostro appare talvolta immobile e la rievocazione del tempo perduto acquista spesso l’odore della morte, intesa come perdita ed allontanamento ed appunto perciò dolorosa ma purtroppo inevitabile, temuta ma alla fine sopportata laicamente dal momento che si lascia un mondo niente affatto a misura umana e meno che mai a misura di poeta. Corazzini è, invece, accostabile a Bardicchia perché poeta-fanciullo, capace di esprimere vera e grande poesia dal vuoto che si nasconde nelle piccole cose, nel tempo e nella parola. Il poeta romano aveva cercato un colloquio e una comunione di anime e lo stesso farà Bardicchia quando cercherà nei suoi componimenti di esprimere una poesia fuori di sé, inseguita nelle piccole cose, nella descrizione divertita, ironica e polemica di personaggi per lo più tipizzati, anche se qualche volta reali. Di queste cose, di questi personaggi e delle tradizioni in genere di Mesagne si rischiava di perdere il ricordo, così come si era perso gran parte dell’uso del vernacolo mesagnese. Il poeta ha voluto allora compiere una scelta: descrivere in dialetto questo mondo, gli usi, le tradizioni, gli uomini e le condizioni di un tempo ormai scomparsi.
La memoria di queste cose e di questi uomini si è ormai persa nelle giovani generazioni ed è a queste che Bardicchia ha dedicato il maggior sforzo e, quasi fossero tutti suoi “nipoti e nipotini”, si è ritagliato il ruolo del nonno adottivo e si è messo a raccontare in versi un mondo forse perduto per sempre ma che ancora si può rievocare e magicamente comunicare grazie alla poesia. Per tutti coloro che non sono più ragazzi ha scelto il ruolo di censore e si è messo a criticare i pessimi costumi attuali, difendendo i buoni usi antichi, i sentimenti di un tempo e le atmosfere ormai perse, che solo la poesia può ricreare grazie alla sua capacità di produrre emozioni e suggestioni. Nel 1986 Bardicchia pubblica un sonetto, suo metro preferito, dal titolo “Gocce d’aceto” in Nzèdduri t’acìtu, 12^ raccolta della collezione “Farfugghi”, per i tipi della tipografia Guarini di Mesagne. E’ quasi un manifesto, in lingua, della poesia del Nostro in quanto ci sono: l’ironia; un disincantato sguardo alla vita che gli appare strana e della quale occorre coglierne il momento; le piccole cose, banali e quotidiane; il pettegolezzo di un paese del profondo Sud e la mentalità in genere della gente che vi abita; la precisione puntigliosa; la ricerca di parole preziose e poco usuali per descrivere ed impreziosire le piccole cose quotidiane.
Le difficoltà che Bardicchia dovette affrontare furono molte perché la poesia non nasce dall’ispirazione di un momento, ma è lavoro certosino, metodico e di grande difficoltà ed un poeta assomiglia, perdonate l’accostamento, più all’avventuriero Indiana Jones, un ricercatore ai confini della lingua, che al romantico professore interpretato da Robin Williams nel film “L’attimo fuggente”. Questa “semplice” verità si deve tenere conto anche come forma di rispetto del messaggio artistico che ci è stato consegnato, considerando che Bardicchia scrisse quasi sempre in dialetto, con la difficoltà che presenta il nostro vernacolo non ancora codificato né in una grammatica né in un dizionario. La nostra attenzione e il nostro rispetto dovrebbero, dunque, essere maggiori e appaiono ingiustificate certe critiche mosse al poeta con superficialità, dal momento che non esistono studi completi della sua opera. E’ ben diverso muovere delle osservazioni critiche nate dallo studio dell’opera del Nostro, necessario per capire il messaggio del poeta, sicuramente non privo di errori ed esagerazioni. Bardicchia concentrò la pubblicazione delle sue poesie, anche di quelle scritte molto tempo prima, lungo un arco di tempo che va dal 1979 al 1990 e i suoi versi, le sue “gocce d’aceto”, non risparmiarono le “situazioni locali dolenti o paradossali e, attraverso di esse, i protagonisti di quelle vicende”, talvolta con “momenti fortemente polemici, di vera irruenza verbale”.
La sua satira, in verità non sempre dura anzi il più delle volte garbata e leggera se non proprio amara, non risparmiò i vizi e i difetti dei mesagnesi, i tempi moderni che il poeta non volle capire né tanto meno giustificare, provando spesso una pena enorme per Mesagne, per come era stata ridotta e trasformata, per come era cambiato, inevitabilmente aggiungiamo noi, il carattere dei suoi abitanti che il poeta, amaramente, vedeva attaccati a comportamenti ed atteggiamenti veramente piccoli ed incoerenti, lontani comunque dai veri valori della vita, un tempo più veri e maggiormente presenti nonostante le difficoltà economiche e sociali. Quel decennio fu di profondo travaglio e di crescita disordinata per Mesagne; Bardicchia, servendosi semplicemente della poesia, ebbe il coraggio di denunciare costantemente la distruzione di un mondo e di una civiltà, e al posto della gratitudine si attirò se non l’odio almeno il “fastidio” di alcuni benpensanti.
La poesia di Bardicchia interpreta benissimo il punto di vista del popolo mesagnese e non deve perciò ingannare più di tanto il lato umoristico ed ironico di molti suoi componimenti. Il poeta mise alla berlina i difetti dei mesagnesi, perché necessario, anche se penoso, per ridere di noi stessi e per cercare, pur sapendo di non riuscire, di riportare tutti a dimensioni più umane. Spesso il tono del poeta si fece lirico oltre la normale liricità propria del sonetto, ciò avvenne ogni volta che evocò la famiglia o diede libero sfogo ai sentimenti, quando si soffermò con profonda nostalgia sulla vita di un tempo non meno che su quella a lui presente, manifestando la sua profonda e naturale religiosità popolare, il suo attaccamento alla famiglia e ai nipoti, ed allora le emozioni personali acquistarono un sapore universale grazie al continuo riandare alle radici antiche di Mesagne, alla descrizione delle persone che un tempo popolavano le vie e le piazze del paese. In molti componimenti poetici Bardicchia si soffermò, con versi dolenti, a descrivere una Mesagne scomparsa del tutto o sul punto di scomparire, ma viva nella sua memoria ed ancora presente alle giovani generazioni grazie alle sue poesie.
In quei componimenti si nota una profonda nostalgia nella descrizione di un mondo ormai perduto, appartenente alla memoria, all’infanzia, quasi mitica, non solo del poeta ma di tutti i mesagnesi nati e vissuti nei bei tiempi passati, non facilmente collocabili cronologicamente, ma vivi nella memoria del poeta, non meno che in quella di tanti compaesani. In molti suoi componimenti è fin troppo chiaro il mondo dell’infanzia per la presenza viva di oggetti e luoghi e personaggi riconducibili a tale periodo. Ci sono in molte poesie gli elementi (odori, sapori, rumori) di un mondo familiare che non finiva con la casa paterna, ma continuava nelle stradine del centro storico, quasi corridoi di un’unica grande abitazione collettiva. Veri quadretti di vita bucolica, semplice e pacifica. Spesso molti suoi componimenti hanno la stessa serenità, data dai brevi ed intensi quadretti descrittivi, di alcune poesie di Carducci, Leopardi e Gozzano. Talvolta nel quadro “idillico” si insinuavano alcune amare precisazioni, per così dire, perturbatori del mitico mondo paesano. Ecco allora apparire llu culèra, la fami, dal momento che non sempre era garantito il cibo, per via della precarietà del lavoro agricolo, in particolare bracciantile (la sciurnatèdda), e, quando il cibo c’era, i membri della famiglia stavano a ntàula tutti quanti ntra nnu piattu.
La povertà fu amaramente rappresentata anche dallo scarso e precario vestiario, da li pezzi, ntra lli scarpi, pi cuazettu. Amaro e polemico, il poeta, denunziò senza veli prièviti e briganti per le condizioni in cui versava il popolo. Quadretti di vita, descrizione di cose semplici e di attività di un tempo che fu appunto, vita ti ieri, appartenente ad un passato talvolta lontano anche dallo stesso poeta, come testimoniano in un suo componimento la štazioni ancora a zeru, li turnisièddi e l’ori cuntàti a l’orologiu a soli, felice espressione poetica per indicare l’antica meridiana che un tempo si trovava in piazza Sitìli. Appartiene però al poeta il tempo del farru assuttu, in altre parole del purè di fave senza altro cibo per contorno. Tempi di ristrettezze economiche, quando a nessuno veniva in mente di buttare via del cibo che, tra l’altro, difficilmente rimaneva dopo un “normale” e frugale pasto perché la fame era tanta ed il cibo poco; erano tempi ti sparagnamientu, non solo per necessità ma anche per mentalità. Una memoria amara per un’epoca ormai perduta ma ancora viva nel poeta e forse, ieri come oggi, in pochi altri che per sensibilità non smettono di amare cose che i più definiscono di “altri tempi” in senso dispregiativo o tutt’al più nostalgico.
Con l’età tutto invecchia, esseri viventi e cose, ma non era l’inevitabile fenomeno naturale che spaventava Bardicchia, quanto, piuttosto, l’invecchiamento, per così dire, “sociale” ed “umano” che notava nella maggior parte dei mesagnesi; avvertiva, infatti, un invecchiamento precoce, un inaridimento della società mesagnese che troppo in fretta dimenticava il suo passato e costruiva un brutto futuro perché non era capace di vivere un buon presente. Quando tutti cercavano opulenza e ricchezza, non importa come e a quale prezzo, il poeta cantava la storia di emarginazione di un pezzente, di un povero ancora realtà in una società che aveva modificato solo l’apparenza, talvolta il conto in banca ma non ancora la mentalità che restava profondamente provinciale e mentre cercava improbabili porti, perdeva di vista la sua storia e le origini che non valorizzava, anzi se ne vergognava, classificando il dialetto come rozzo e incivile e la cultura tradizionale e popolare di categoria inferiore, nella migliore delle ipotesi. Da queste considerazioni amare nasce tanta poesia polemica e satirica e il bisogno di descrivere personaggi e cose, le buone cose di un tempo che non c’è più. Questa poesia delle buone cose di un tempo felice aveva, talvolta, il sapore dell’illusione perché il poeta sapeva chiaramente di rappresentare il tempo dell’anima, l’amore nostalgico per momenti, uomini, cose, avvenimenti, immagini, sapori, profumi, atmosfere, che esistevano sempre più “dentro” e sempre meno “fuori”, dove una città ormai diversa e talvolta estranea non aveva voglia o tempo di godere e di gustare i frutti della memoria e del cuore che il poeta tentava di ricreare.
Molti non sapevano o non capivano o addirittura mal sopportavano questi tesori dell’anima, questi farfugghi e opuscoli che il poeta ostinatamente dava in omaggio per i sostenitori… e per la gioventù studentesca. Già, i giovani, il poeta li amava moltissimo e riponeva in loro molta fiducia, sempre pronto a raccogliere l’invito di qualche insegnante e recarsi a scuola, tra i ragazzi per raccontare loro le cose di un tempo e parlare del dialetto, ormai corrotto o scomparso. Era un nonno per tutti i ragazzi e non solo per i suoi “nipoti e nipotini” ai quali il poeta ha praticamente dedicato gran parte delle sue pubblicazioni e ai ragazzi raccontava delle cose che un tempo si trovavano ne lu štipòni ti li nonni comunicando loro termini del tutto scomparsi dal nostro dialetto perché è ormai scomparso in gran parte anche il “corredo” tradizionale. Per i ragazzi, e non solo per loro, la poesia di Bardicchia rappresenta un tuffo nel passato dei loro nonni, dal momento che termini come scolla (cravatta, scialle), cinnaratùru (ceneraccio), scicca (leggera camicetta), nfocapèpiti (cappotto), zimàrra (sopravveste), capparrùni (cappe, mantelli), tubulèttu (busto), mandràppa (gualdrappa), spitùrsi (stoffe di sacco che i contadini usavano ai piedi durante il lavoro), scafarèi (antichi berretti), sinàli (piccoli grembiuli), scazzittini (berretti di lana per la notte), carzunèttu (mutandone), nigghièri (cuscini, origliere), parapàlli (gonne ampie a campana), ummèddi (gonnelle), busciuncièddu ( sacchetto, cuscino vuoto) e lo stesso štiponi appartengono ormai alla memoria dei nostri anziani.
In definitiva la poesia di Bardicchia è come un tuffo nel passato e nelle tradizioni o, come spesso si dice, negli “usi e costumi” del nostro popolo. Molti bellissimi componimenti, inoltre, ci danno l’opportunità di far notare quanto il Bardicchia fosse debitore verso cunti, proverbi, cantilene e modi di dire della nostra tradizione locale. L’opera di Francesco Bardicchia è ormai parte della storia della nostra cultura la quale altro non è che il bene comune del nostro popolo perché in essa si sedimentano e grazie ad essa fruttificano esperienze ed aspirazioni. Il progresso di un popolo si ha soltanto quando esso è capace di tutelare e successivamente comunicare questo prezioso bene. Bardicchia, il poeta della nostra memoria lo ha fatto, in punta di piedi, con umiltà, e senza chiedere e pretendere compensi di alcun genere ci ha insegnato e ci insegna ancora con le sue poesie che i valori umani sono intramontabili e, soprattutto, non rimano con gli egoismi.
Bibliografia delle opere di Francesco Bardicchia
1) Cara poesia, Mesagne 1987;
2) Cari farfugghi mia. Poesie dialettali mesagnesi, Mesagne 1989 (?);
3) Caru dialettu, Mesagne 1985;
4) Cosi nueštri, Sandonaci 1982;
5) Cranieddi ti sali, Mesagne 1983;
6) Cunchiutimientu, Mesagne 1984;
7) Eccu Misciagni tua, Mesagne 1990;
8) Fantasii, Mesagne 1987;
9) Farfugghi allu ientu, Sandonaci 1982;
10) Farfugghi. Gruppi di poesie dialettali mesagnesi, Mesagne 1979;
11) Io e… me stesso, Mesagne 1987;
12) Iu, la vita e vui, Mesagne 1987;
13) Mietici, malati e miticini, Sandonaci 1980 (?);
14) Mindrodduri, Mesagne 1988 (?);
15) Misciagni: itinerari, Sandonaci 1979;
16) Mmisculanza, Mesagne 1984;
17) Natali a casa noštra. Poesie dialettali natalizie mesagnesi, Sandonaci 1980;
18) Nn’atra francatedda ti farfugghi, Mesagne 1989 (?);
19) Nna francatedda ti farfugghi, Mesagne 1989 (?);
20) ‘Nzedduri t’acitu, Mesagne 1983;
21) Parlamu nu picca ‘ntra nui, Mesagne 1987;
22) Parole senz’ombra. Poesie, Mesagne 1980;
23) Pepi… zzuccuru e carofulà, Mesagne 1984;
24) Poesie dialettali mesagnesi, Fasano 1987;
25) Profili mesagnesi, Sandonaci 1979 (?);
26) Profili nostrani. Poesie dialettali mesagnesi, Fasano 1983.
27) Profili paesani (in 3 voll.), Mesagne 1983 (vol.1), 1984 (voll.2,3);
28) Quadernetti di“Farfugghi”, n.1-4, Mesagne 1988 (?);
29) Quadernetti di“Farfugghi”, n.5-8, Mesagne 1989 (?);
30) Rricuerdi štingusi, Mesagne 1987 (?); <
31) Scirculècchi, Mesagne 1988 (?),
32) Siešta, Mesagne 1984;
33) Štruelichi. Poesie dialettali mesagnesi, Mesagne 1990;
34) Sursati ti marvasia, Mesagne 1984;
35) Tre francati ti farfugghi a farfaruegghiu, Sandonaci 1981;
36) Tutto Natale. Poesie natalizie dialettali mesagnesi, Mesagne 1987 (?);
37) Vecchia Misciagni, Mesagne 1987;

L’evoluzione-involuzione del sonetto nella poesia
di Francesco Bardicchia
di
Roberto Alfonsetti
Senza inoltrarci nella notte dei tempi … enigmistici, il sonetto bardicchiano, (fin dai tempi di “BASCO”), appare sapientemente costruito secondo le migliori norme delle precettistica classica. Gli endecasillabi sono perfettamente limati e cadenzati con i giusti accenti ritmici, e i concetti interfluiscono tra di loro anche per via, dove occorre, di efficaci “enjamtement”. Ma è, soprattutto, nella chiusa concettosa, di cui si fa carico l’ultimo verso del sonetto, e che illumina, da sola, in modo non equivoco il tema trattato, che si rivela la lunga, attenta frequentazione dei classici. Esporremo qui, di seguito, alcuni di questi versi conclusivi di sonetti bardicchiani, – ad illustrazione di quanto sopra detto, – che coprono circa un ventennio (tra il 1967 e il 1988), – riteniamo, il più fecondo -, della produzione complessiva. Essi apparvero, primieramente, su pubblicazioni locali (tutte di breve vita) e, dopo tempi più o meno lunghi, furono poi ripresi nelle ben note, periodiche raccolte a stampa.
“ORA 23” (1967 – 1968)
“ma a l’alba ‘mbevi l’aria, … e campa, … e basta”
(LU PIZZENTI)
“e poi si ‘llava, simili a Pilatu”
(LU MIETUCU)
“e poi sta strata longa, longa, longa…”
(LU BURRIU)
“pi la partita solita a “Tressetti”
(SEZIONE COMMERCIANTI)
“per chi si vergognò … d’aver vergogna”
(MACELLU VECCHIU)
“IL CASTELLO” (1977 – 1978)
“puru la morti la rimanda a crai”
(SIERDA)
“ca tici tantu senza ‘ddica niente”
(MAMMATA)
“INCONTRO” (1988)
“nu velu biancu, neru ti cinica”
(LA VINDIOLA)
“l’urtama farsa la scta vivi iddu”
(TIATRU COMUNALI)
Da notare, ne “LA VINDIOLA2, COME, IN UN SOLO VERSO, Bardicchia abbia saputo costruire, con effetti non solo cromatici, la “la callida junctura” tra «biancu» e «neru», ma anche, nel complesso, un’ottima figura chiastica, a conferma del sicuro possesso, che Egli aveva, dei “fondamentali” del sonetto, in particolare. Certo, la cospicua, successiva produzione, potè nuocere all’efficacia lirico-descrittiva e, con l’andar del tempo, anche per l’avvento di occasionali momenti di “vis polemica”, il sonetto perde in efficacia complessiva: complice, anche, l’uso sempre più frequente di “parole-zeppa”, ossessionato, com’Egli era, dall’effetto della rima. Ma era anche, l’effetto di una “stanchezza” più complessiva, preannunciata in “CUNCHIUTIMIENTU (1985)” e sanzionata in “ECCU MISCIAGNI TUA” (Gennaio 1991), dove, un foglietto manoscritto inserito subito dopo la copertina, si annunciava la fine delle pubblicazioni e un ideale passaggio di testimone “a chi vorrà interessarsene” (delle altre raccolte inedite già ordinate). Ne conosciamo i titoli, perché da Lui anticipati in “CUNCHIUTIMIENTU” :sette in vernacolo e due in lingua). Alla Sua morte, fu istituita una Commissione di studio per la pubblicazione graduale di tutti gli inediti, e, a breve dovrebbe uscire il primo volume. Questo lavoro, il primo, è da tempo terminato, e, quindi, non sarebbe mai troppo … presto. In conclusione, vorremmo ricordarLo con “NOVEMBRI” (dalla collana “Li Misi”) composta, come si vede, nel 1974, nell’età felice della prima raccolta a stampa (FARFUGGHI), delle prime radio “libere” e, soprattutto, della prima e più efficacia Sua musa.
CICCIO BARDICCHIA
a 10 anni dalla morte
(nel 90° anniversario della sua nascita)
di
Augusto Bardicchia
Sono 10 anni, ormai, che Ciccio Bardicchia, non declama più versi in vernacolo alla sua e per la sua amata Mesagne, anche se in tutto questo tempo l’eco della sua voce inconfondibile ritorna nei nostri cuori, forse un po’ più flebile, ma comunque presente. E’ inutile dire che io come figlio, sicuramente più di altri, sento più che mai il peso della sua dipartita, ed in tutti questi anni ho sempre cercato di ripensare al suo vissuto, non solo come padre ma anche , e forse principalmente, come uomo e come poeta. Compito non facile, come non facile è stata la sua vita. Ripensare a mio padre, sicuramente è un impegno da portare avanti con perseveranza, dato che più scavo nella sua esistenza più mi accorgo che di lui conoscevo solo una parte, forse preponderante, ma sicuramente non sufficiente a farmi affermare che per me fosse un libro aperto. Tutto questo mi porta a riflettere criticamente anche sui rapporti che hanno caratterizzato la sua e la mia esistenza in quegli anni, in seno alla nostra famiglia, e sicuramente ciò mi aiuta a conoscere meglio anche me stesso. In tale ottica trovo oltremodo stimolante questo mio impegno introspettivo, non solo perché mi permette di valutare con maggiore distacco vicende e momenti della nostra vita in modo più obiettivo, ma mi offre anche la possibilità di porgere a quanti lo conobbero e lo apprezzarono, come poeta, un contributo di arricchimento. Se è vero che Mesagne riconosce in lui un’identità artistica impregnata di “mesagnesità”, io come figlio sento il peso di quest’eredità da difendere e da coltivare nel tessuto sociale che lo ha visto crescere e morire, specialmente presso le giovani generazioni che non lo hanno conosciuto.
Ciccio Bardicchia è da sempre identificato come il poeta mesagnese capace di guardare alle vicende umane in modo particolarissimo filtrandole con quella vena di sottile ironia con cui addolciva anche le verità più amare. Attraverso la sua sterminata produzione ha delineato una identità letteraria intimamente legata a questa sua terra. E’ vissuto sempre lì, nel cuore della sua vecchia Mesagne: Piazza Vecchia e Mercato Coperto. Era lì che riusciva a captare, con le sue sensibilissime antenne di artista vero gli umori, i profumi, i sentimenti di quelle esistenze semplici e complesse nello stesso tempo, ma incomparabilmente piene di umanità. Era questo l’humus che ha sempre nutrito la sua vena poetica “popolare”, intendendo questo termine nel suo significato più nobile. La poesia in vernacolo di mio padre, però, deve essere soppesata non solo valutandone i contenuti, ma anche la qualità poetica del suo verso, la sua purezza stilistica , nonché il rispetto dei canoni della metrica. Il suo verso è stato sempre fluido e ricco lessicalmente, piacevole e musicale, poichè per lui un componimento poetico doveva essere sempre intriso di armonia interiore e di musicalità, e per raggiungere la “sua” perfezione ritornava a limare fino all’ossessione i suoi versi. Ogni sua produzione era il frutto di una ricerca maniacale, come si evince dai suoi manoscritti dove si notano le innumerevoli correzioni successive alla prima stesura. Tale lavoro poteva essere possibile solo se nel suo retroterra culturale ci fosse stata una ricchezza lessicale ed una solida base sintattica e linguistica e, considerato che mio padre era in possesso solo della licenza di quinta elementare, viene da chiedersi come fosse possibile ciò. D’altra parte non è che ogni tanto non scivolasse in qualche “licenza poetica” di natura grammaticale e qualche volta sintattica, ma è proprio questo suo continuo anelare alla perfezione, mai pienamente raggiunta, che ci fa comprendere quanto lungo e faticoso sia stato il suo percorso artistico.
Per tutta la vita ha avuto voglia d’imparare; era un instancabile lettore di romanzi gialli e non solo, in tal modo l’ortografia, la grammatica e la sintassi le apprendeva sul campo,dalla lingua viva di tanti autori dei quali aveva imparato ad apprezzare le sfumature letterarie e i diversi stili espressivi. Uno come lui, poi, non poteva non amare la poesia: i più importanti poeti gli erano familiari. Io stesso ricordo a memoria brani della Divina Commedia solo perché rimanevo affascinato dall’espressività che sapeva esternare quando ne recitava i versi a pranzo. Il Conte Ugolino, io bambino, mi sembrava di vederlo di persona mentre azzannava il cranio dell’Arcivescovo Ruggieri. Prediligeva Guido Gozzano, tanto che, spesso, nella sua stessa poesia riecheggia qualche eco di quei versi così dolci e crepuscolari. Insomma mio padre si è fatto così, tutto da solo. La molla però che costantemente ha alimentato la sua sete di sapere e di imparare, è stato il suo insopprimibile bisogno di scrivere versi. Poeti si nasce, l’arte in qualunque forma espressiva non s’impara, nasce con noi, si può certamente affinare, ma il vero poeta, secondo me fa versi anche quando pensa ed affronta i problemi di ogni giorno. Le sue più belle liriche sono nate sulla carta in cui avvolgeva il baccalà, nei momenti in cui era intento alla vendita al dettaglio, da ambulante, sotto la pensilina del Mercato Coperto, che ora non esiste più. C’è un aspetto della sua storia artistica però che quasi nessuno conosce e che io in questo mio scritto intendo mettere in luce, che rappresenta un po’ l’altra faccia di una stessa medaglia. Fino ad ora di Francesco Bardicchia si è sempre apprezzata la sua poesia in vernacolo, ma lui in vernacolo ha prodotto in modo massiccio solo dal ’75, o quanto meno da quel momento ha prodotto quasi SOLO in vernacolo. E prima cosa ha scritto? Possibile che della sua poesia si conosca solo ciò che ha scritto dai sessant’anni e passa ?
La verità è che mio padre, fin da quando ha saputo tenere la penna in mano ha prodotto versi e la maggior parte della sua produzione precedente quell’anno è in lingua, inframmezzata anche da non pochi componimenti in vernacolo. La sua però è stata sempre una produzione che potremmo definire “speciale” perché appartenente ad un genere molto particolare e poco conosciuto, almeno a quei livelli. Mio padre è stato per decenni un cultore dell’enigmistica, e da vero amante del genere non disdegnava le riviste di grande tiratura perché i suoi primi lavori hanno trovato ospitalità proprio sulle pagine della Settimana Enigmistica e pertanto per questo periodico nutriva una particolare predilezione. Io però intendo precisare e portare alla conoscenza di tutti che l’enigmistica da lui prodotta apparteneva ad un diverso livello rispetto a quello comunemente inteso. Esisteva allora (mi riferisco agli anni ’30-’40) un gruppo ristretto di cultori del genere che su tutto il territorio nazionale non superava le duecento unità. Essi mantenevano assidui contatti pubblicando i propri lavori su riviste di limitatissima tiratura ( Penombra, La Sfinge, Il labirinto, La Corte di Salomone, Fiamma Perenne e qualche altra ancora di cui ora mi sfugge il titolo). Costoro erano persone specialissime che si cimentavano nella produzione e nella soluzione di giochi espressi in forma poetica o sotto forma di enunciati brevissimi, che per difficoltà erano alla portata solo delle loro eccezionali capacità intuitive e culturali. Ecco cosa ha fatto mio padre fino ai sessantadue anni. Produceva giochi in forma poetica e risolveva poi quelli degli altri. Lo accompagnava in questa sua passione un altro valentissimo ed inseparabile amico, il dott. Angelo Ribezzi di Latiano, con il quale per ben quarant’anni ogni domenica si incontrava a casa mia per trascorrere, in questo specialissimo e silenziosissimo modo, alcune ore. Mio padre cessò di fare enigmistica nell’anno in cui questo carissimo amico lasciò la scena terrena. Per lui fu un colpo tremendo dal quale non si riebbe mai completamente e fu allora che decise di smettere. Dalle ceneri del poeta enigmista nacque, dopo poco, il poeta del vernacolo che tutti conoscono. Fare enigmistica richiede il possesso di doti artistiche spiccate e solide, dato che comporre un lavoro implica fondere insieme alle finezze propriamente poetiche anche un rigore assoluto nella ricerca dei termini che si prestano ai doppi sensi. In appendice a tale mio scritto presenterò alcuni suoi lavori che daranno la possibilità di chiarire meglio quanto io sto cercando di dire. Posso certamente affermare che questo suo hobby era una vera disciplina che richiedeva il rispetto di ferrei limiti e dure regole e mio padre in questo era un maestro.
Chiedo scusa ai lettori se in questo mio scritto mi sono lasciato un po’ prendere la mano, un figlio non potrà mai essere un buon critico quando scrive del padre. Ho cercato di essere il più possibilmente freddo e controllato, ma forse con scarsi risultati. Gli anni che passano sono il filtro migliore per assegnare il giusto valore a ciò che ognuno di noi ha compiuto durante la propria vita. Mesagne però, nella persona di chi ne tutela i destini, ha il dovere morale di tutelare la memoria di questo poeta, dato che poco dopo la sua sepoltura terrena fu chiesto alla famiglia di donare alla Biblioteca Comunale, cuore culturale della città, i manoscritti in suo possesso, con la promessa di una rivisitazione critica di tutta la sua opera, per una futura pubblicazione dell’OPERA OMNIA a cura del Comune. A dieci anni dalla sua morte tutto tace. Mi auguro che questo silenzio sia di meditazione sul da farsi e non foriero di brutti presagi. Quanto meno Ciccio Bardicchia merita di essere ricordato, non solo da chi gli è stato vicino per tutta la vita.
Daniele Cavaliere (1909-1990)
di
Angelo Catarozzolo
Non so perché si debba dire e scrivere su personalità di rilievo dopo la loro morte, e non offrire, invece, alle stesse la soddisfazione di riconoscimenti gratificanti durante la vita. Non che don Daniele ambisse gratificazioni e riconoscimenti, tutt’altro: chi si era premurato di fargli giungere nel 1986 l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana sa bene quale fu la sua reazione. Voglio dire che egli avrebbe meritato di più in vita, da parte di chi ha pure apprezzato le sue doti singolari di mente e di cuore. Faccio questa considerazione con tutta semplicità, forse anche per la caratteristica, comune a tutti, che le esperienze vissute da ragazzi lasciano il segno per tutta la vita. Don Daniele, infatti, mi accolse undicenne nel Seminario di Brindisi, di cui era Rettore, e mi avviò agli studi ginnasiali. Era il 5 ottobre 1936. Questo ricordo sovrasta tutti gli altri. Allora don Daniele aveva 27 anni. Egli, infatti, nacque a Mesagne il 20 giugno 1909 da Vincenzo Cavaliere – in città da tutti conosciuto come “‘Nzinu ti la Rossa”- e da Maria Carmela -“donna Melina”- Taberini. Il 1° agosto successivo ricevette il sacramento dell’iniziazione cristiana nella chiesa Matrice dal canonico don Noè Campi ed al fonte battesimale gli fu anche imposto il nome di “Giuseppe”. Padrini furono i coniugi Silvio Murri e Teodorina Alessano. IL 24 aprile 1916, a 7 anni, ricevette la cresima. “Soldato di Cristo” – così diceva il catechismo di Pio X- a 7 anni. Il dato sembra offrire già, in nuce”, una vigoria inusuale. E proprio la presenza fisica ed il temperamento aperto e gioviale riscossero tanta ammirazione e disegnarono in me l’ideale del prete e dell’educatore, che non avrei più dimenticato. Lo volli, poi, alla mia prima Messa per l’omelia sul sacerdozio, perché mi avviasse anche nel cammino ministeriale, dopo quello della formazione seminaristica.
Dalla prima giovinezza, quindi, lo vidi come un condottiero… e in seguito mi parve assai naturale che indossasse la divisa di ufficiale cappellano. Don Daniele, infatti, dopo aver compiuto i suoi studi nel ginnasio di Brindisi e nel liceo classico “Palmieri” di Lecce, completò gli studi teologici nel Seminario regionale di Molfetta e, ordinato sacerdote il 23 settembre 1933, cantò la sua prima Messa solenne il giorno seguente nella chiesa Matrice di Mesagne. Dall’anno successivo fu accolto nel Clero brindisino ed iniziò nel capoluogo un’intensa opera in favore dei giovani. Fu rettore del Collegio vescovile e del Seminario minore e, presso il liceo classico “Benedetto Marzolla”, fu guida di molti studenti come docente di religione. L’influenza positiva esercitata nella formazione del giovane Daniele Cavaliere dai suoi “maestri” – il professore don Eugenio Maizza; don Pasquale Micelli, parroco della chiesa del Rosario in Lecce e vera guida spirituale nel suo cammino vocazionale; mons. Francesco De Filippis- diedero ben presto molti frutti. In quegli anni brindisini, infatti, egli fu anche responsabile diocesano della Gioventù di Azione cattolica ed è vivo in molti il ricordo entusiasta di iniziative, nelle quali il giovane sacerdote riusciva a coinvolgere tutti. Se molti furono i giovani da lui “incontrati” ed ai quali ha parlato con entusiasmo, infiniti sono gli amici, che da ogni luogo lo hanno ricordato – e per tutta la vita – per i benefici della sua azione pastorale quando, scoppiato il secondo conflitto mondiale, don Daniele, arruolatosi nel 1941 come volontario nel servizio di cappellano militare del 200 Reggimento fanteria “Brescia”, prestò la sua opera, prima per undici mesi in Cirenaica, e poi in Inghilterra, come compagno di prigionia per quattro lunghi e duri anni.
Quello del suo impegno come cappellano militare fu un capitolo molto significativo della sua esistenza, un capitolo-guida, una pietra miliare a cui faceva riferimento, per trarre sempre nuova forza e nuovi stimoli al suo impegno pastorale. Dall’esperienza dei prigionieri di guerra all’altra simile di cappellano della Casa circondariale di Brindisi, dopo il rientro in patria nel 1946, per l’assistenza dei detenuti. Nello stesso periodo diresse l’Opera Diocesana di Assistenza (ODA) per le colonie marine e collinari ai ragazzi. Tra i giovani e immerso nell’umanità che soffre, don Daniele è sempre in prima linea: la sua nobiltà d’animo svetta per umanità, le sue parole sollevano chi è caduto e chi cerca una strada. Nel 1949 fu nominato canonico del Capitolo cattedrale di Brindisi ed il 12 febbraio 1955 riceveva la nomina di arciprete curato della Collegiata di “Tutti i Santi” in Mesagne, ufficio al quale ha adempiuto dal 1° maggio di quell’anno sino al 31 dicembre 1984, momento in cui, compiuti i 75 anni di età, rassegnò le dimissioni, così come vogliono le norme del nuovo Codice di diritto canonico. Un’intera esistenza, quindi, spesa per il Popolo di Dio ed ho letto con gioia le testimonianze pubblicate da un gruppo di amici, sacerdoti e laici: un impianto musivo affascinante, illuminato dai ricordi della sua ricca umanità e della sua cultura. Sento, però, di dover “integrare” quanto è stato scritto sulla sua figura, con il chiaro riferimento alla identità sacerdotale, che fu a monte della sua passione umana e culturale.
L’ho commemorato più volte: nella sua Comunità parrocchiale; nell’annuale liturgia di suffragio promossa dai pensionati CISL, sindacato di cui è stato rappresentante regionale negli ultimi anni della sua vita, quelli più intensamente dedicati all’assistenza agli anziani e che gli valsero la nomina, nel 1986, a Cavaliere al merito della Repubblica Italiana; negli incontri dei soci Lions e Rotary, tra i quali aveva lasciato il gradito ricordo delle sue dotte conferenze. In ogni circostanza ho privilegiato l’identità del sacerdote, fondamento e sublimazione delle sue doti umane ed intellettuali. L’identità del ministro di Dio, infatti, parte dalla fede, ricevuta in dono nel Battesimo, che è all’origine del sacerdozio comune dei fedeli. Ma per i prescelti al carisma del ministero sacerdotale deve crescere di intensità per motivare la generosità della sequela di Cristo. E il sacerdozio di don Daniele fu segnato da fede limpida e robusta. Soprattutto la parentesi del servizio militare in periodo bellico va visto in quest’ottica. Non si lascia, infatti, la condizione favorevole, pur pastoralmente impegnata, in Patria, tra la stima del vescovo, dei confratelli e degli amici, per un ministero ad alto rischio, senza una forte vocazione, originata ed alimentata dalla luce della fede, la sola che può sospingere sulle frontiere di grandi ideali, i cuori più generosi. E don Daniele fu un uomo di fede.
Credeva nel carisma del sacerdozio per cui offrì il ministero illuminato ai seminaristi e agli studenti, ai giovani di Azione cattolica e ai ragazzi assistiti nelle colonie, ai militari e ai detenuti. Uomo di fede che andava all’essenziale, fuori dagli orpelli del devozionismo, disincantando con espressioni talvolta paradossali, pietismi e formalismi, indirizzando la pietà popolare verso i valori evangelici. Se è vero che la parola manifesta la ricchezza del cuore (ex abundantia cordis os loquitur), senza convinzioni di fede autentica non sarebbe stato il “Ministro della Parola”, non solo per trent’anni nella Chiesa Matrice di Mesagne, ma sui pergami prestigiosi di tante chiese in Diocesi e fuori, e nei tanti incontri culturali, religiosi e laici, ove fu ardente e forbito oratore. Forse non scrisse, se non in poche occasioni, perché si sentiva più realizzato nell’arte dell’eloquenza , per la forza di comunicativa, con cui avvinceva l’uditorio. Alla fede attinse lo stile di Chiesa, sintonizzato sul rinnovamento Conciliare. Seguì ed applicò la riforma liturgica e promosse il confronto anche con le posizioni avanzate dei teologi contemporanei, pur respingendo le effimere suggestioni del dissenso. Fu puntualmente presente, guidando gruppi di giovani, ai corsi cristologici della Cittadella di Assisi, attento alle aperture al nuovo, senza rinunciare alla saggezza dell’equilibrio ecclesiale. Lo stile di Chiesa lo rese uomo di dialogo, senza ombre di radicalismi, quando la conflittualità delle ideologie imperversanti a Mesagne, come altrove, rendevano talvolta difficili i comuni rapporti umani e sociali.
Nelle peculiarità di un certo localismo, anche a Mesagne si rivelò provvidenziale la sua presenza dialogante, utile per favorire giusti equilibri cittadini. Anche in questo campo sarà ricordato nella cittadina come condottiero. Ma dove più si riflette lo stile di Chiesa fu nell’amore verso i poveri. Egli stesso povero tra i poveri. Eppure non trascurò il rapporto con la piccola borghesia locale, ma senza mai rinunciare alla condizione di povertà, con lo sguardo fiducioso rivolto verso la Divina Provvidenza. È la povertà l’ultimo insegnamento del pastore e del maestro, testamento di trasparenza evangelica. Scelse di riposare – dal 5 agosto 1990, data in cui lasciò il cammino terreno – sotto la nuda terra, accanto ai poveri, per condividere, in umiltà, con essi la “beatitudine” promessa da Cristo in vista del Regno dei cieli.
Antonio Criscuolo (1819-1871)
di
Mario Vinci
Antonio Criscuolo nacque a Mesagne nel 1819, da padre napoletano, Alessandro, di professione orafo, e da madre mesagnese, Carmela Devicienti. Nel manoscritto (fine ‘800) di Paolino Cavaliere si legge che la sua casa natale era ubicata nella piazza che oggi porta il suo nome, “sopra il trappeto di Giustiniano Sconosciuto”. Poco più che ventenne, si trasferì a Napoli per intraprendere gli studi artistici presso l’Accademia delle Belle Arti, dove si diplomò. Successivamente partecipò con sue opere a diverse mostre, ricevendone apprezzamenti e premi. In una di queste mostre vinse il primo premio con il quadro “Ragazzi che giocano a gatta cieca”. A Napoli dipinse anche una grande tela, “Napoleone che valica le Alpi”, che è conservata nel bellissimo palazzo della famiglia Pignatelli, sempre a Napoli.
Chiamato a Taranto per eseguire alcuni lavori, in particolare il ritratto del marchese di Beaumont, vi rimase, trovandovi non solo lavoro, ma anche moglie. Sposò Raffaela Talamo e dal matrimonio nacquero tre figli, Carmela, Alessandro ed Elisa. Alessandro fu un valente avvocato ed un eccellente oratore, di lui ricordiamo il discorso tenuto a Taranto dove aprì una scuola di disegno e fra i suoi allievi ci fu, fra gli altri, Francesco Bruni. In questo periodo eseguì moltissime opere, specialmente ritratti che ancora oggi si conservano presso molte famiglie patrizie tarantine e salentine, tra cui la famiglia Carducci e Cacace a Taranto, la famiglia Gallucci a Galantina e l’Antoglietta a Lecce. A Francavilla Fontana dipinse i soffitti del palazzo ducale e a Taranto quelli del palazzo Cacace-Maggi.
Restaurò, inoltre, la cupola del Cappellone di San Cataldo a Taranto e dipinse gli affreschi della chiesa di Santa Chiara. Nella sua terra natia era solito recarsi per rivedere i suoi cari. Mesagne possiede due sue opere, che ancora oggi si possono ammirare: il quadro dell’Immacolata Concezione, che si conserva presso la chiesa omonima in Piazza Vittorio Emanuele, ed il quadro di Sant’Antonio da Padova, conservato presso la chiesa di Santa Maria in Betlemme in Piazza Garibaldi. A testimonianza del suo amore per Mesagne esiste anche una litografia, recentemente ristampata, nella quale si può ammirare una veduta del paese da ponente come si presentava alla metà del secolo scorso. Fu anche ufficiale della Guardia Nazionale e nutrì ideali liberali. Morì a Taranto il 10 dicembre del 1871.
Antonio Epicoco (1883-1968)
di
Angelo Sconosciuto
“Ancora dona eppur donato ha tanto,
ché tanto ha amato
ed ama, ed ama ognora;
sol che l’amare, alfin, or men gli costa,
perché tutte le lacrime le ha sparse
in quella vigna che rimane sua…
Sono gli ultimi, ingenui versi di una poesia, che “un concittadino devotamente” offriva a monsignor Antonio Epicoco nell’aprile del 1954. Il foglietto, con 21 versi divisi in quattro strofe, fu stampato dalla Tipografia Pettograsso e – come si direbbe oggi – “volantinato” in alcune migliaia di copie. L’arciprete aveva da poco lasciato ufficialmente – dopo oltre un quarto di secolo – la cura delle anime; aveva lasciato “quella vigna che rimane sua e nella quale, evidentemente, aveva profuso i suoi sforzi migliori. Quelle lacrime degli ingenui versi del volantino altro non fanno ricordare se non le parole del salmista: “Nell’andare, se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare, viene con giubilo, portando i suoi covoni”. Mons. Epicoco aveva ereditato quella vigna da coltivare a 35 anni. Scrive egli stesso nella sua Raccolta di memorie patrie: “Per dissensi sorti tra il Reverendo Capitolo e l’arciprete [don Simone] Cavaliere, circa l’Amministrazione dei Beni parrocchiali e capitolari, questi dovette dimettersi l’11 febbraio 1928, succedendogli nella cura delle Anime, per volontà dell’arcivescovo di Brindisi, mons. Fra Tommaso Valeri, di santa memoria, il sac. Don Antonio Epicoco, quel che riporta queste notizie. Passata l’amministrazione del Beneficio al Rev.mo Capitolo, all’arciprete non rimaneva che la sola cura delle Anime e di celebrare le sacre funzioni e la solennità come prima dignità del Capitolo.
In tale condizione, quello che ha potuto fare di meglio per la Chiesa Matrice l’Arciprete Epicoco, durante la sua cura di Anime, è stato: il restauro del succorpo, la fusione di due campane, la più piccola e la seconda dopo la campana maggiore (furono fuse dalla rinomata Ditta Poli di Vittorio Veneto); le iscrizioni ricordano l’epoca e le diverse circostanze; furono benedette con grande solennità e intervento di Autorità religiose, civili, militari, e gran concorso di popolo; due altari di marmo, quello dello Spirito Santo e quello dell’Assunta con il restauro del grande quadro, in occasione della definizione dogmatica dell’Assunzione di Maria Santissima, due grandi nicchie ai lati dell’altare della Madonna del Carmine, tutti i finestroni (circa 24) in telaiatura di ferro e vetri colorati, due dei quali istoriati, il maggiore è quello del coro; inoltre la ricostruzione della volta della chiesa di San Cosimo. Dopo 26 anni di cura di Anime, l’arciprete mons. Antonio Epicoco, ormai stanco ed avanzato negli anni e dopo ripetute istanze al legittimo superiore, l’arcivescovo mons. Francesco De Filippis, volle spontaneamente dimettersi col 31 dicembre 1953″.
Se è vero che le costruzioni parlano per gli uomini, molte cose restano a ricordare l’opera di mons. Epicoco. Ciò che è meno appariscente, però, e che forse maggiormente andrebbe messo in evidenza, è il modo in cui “coltivava” ogni singolo alberello della sua vigna, che conosceva da ben più tempo, almeno dai primi anni di questo secolo, da quando cioè divenne sacerdote. Mons. Antonio Epicoco, infatti, nacque a Mesagne il 10 gennaio 1883 da Giovanni ed Elena Poci e, dopo aver frequentato le scuole elementari in loco, nel 1899 lo troviamo in Seminario ad Oria, alunno della terza ginnasiale. Qui tra gli altri maestri trovò la sua prima guida spirituale nel vicedirettore di quell’Istituto, don Antonio Stella di Martano. Il sacerdote fu autentico faro per lui che, a tanti anni di distanza, ricordando il suo primo viaggio – quello fatto da studente a Pompei con il vescovo di Oria, Teodosio Maria Gargiulo, e durante il quale conobbe il Beato Bartolo Longo – annotava nei suoi appunti le qualità di presbitero di don Stella, il suo essere prodigo di consigli sul metodo di studio e sull’organizzazione del proprio vivere quotidiano. In una parola, don Antonio Stella iniziò a fare di mons. Epicoco un autentico “vignaiolo” per la vigna del popolo di Dio. E quando iniziò a coltivare la sua vigna (nel 1928, Mesagne non aveva altre parrocchie se non la Chiesa Matrice) “papa ‘Ntunucciu” – come divenne presto per tutti – orientò il suo impegno lungo due direttrici. Egli, infatti, cercò sempre di dedicare la massima attenzione al culto facendo sì che questo non fosse fine a se stesso ma, proprio attraverso di esso, il Popolo di Dio che era a Mesagne vivesse appieno la sua cattolicità e si sentisse davvero parte della Chiesa universale.
Sono da inquadrare in quest’ottica i numerosi interventi e le iniziative intraprese: ogni opera coincideva sempre con avvenimenti importanti, con tappe fondamentali per il cammino della Chiesa universale. Due esempi per tutti. Nel 1933 – anno santo straordinario della redenzione- restaurò il succorpo della Chiesa matrice e nel 1954, in occasione della definizione dogmatica dell’Assunzione di Maria Vergine al Cielo, provvide a far restaurare l’altare dedicato a quel mistero mariano. Egli però voleva che in ogni luogo fosse dedicata la massima attenzione alle cose sacre, a ciò che parlava della cristianità e non esitava, molte volte, ad esprimere giudizi. Anche in ciò illuminanti risultano alcuni brani della sua Raccolta di memorie patrie. Il primo riguarda il trasferimento del Calvario nei pressi della Chiesa del Crocefisso. “Era certamente questo – scrive mons. Epicoco – il luogo più conveniente per tale monumento, vicino ad una chiesa dedicata alla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo”. Molto più significativo il brano in cui tratta delle ultime vicende del Convento di Santa Maria della Luce nel Centro storico. Avvenimenti che lo videro autentico protagonista.
“Andate via le tre decrepite monache nel 1906 – scrive – la Chiesa rimase ancora aperta al culto per lo zelo ed interessamento della Pia Unione delle Figlie di Maria quivi installata fin dal 1874 anno di fondazione, finché il 13 aprile 1913, per ordine ministeriale, provocato dalla nostra Amministrazione Comunale, veniva chiusa al culto. I locali del Convento servirono per vari usi per conto del Municipio; della Chiesa e di ogni utensile se ne fece il massimo scempio; dell’organo, in ottimo stato, si approfittò per venderlo come metallo, specie che si era al tempo della I Guerra mondiale; i soldati, accasermati nel Convento, profanarono quei luoghi santi in tutti i modi. Dopo 5 anni e 4 mesi, per mio interessamento, veniva nuovamente riaperta al culto, con funzione di riconciliazione e Messa solenne. Detta riapertura durò pochi mesi, perché dopo la Pasqua del 1919, di nuovo fu ordinata la chiusura al pubblico culto, dopo aver speso del denaro per metterla in una degna condizione del servizio di Dio. L’Amministrazione comunale di quel tempo col sindaco il dott. Annibale Profilo, ne sollecitava la chiusura, per incominciare i lavori di demolizione per l’erigendo mercato coperto. Da parte mia posi tutto l’impegno per evitare tale demolizione, specialmente della Chiesa, proponendo al sig. Prefetto della Provincia… l’erezione di un Orfanotrofio di guerra. Viene lodata la mia proposta umanitaria e patriottica; ma fu risposto che essendosi fatto un contratto di vendita con una società di Mesagne, questo non si poteva sciogliere. Fu un ritrovato che non reggeva, perché tutti i contratti emessi in tempo di guerra potevansi benissimo sciogliere, specialmente che si trattava di un’opera sì altamente nobile, civile, patriottica…”.
Egli, dunque, fu autentico protagonista della vita civile – e non solo ecclesiale – di Mesagne. Un autentico “vignaiolo” che non trascurò mai un alberello, nemmeno il più restio a portare frutti. Che egli abbia inciso profondamente sulla comunità civica non vi è dubbio: non sarebbe ancora oggi ricordato; non si direbbe ancora per indicare il periodo in cui fu arciprete: “Alli tiempi ti papa ‘Ntunucciu”; non si farebbe ricorso continuamente ad un’aneddotica fiorente, che rivela le sue doti di profonda umanità, soprattutto verso i grandi e piccoli problemi di coscienza che assillavano ogni famiglia, e verso i bambini, che frequentavano la parrocchia, ai quali perdonava sovente le marachelle infantili. Scriveva, infatti, l’anonimo concittadino nella seconda strofa: “Passa tra i bimbi e l’accarezza piano, lieve, come il giogo del Signore, e sempre a qualche cosa da donare: un confettino, od una medaglina, una parola buona, o un predichino…”.
Lasciata ufficialmente la cura d’anime, mons. Antonio Epicoco – fu anche Vicario foraneo ed ebbe come onorificenza pontificia la nomina a Cameriere segreto dì Sua Santità- si dedicò a stendere una Raccolta di memorie patrie, rimaste dattiloscritte, nelle quali senza pretesa, come in un collage, attingendo alle fonti ed agli scritti su Mesagne, cercò di mettere insieme notizie utili sui monumenti civili e religiosi della cittadina. L’opera, tuttavia, ha un pregio indubbio: quello di contenere “aggiunte di notizie di tempi più vicini a noi”, che mons. Epicoco riporta probabilmente anche per fissare le non poche cose da lui realizzate. Altro indubbio pregio di queste pagine, però, è quello di aver raccolto la tradizione orale della pietà popolare mesagnese. Ne esce, così, uno spaccato della Mesagne dei primi decenni di questo secolo, certamente poco studiata e che, invece, andrebbe degnamente approfondita. Sempre nello stesso periodo, provvide ad ordinare gli appunti dei suoi numerosi viaggi, fatti in vari luoghi in Italia ed all’estero. raccolse quelle impressioni su alcuni grossi quaderni, e volentieri li leggeva a quanti – soprattutto in estate – preferivano trascorrere le serate con lui, nell’amata villeggiatura di “Ficcanterra”.
Anche quegli appunti, come tutta la sua vita, sono un continuo rendere grazie al Creatore “per i numerosi benefici corporali e spirituali” concessigli. Lo stile di vita fu sempre quello e può essere racchiuso in poche parole, che lo stesso mons. Epicoco scrisse su un foglietto: “…senza ricercatezza e senza studio; perché, secondo me, le cose al naturale riescono meglio”. E con quello stile, anche dopo aver rassegnato le dimissioni da arciprete, continuò a coltivare “la vigna che rimase sua” ed i raccolti continuarono a essere copiosi. Il 17 dicembre 1968 lasciò la vita terrena e la comunità cittadina in lacrime. Certamente, quando si presentò al Padrone della vigna per rendere conto del suo operato, non aveva le mani vuote.

(1875-1923)
UNA SERATA ALL’INSEGNA DEL MANDOLINO
CON IL MAESTRO FERDINANDO FASANO
Non è stata ancora ufficializzata la data di inaugurazione del teatro comunale che già si pensa ad una sua intitolazione. Naturalmente tanti i talenti artistici che Mesagne annovera nei propri cittadini che l’imbarazzo della scelta è davvero tale. Comunque in questi giorni bisogna registrare una richiesta della famiglia Fasano di murare, nel rinnovato teatro comunale, un’epigrafe commemorativa a ricordo nel musicista Ferdinando Fasano (1875-1923). Uscito dalle scene musicali in giovane età, aveva appena 48 anni, egli nella sua vita fu autore di numerose opere musicali che proprio nel teatro comunale videro la prima rappresentazione. Musica sacra, classi e folkloristica che rimase impressa nei suoi cittadini tanto che molti anni dopo gli anno intitolato una via e un’associazione musicale. Ancora vivo nelle cronache il ricordo di un concerto di mandolini, tenuto nel 1898, le quali scrissero testualmente: «Fu un programma attraentissimo e svariato al Fasano ed ai suoi bravi cooperatori furono tributati applausi vivissimo. Piacquero moltissimo il Notturno, il carnevale di Venezia, la forza del destino e la marcia, ma il pezzo che suscitò un vero entusiasmo fu la “Serenade” di Schubert, ridotta ed eseguita dallo stesso Fasano magistralmente sulla mandola con accompagnamento di pianoforte, mentre i due mandolini nascosti tra le quinte eseguivano lo smorzo. L’effetto fu stupendo ed il maestro Fasano, che si rivelò squisitissimo esecutore, fu vivamente applaudito». Serate musicali di gran pregio e di commemorazione dei propri artisti che sicuramente l’amministrazione comunale ha in animo di riproporre ai propri concittadini non appena saranno chiari gli indirizzi gestionali della struttura.

(1922-1997)
di
Tranquillino Cavallo
Il 15 dicembre 1997, alle ore 9.00, è ritornato alla Casa del Padre mons. Armando Franco, Vescovo di Oria e nostro concittadino. E’ difficile parlare di mons. Armando Franco, uomo straordinario, sacerdote esemplare fin nel profondo e servo del Vangelo. Le sue armi erano un sorriso schietto, spontaneo ed uno sguardo intenso e limpido, una parola suadente ed una volontà indomita che non si arrendeva mai e non si piegava al potere. Era nato a Mesagne, in provincia di Brindisi, il 6 maggio del 1922, ed a soli 25 anni venne ordinato Sacerdote; successivamente, per i suoi meriti, ricoprì la carica di vicario generale della diocesi di Brindisi. Nel 1977 venne investito della dignità episcopale con mandato nella diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, che si trovò a guidare quale presule durante i tragici giorni del terremoto lucano. Da allora iniziò un itinerario che lo portò a spostarsi di frequente. Nel 1981 fu nominato Vescovo di Oria, succedendo a mons. Salvatore De Giorgi. Quanti lo conoscevano vedevano in lui un mendicante per amore, con quel dono soprannaturale che trapelava dalla sua persona, un uomo che stendeva la mano a tutti, costringendo a dare e a dare con gioia, anche dalle persone più restie. Per questi suoi talenti mons. Franco, per il secondo triennio, era stato nominato presidente della Caritas Italiana e della Consulta ecclesiale degli organismi socio-assistenziali, incarichi ai quali dedicava gran parte del suo tempo.
Egli riusciva a convincere e guidare con la sua parola chiara, precisa e volutamente misurata, era come il distillato di una cultura vasta e profonda, sapeva conquistare il cuore di tutti con la sua bontà e semplicità. Come uomo di governo non conosceva compromessi: amava guidare con la carità e l’opera di convinzione, ma sapeva essere serenamente fermo quando il caso lo richiedeva, ed era inflessibile e intransigente di fronte a coloro che mirassero a calpestare i diritti della Chiesa o ad ostacolare il ministero pastorale dei suoi sacerdoti. Da qualche hanno era riuscito a realizzare il nuovo Seminario Vescovile presso il Santuario dei Santi Cosimo e Damiano nei pressi di Oria, progetto a cui teneva particolarmente. Grande era in lui il senso del dovere, l’eccezionale capacità di lavoro, l’amorosa cura del tempo e il bisogno della preghiera. Per mons. Franco l’amore a Dio era principalmente azione, iniziativa, audacia, rischio e rinnegamento di sé fino al sacrificio cruento come sommo ideale. Il 13 luglio del 1997, in occasione delle celebrazioni per il 50° di sacerdozio, don Armando aveva voluto trascorrere questo avvenimento, tra la sua gente partecipando con loro ai riti religiosi in onore della Vergine SS. del Carmelo di Mesagne. La sua grande umanità e l’incisiva intelligenza avevano fatto di lui un messaggero di pace. Per questo aveva deciso di far realizzare una Via Crucis, in terracotta, da donare a Natale alla Chiesa di Sarajevo affinché gli abitanti di questo stato bosniaco potessero verificare l’azione continua di solidarietà dei cristiani, e noi cristiano avremmo appreso la necessità di vivere questi rapporti nella solidarietà dello spirito cristiano.
A Natale nella chiesa di San Giuseppe a Turbe, presso Travnik, don Armando (come lo chiamavamo affettuosamente noi mesagnesi) non ebbe il conforto di veder realizzate le sue opere in quanto non era presente a consegnare le 14 formelle all’Arcivescovo Pulijic di Sarajevo perché il Signore lo aveva invitato alla sua festa. Crediamo doveroso e importante riportare l’ultimo scritto di mons. Armando Franco, pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, pubblicato il 15 dicembre 1997, giorno della sua morte, perché contiene anche il testo del messaggio per il vicino Natale Il presule mesagnese aveva affidato tale messaggio dapprima al periodico cegliese “L’idea” e poi successivamente fu pubblicato anche dal giornale salentino “Quotidiano” del 16 dicembre 1997. Ecco il testo:
«L’idea di donare una Via Crucis ad una Chiesa distrutta nella diocesi di Sarajevo è quanto mai importante per due motivi: perché in primo luogo dà agli abitanti della parrocchia prescelta dal cardinale Puijlic la possibilità di verificare l’azione continua di solidarietà che giunge dai cristiani, e d’altro canto dimostra a coloro che fanno questo dono – in questo caso la Caritas Italiana e tutta la comunità che essa rappresenta – quanto sia grande la necessità di vivere rapporti di solidarietà nello spirito cristiano. Questo Natale ci dà l’occasione per realizzare quanto noi auspichiamo che avvenga, proprio in quello spirito di solidarietà che Cristo ci ha insegnato. Lo stesso messaggio trasmesso da questa opera che il maestro Cosimo Giuliano sta realizzando. Quando parlo di società, mi riferisco a tutto il popolo cristiano. Perché questo gesto appartiene – lo sottolineo – a tutti: non solo alla diocesi di Oria, ma a tutte le chiese di Puglia e direi a tutte le chiese d’Italia. Così esso rappresenta un’espressione solidale e corale di questo nostro atteggiamento nei confronti degli abitanti di Sarajevo. Un popolo che possiamo definire di martiri, perché con la loro costanza e la loro fedeltà alla parola del Signore hanno dato testimonianza di quanto sia grande e radicato questo loro attaccamento alla fede: attaccamento a Dio, nella persona di Nostro Signore Gesù Cristo, che non trova confronti nella storia. Dopo il pane e le coperte, dopo gli aiuti materiali organizzati nei momenti più difficili, ora con questo dono della “Via Crucis” vogliamo che la “ricostruzione” di questa città martoriata non avvenga solo nelle pietre, ma anche nello Spirito. Questo coinvolgendo le persone che sentono ancora vivo il loro messaggio cristiano e che lo potranno vivere attraverso la liturgia , proprio in quella chiesa dove la “Via Crucis” verrà collocata. Quattordici tappe che ci uniranno in un cammino comune. Perché il vincolo che ci lega a questa gente non è dato solo dalla vicinanza geografica, ma anche da quel mare Adriatico che da sempre costituisce la culla della nostra storia comune.
Questo dono, queste 14 formelle costituiranno una sorta di ideale itinerario che continuerà ad unirci attraverso questo mare. La rappresentazione poi di due delle 14 terrecotte – una dedicata al “Contingente di pace” che attualmente opera nella ex Jugoslavia e l’altra ai giornalisti che hanno raccontato, a volte morendo, quella guerra – è significativa proprio per il rispettivo contributo che gli uni e gli altri hanno dato alla storia di questo popolo. Rivolgo però un appello: ai giornalisti di trasferire all’attenzione della gente (attraverso l’uso dei mass-media), questa iniziativa della Comunità cristiana; e al Contingente italiano di essere solidale con questo gesto che racchiude un messaggio che va oltre il semplice dono. E magari lo stesso Stato maggiore dell’Esercito ci aiuti a trasferire a Sarajevo le opere realizzate. Nella ricorrenza del Natale si è soliti scambiarsi gli auguri: auguri di benessere, di buona salute soprattutto, oltre agli scopi che ci si possono prefiggere. E’ un modo anche per rinnovare i sentimenti di amicizia che legano due persone, sue famiglie, due gruppi. E in questo ci si dimentica che il primo augurio deve essere scambiato con il festeggiato. A Betlemme nacque un bimbo cui fu posto il nome di Gesù che significa “Dio salva”. Di questo bambino nato profugo in terra straniera si festeggia il compleanno. Nacque in terra straniera perché Maria e Giuseppe, uniti in matrimonio, si recarono a dare il proprio nome per il censimento ordinato da Cesare Augusto. In quel viaggio non trovarono alcuno che li ospitasse. E dopo aver chiesto all’albergatore del tempo, che certamente vedeva Maria in situazione avanzata di maternità, dovettero convenire che non c’era posto per essi: “Non c’era posto nell’alloggio”, dice l’evangelista Luca (2,7).
Non c’era posto. Non ce n’era allora, non ce n’è oggi. Non ci fu posto per Gesù, non ce n’è per tanti che portano il suo stesso nome di “uomo”. Non ce n’è per tanti extracomunitari, che pure sono in mezzo a noi, condividono con noi gioie e speranze, in molti casi sono diventati i nostri servitori. Non c’è posto per essi, che consideriamo di razza inferiore, per il diverso colore della pelle, per la diversità di cultura, per mentalità religiosa, o per altri motivi. Non c’è posto per essi, perché vivono clandestinamente, sono sbarcati all’improvviso, senza che nessuno li attendesse per accoglierli. Non c’è tuttora posto per essi, che sono sfrattati dalla nostra mensa, senza alcun segno di umanità verso di essi. Non c’è posto per essi che supponiamo sfrattati dai loro paesi, perseguitati a ragione o a torto; non c’è posto per essi sfuggiti ad un agguato scampati a morte sicura, ricercati per essere distrutti. Non c’è posto perché non vogliamo che i loro figli giochino con i nostri, perché il divertimento resti un affare di famiglia, privato. Non c’è posto per essi che sappiamo dediti alla prostituzione e che guadagnano bene. E non pensiamo che c’è fra di noi chi ricorre a loro per soddisfare le proprie passioni, per ripromettersi lucrosi profitti. Non c’è posto per essi, che turbano i nostri sonno tranquilli, che non vogliamo vedere mendicare oggi, per non turbare la serenità di questo giorno. Ma è proprio sereno il giorno in cui non vedo che ogni uomo è mio fratello? L’augurio è allora questo: che il nostro sorriso raggiunga tutti gli uomini, di ogni colore, di ogni razza, di ogni religione e a ciascuno dica: tu sei mio fratello, auguri! Buon Natale!»

(1878-1911)
di
Mario Vinci
Granafei Ugo Enrico Eduardo Marcar Estor, nacque a Mesagne il 22 settembre del 1878 da una nobile ed antica famiglia salentina, i Granafei marchesi di Serranova [1]. Il padre Giuseppe, la madre Iran d’Abro dei principi Pagratide [2], erano residenti a Napoli alla Riviera di Chiaia, ma abitualmente soggiornavano a Mesagne, nella splendida tenuta di Castello Acquaro, per poter meglio amministrare l’ingente patrimonio terriero posseduto in territorio di Mesagne e Brindisi. Ugo affrontò i primi studi presso il liceo Palmieri di Lecce, successivamente si trasferì nel Convitto militarizzato di Salerno [3]. Il 12 ottobre del 1898 fu sottoposto a visita di leva ed il 28 dello stesso mese entrò nella Scuola Militare di Modena, ammesso a mezza pensione gratuita per meriti personali [4]. L’8 settembre del 1900 viene nominato Sottotenente nel 6° Reggimento Lancieri d’Aosta ed il 13 ottobre del 1903 promosso al grado di Tenente in detto Reggimento e nominato Ufficiale d’Ordinanza di S.E. il Tenente Generale Viganò, Comandante il VII° Corpo d’Armata [5]. Granafei avrà subito modo di distinguersi, mettendosi al servizio della popolazione duramente colpita dall’eruzione del Vesuvio del 1906. In quella occasione gli sarà conferita una medaglia d’argento al valore civile con la seguente motivazione: “Decorato della medaglia d’argento al valore civile perché adoperandosi con grave rischio della vita, sotto l’incessante pioggia di grossi lapilli e dove maggiore era il pericolo, nell’opera di salvataggio, riuscendo così d’esempio ai suoi dipendenti” – Ottaviano (Napoli) 4 aprile 1906 – R.D. 12 settembre 1906 –
Nel 1908 morì in Napoli il marchese Giuseppe Granafei, la madre marchesa Iran d’Abro, avrà l’incombenza di dover amministrare l’ingente patrimonio immobiliare [6], i tre figli, tutti militari in carriera, non potevano esserle d’aiuto; oltre Ugo vi era Aslan tenente nella Regia Marina e Giorgio capitano nel 24° Reggimento Fanteria; sempre in quell’anno i Granafei consolideranno il patrimonio immobiliare acquistando dagli eredi Imperiali il castello di Mesagne [7]. Il 12 maggio 1910 è trasferito nel Reggimento dei Cavalleggeri di Piacenza e l’11 maggio dell’anno successivo esonerato dal servizio di Ufficiale d’Ordinanza del Generale Viganò ed assegnato al 15° Reggimento dei Cavalleggeri di Lodi di stanza ad Aversa [8]. Intanto, il Governo Giolitti, nell’ottobre del 1911, decretava l’invasione della Libia e la guerra contro la Turchia per soddisfare il sogno coloniale di molti italiani (si parlava già di quarta sponda), sperando anche che i nuovi territori potessero assorbire il crescente fenomeno dell’emigrazione dal Mezzogiorno d’Italia. Ben presto però di tutto questo restò solo il ricordo, le vittime si contarono a centinaia, durante il conflitto furono impiegati 55.000 uomini, i caduti in battaglia furono 1.014, mentre 3.179 furono i feriti e 1948 i morti per malattia [9].
Il 9 ottobre del 1911 dal porto di Napoli vengono imbarcati alla volta di Tripoli il 1° e il 3° Squadrone dei Cavalleggeri di Lodi, tra questi vi era anche Ugo Granafei. Sbarcheranno nel porto libico il 15 e verranno alloggiati nella casa Giamil-Bey, adibita a caserma di cavalleria, vicinissima all’oasi di Henni-Bu-Meliana, dove la notte tra il 25 ed il 26 ottobre scoppiò una cruenta battaglia tra le truppe italiane e l’esercito turco, appoggiato dagli arabi. Questa battaglia passerà alla storia come le giornate di Sciara-Sciat [10]. Del primo Corpo di Spedizione, sbarcato a Tripoli l’11 ottobre, faceva parte anche l’11° Reggimento Bersaglieri e tra questi valorosi soldati vi era anche un altro mesagnese, il bersagliere Carmelo Giorgio decorato con medaglia di bronzo al valore militare. Nel rapporto inviato al Comando di Reggimento dal tenente Giovanni Castelli, comandante del 1° Squadrone Cavalleggeri di Lodi, si legge:
«Dalla Caserma Sidi Mesri, 30 ottobre 1911 – Al Comando del Reggimento Cavalleggeri di Lodi (15°) – Aversa
Compio il doloroso dovere di informare codesto Comando delle perdite avute dallo Squadrone, nonché degli uomini messi fuori combattimento per le ferite riportate durante il combattimento del 26 mattina a Sciara Zama. All’alba del 26 dalle trincee, distanti solo duecento metri dall’accampamento dei due Squadroni, fu suonato il segnale d’allarme, che si confuse subito con un nutritissimo fuoco di fucileria. Lo Squadrone appiedato accorse verso le trincee, le quali erano state assaltate sul fronte da un piccolo drappello di cavalleria nemica seguito a breve distanza da numerosa fanteria turca ed araba, mentre alle spalle delle trincee stesse un’orda numerosissima di arabi traditori effettuava simultaneamente un altro attacco. Lo Squadrone, unitamente al 2° Squadrone, con valore che è stato additato ad esempio a tutto il Corpo di spedizione, accorse la dove ferveva la mischia riuscendo dopo quattro ore e più di accanito combattimento a fare riconquistare le trincee ad alcune compagnie di fanteria nonché a fugare l’orda degli arabi traditori. Il combattimento cessò verso le 10,30 e per quattro ore ininterrotte fu sostenuta una lotta titanica, sia per il numero degli avversari che per gli attacchi sostenuti da tutte le direzioni. Intanto qui sotto trascrivo il nome dei nostri cari ed amati fratelli che versarono il sangue loro col grido d’Italia sulle labbra, di Savoia e della nostra cara famiglia “Cavalleggeri di Lodi”. Additerò ora in succinto gli atti di valore personale di quelli che non sono più nelle file dello Squadrone:
- Capitano Goffredo Lorenzo […]
- Tenente Solaroli barone Paolo […]
- Tenente Granafei sig. Ugo: cadde colpito da un sol colpo d’arma da fuoco alla testa, ed al sottoscritto che lo rinvenne dopo il combattimento parve vederlo dormire di un sonno di pace e soddisfatto del suo operato. Armato di una pistola Mauser egli continuò, per circa un’ora di combattimento, inflessibile nella posizione d’inginocchio, come se fosse ad un campo di tiro, ad eseguire un fuoco nutrito circondato dal suo plotone senza recedere di un passo. Con l’esempio e con la voce trasformò i suoi trenta cavalleggeri in altrettanti eroi. Il Caporal Maggiore Sassi che gli fu sempre dappresso rammenta che durante il combattimento un arabo si avvicinò al plotone strisciando per terra seguito da altri suoi compagni: «Quello lo tiro io» esclamò con enfasi il Tenente. Il colpo partì e l’arabo fu steso al suolo: ma un quarto d’ora dopo il Tenente giaceva con la tempia forata.
Le salme di questi due nostri cari fratelli [Granafei e Solaroli] sono state raccolte, riposte in casse di zinco e di legno e tumulate nel camposanto cristiano di Tripoli con speciali segni da essere sicuramente rintracciate».
A Roma il re fregia della medaglia d’argento al valore militare lo stendardo dei Cavalleggeri di Lodi con la motivazione: «Per la splendida condotta del 1° e 2° Squadrone nel combattimento di Henni-Bu-Meliana». Al tenente Solaroli Paolo sarà conferita la medaglia d’oro al valore e al tenente Ugo Granafei di Serranova la medaglia d’argento con la seguente motivazione: «Perché comandò un plotone di Cavalleggeri appiedati incaricato di recarsi a sostenere le truppe in trincea fortemente impegnate: vinse la resistenza di orde di arabi ribelli appostati, raggiunto l’obiettivo prefissatogli sotto vivo fuoco di fucileria prese posizione e sostenne con fermezza ed ardire le altre truppe impegnate, sino al momento in cui fu colpito a morte» (Regio Decreto dell’8.11.1912). La madre del giovane eroe, la signora Iran d’Abro a perenne ricordo offrì la somma di lire 5.100, con rendita al 3,50%, con la quale fu istituita con Regio Decreto del 25 agosto 1913, n.1221 l’Ente Morale “Fondazione Granafei”.
Gli scopi della Fondazione consistevano nell’erogare una rendita in denaro ad uno o due soldati o caporali del 1° Squadrone del Reggimento Cavalleggeri di Firenze [nato dallo scioglimento del 15° Reggimento dei Cavalleggeri di Lodi] che durante il tempo trascorso sotto le armi si fossero distinti per moralità, disciplina, attaccamento al dovere, affetto al Reggimento o per atti di valore. L’amministrazione era affidata al Comandante del Reggimento, il quale vagliava anche l’erogazione dei benefici secondo un proprio criterio, mentre la data della premiazione era fissata al 26 ottobre, anniversario della morte del tenente Granafei. La mattina del 3 novembre 1911 la salma del giovane tenente giunse a Mesagne per essere tumulata nella cappella di famiglia. Sulla tomba una lapide riporta:
TENENTE DEI CAVALLEGGERI DI LODI
UGO GRANAFEI DEI MARCHESI DI SERRANOVA
NATO IL 22 SETTEMBRE 1878
MORTO SUL CAMPO DELL’ONORE IL 26 OTTOBRE 1911
In quell’occasione Mesagne tributò solenni esequie al suo eroico figlio, alle quali parteciparono tutte le Autorità civili e militari, l’intero paese, il generale Bovio e molte altre personalità giunte espressamente per rendere l’ultimo omaggio alla salma. Si ha notizia anche di una lapide commemorativa, offerta dalla cittadinanza, si ignora però il luogo ove fu posta, ne conosciamo però il testo:
26 OTTOBRE 1911
——–
SULLA TERRA AFRICANA
SOGNANTE EROE
A SIDI-MESSRI
– LIETO CADENDO –
IL MARCHESE TENENTE UGO GRANAFEI
CONTRO IL NUMERO E LA FEROCIA ARABA
VITTORIOSO
CO’ L’IMPETO DE’ SUOI DI “LODI” CAVALLERIA
IRRUPPE
——–
MESAGNE
AL FIGLIO
ORGOGLIOSA
Nel 1912 un gruppo di amici: Giovanni Antonucci, Francesco Morgese, Giovanni Profilo, Vincenzo Cavaliere, Federico Profilo, Giuseppe Capodieci (che ne sarà il futuro bibliotecario) darà vita alla Biblioteca Popolare che intitolerà al tenente Ugo Granafei [11]. Il 31 marzo del 1913 con una solenne cerimonia si tenne l’inaugurazione ufficiale della Biblioteca e la commemorazione dell’eroe caduto in battaglia [12]. Concludo con quanto ebbe a dire il generale Gustavo Fara, medaglia d’oro al valore, nel 1926, ottavo anniversario della Vittoria: «Glorioso e valoroso Cavalleggero caduto eroicamente combattendo il 26 ottobre del 1911, in una tragica alba nell’oasi di Tripoli».
[1] Sulla famiglia Granafei si veda: M.VINCI, Brevi cenni sulla famiglia Granafei, in: “Castrum Medianum”, a. I n.1 1988, pp. 31-42; IDEM, Una nobile famiglia salentina, i Granafei marchesi di Serranova, in “Lu Lampiune”, a. V n. 2 1989 pp. 65-76; IDEM, 1862 – Un processo per brigantaggio, in “Lu Lampiune”, a. V n.3 1989, pp.67-74; IDEM, Tra le masserie salentine… Castel Acquaro a Mesagne, in “Lu Lampiune”, a. VI n. 1 1990, pp. 121-128; IDEM, Il palazzo Granafei a Brindisi, in “Lu Lampiune”, a. VI n. 3 1990, pp.263-272.
[2] D’Abro Pagratide, antica e illustre famiglia armena, sovranamente riconosciuta nel 1892 nel titolo di principi, residenti in Napoli, cfr. F.BONAZZI, Famiglie nobili e titolate del napolitano, Napoli 1902.
[3] I. DEL SORDO, Il tenente Ugo Granafei solennemente commemorato a Mesagne, in: “La Tribuna”, 1 aprile 1913.
[4] ARCHIVIO STATO LECCE, Serie Ruoli Matricolari: Foglio Matricolare di Granafei Ugo, matr. 4174ter.
[5] Ministero della Difesa, D.G.U.E., Mod. 53 del tenente Ugo Granafei.
[6] Conservatoria dei RR.II. Lecce, Notar Taberini Raffaele, 10 agosto 1911, Atto di divisione eredi Granafei.
[7] M.VINCI, Spigolature sul castello di Mesagne nei secoli XVIII-XIX, in “Lu Lampiune”, a. VII n. 1 1991, pp. 245-253.
[8] D.TEMPERINO, I Cavalleggeri di Lodi 1859-1920, Tip. Vasesia, (NO), 1987; Il Reggimento dei Cavalleggeri di Lodi fu fondato ad Alessandria il 16 settembre del 1859.
[9] C.CICERONE, La terza colonia italiana – Cronista della guerra italo-turca; Roma 1913; S.BONO, La guerra di Libia, in “Storia e Dossier”, a. VI n. 54; L. MUNAFO’, La guerra politica giolittiana e la campagna di Libia, in “Atti del VII convegno di Studi sul Risorgimento in Puglia”, Bari 1991.
[10] Località alla periferia di Tripoli.
[11] P. IMPERATRICE, La Biblioteca Popolare Ugo Granafei a Mesagne, in “Rassegna Pugliese di Arti e Scienze”, a. 1913, p. 138.
[12] M. VINCI, In ricordo del tenente dei Cavalleggeri di Lodi Ugo Granafei (1878-1911),in “Lu Lampiune”, a. VIII n. 1 1992, pp. 263 – 275.
Anselmo Cosimo Leopardi (1915-1989)
di
Tranquillino Cavallo
Una delle pagine più importanti della storia carmelitana del XX secolo è senz’altro quella scritta da padre Anselmo Cosimo Leopardi. La storia semplice ed umile di un uomo di cui, purtroppo, ci si ricorda troppo tardi e che, invece, avrebbe meritato maggiori gratificazioni durante la sua vita. La nostra Mesagne, la sua città natale, ha fatto troppo poco ed ha scritto ancora meno per commemorare chi, con lo stile di vita e le opere, ha mantenuto alto il nome della terra natale. Figura di uomo molto forte, intelligente e sicuro di sé, non ha mai fatto mancare il suo aiuto ai più deboli, a tutti coloro che a Lui si rivolgevano per avere una parola di conforto ed un aiuto materiale. Dotato di una personalità poliedrica, che intravedi solo se la avvicini e ti fermi a ripulirla delle scorie, come un diamante, Padre Anselmo ha un suo fascino particolare, tanto più attraente quanto più sfuggente. Unisce l’austerità del tratto all’apertura verso ogni modernità sana; la rigida riservatezza del frate all’audacia dell’imprenditore; lo spirito contemplativo ed orante del cenobita alla frenesia del propagandista; la tenacia del minatore all’arditezza dell’architetto. Sul piano operativo, le lunghe e silenziose riflessioni esplodevano talvolta in decisioni imprevedibili ed irremovibili.
Personalmente l’ho conosciuto nel 1977, durante una visita alla Casa Provincializia di Bari, quando fui immediatamente colpito dalla sua personalità, forte e sicura, dalla disponibilità all’ascolto e dalla generosità nei consigli. Padre Anselmo nacque il 30 settembre 1915 a Mesagne, da una famiglia profondamente cattolica, contadina e molto laboriosa, simile in ciò alla grande maggioranza delle famiglie della nostra terra in quel tempo. La laboriosità e la resistenza alla fatica della nostra popolazione, allora generalmente e dignitosamente molto povera, erano da sempre un’esigenza per sopravvivere. Perciò, in ogni famiglia, la regola fondamentale era, per tutti i suoi membri atti a qualche attività, guadagnarsi il “pane”. Cosa non facile, specialmente quando le braccia atte al duro lavoro della terra erano poche e le bocche da sfamare erano molte, come avveniva nella famiglia di Emanuele Leopardi, conosciuto a Mesagne come “Manuele d’Aronne”. La moglie, Maria Vincenza Capodieci, più giovane di lui di otto anni, lo aiutava come poteva, date le sue frequenti maternità ed i molti problemi da cui erano abitualmente accompagnate. I suoi figli, Eugenio, Angelo, Maria Addolorata, Maria, Luigi e Antonio, per quanto volenterosi, erano poco più che una speranza per l’avvenire della famiglia.
In questa cornice di laboriosità e di povertà, senza fiocchi alle porte, senza partecipazioni e senza lettere di felicitazioni, nacque il settimo figlio di Emanuele. Allora i figli erano numerosi in quasi tutte le famiglie e la loro nascita era un avvenimento importante, ma strettamente familiare. Fra i parenti, in genere, ne erano preavvisati solo quelli che i genitori del nascituro avevano già designato come padrini. A volte i compaesani erano messi al corrente dell’evento dai vicini di casa con una formula basata sull’abitudine di battezzare i figli il più presto possibile. In una cornice di festa della natura, ma nel silenzio discreto e sereno che è caratteristico della gente umile, al piccolo fu amministrato il sacramento del battesimo ed imposto il nome di Cosimo. Crescendo Cosimo diventò un ragazzo semplice, spontaneo e tale restò per tutta la vita anche se, nell’età matura, diede spesso l’impressione di essere un diplomatico consumato. Sentiva intimamente che era un suo dovere assecondare la chiamata di Dio che considerava come sicura e consacrarsi per intero alla famiglia che il Signore gli aveva dato. Fu così che nell’ottobre 1928 il padre Emanuele presentò la dovuta domanda al rettore del vicino Seminario Carmelitano di Mesagne, accompagnando personalmente il figliolo e verificando da vicino i luoghi in cui avrebbe studiato, pregato, mangiato e giocato. Frequentò il Ginnasio interno al Seminario e si distinse per i profitti ottenuti nello studio, per la serietà profusa nello studio di tutte le discipline, per l’osservanza dell’orario e della disciplina e per il rispetto portato verso i maestri. Era amato da tutti per il suo volto sempre sereno e gioviale, per il suo comportamento composto e dignitoso.
Fin da quell’età, per lui, contavano solo le competizioni dello spirito, fondate sull’intelligenza, sulla forza del ragionamento, sull’audacia e l’intraprendenza e per esse lottava per raggiungere il primo posto. Le gare basate sull’agilità, sulla velocità o sulla capacità di colpire la palla, non erano fatte per lui. Come tutti i seminaristi, Cosimo trascorreva in famiglia le vacanze estive e quando arrivava a casa con la tonaca e la gravità del frate autentico, i famigliari lo trattavano con lo stesso rispetto che riservavano a tutti i sacerdoti. Erano contenti che partecipasse ai lavori agricoli che, nei mesi estivi, sono intensi, ma erano altrettanto lieti che una parte del suo tempo lo dedicasse allo studio ed alle preghiere. Le vacanze erano per lui un riposo più simbolico che reale e possiamo ragionevolmente supporre che approfittasse di quel tempo, specialmente negli ultimi anni di teologia, per prepararsi alla predicazione. Nel 1932 trascorse l’anno di noviziato in Sicilia, a Barcellona Pozzo di Gotto, e il 3 ottobre 1933 emise la prima professione religiosa. Nel suo ingresso in noviziato osservò il costume di cambiare nome, come segno dell’inizio di una nuova vita. Scelse il nome di Anselmo. Successivamente si recò a Roma, presso il Collegio Internazionale Pio XI per frequentare il corso filosofico. Nel momento in cui incominciò lo studio della filosofia e delle Sacre Scritture, il diciottenne frate Anselmo cessò praticamente di essere giovane, nel senso che tanto il suo comportamento esteriore quanto i suoi pensieri ed i suoi discorsi furono quelli dell’uomo maturo, di chi si è dato una regola di vita, scegliendo la strada da percorrere tenacemente e senza tentennamenti.
Nel 1936 rientrò, per motivi di salute, nella propria Provincia Religiosa ed in un clima molto disteso terminò gli studi presso l’Istituto Teologico dei Padri Francescani di Taranto. Qui, il 4 ottobre 1936, ricevette l’ordine del diaconato in una cerimonia umile ed intensa. Il 9 ottobre 1938, a soli 23 anni, ricevette l’ordinazione sacerdotale dal vescovo di Taranto, nella chiesa del SS. Crocifisso. Fu nominato vice – parroco della parrocchia del SS. Crocifisso, gestita dai padri Carmelitani, e ricoprì tale incarico fino al 1941, anno in cui fu trasferito presso il Santuario di Palmi, in Calabria, dove rimase per sei anni. Negli anni del secondo conflitto mondiale fu impegnato, in qualità di cappellano della Gioventù del Littorio, a prestare aiuto ai bisognosi. In quel periodo guidò con diligenza e competenza il gruppo giovanile della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI). Fu, dall’estate del 1943, custode e garante della cittadina di Palmi, i cui abitanti, impauriti dai bombardamenti effettuati dalle truppe alleate durante l’avanzata verso Roma, si erano rifugiati nelle campagne e nelle grandi gallerie ferroviarie costruite dall’ex stato fascista. La cittadina di Palmi, semi distrutta dai bombardamenti ed in preda ad uno spietato sciacallaggio da parte delle truppe nazifasciste in fuga, si salvò in parte grazie alle eroiche gesta di padre Anselmo e dei giovani della FUCI. Non mancavano gli orfani bisognosi di aiuto, poiché la guerra aveva preteso subito le sue vittime. A fine conflitto, la popolazione di Palmi non lesinò a padre Anselmo e ai giovani della FUCI pubbliche dimostrazioni di gratitudine.
Successivamente fu inviato dai suoi superiori a dirigere il convento di S. Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli. Vi rimase undici anni ed anche nella nuova comunità si fece apprezzare per le sue doti umane e di grande oratore. Grazie alla vicinanza della Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” e al grande Archivio di Stato di Napoli, divenne ricercatore e studioso di storia patria, con particolare riguardo alla vicende della sua Mesagne. Assegnato alla comunità religiosa della Casa Provincializia di Bari, prestò servizio per 15 anni, come cappellano militare, nel carcere del capoluogo, aiutato in ciò dalla sua forte personalità autenticamente umana, e gestendo oltre tremila reclusi, sui settecento previsti dal regolamento penitenziario, guadagnandosi subito la fiducia dei detenuti. L’impegno di cappellano militare fu un capitolo molto significativo della sua vita, una pietra miliare, a cui faceva riferimento per trarre nuova forza e nuovi stimoli per il suo ministero pastorale. L’esperienza acquisita da padre Anselmo si manifestò durante due ammutinamenti avvenuti nel carcere, durante la direzione del dott. Azzariti, quando, grazie alla sua forte e coraggiosa opera di mediazione, furono evitati gravi disordini tra i detenuti e le forze dell’ordine. Per quest’azione lo Stato gli conferì una medaglia di bronzo e, successivamente, una d’argento al valore civile. Continuò con immutato impegno ed identica umiltà il suo lavoro di promozione umana a favore dei reclusi e la dedizione a questa causa lo portò ad essere nominato cappellano capo di tutte le carceri di Puglia. Con questo compito di coordinatore, offrì ai colleghi cappellani la sua esperienza umana e l’immancabile amicizia.
Nel 1955 prese parte ad un congresso di Penitenzialisti Cattolici, durante il quale propose, ottenendoli sia l’abolizione della casacca a strisce indossata dalle donne recluse che il diritto di tenere in cella uno specchietto ed alcuni cosmetici per la cura personale del viso. Si batté, inoltre, per l’abolizione della palla al piede dei detenuti, ritenendola un inutile fardello di pena ed altamente lesivo della dignità umana. Esempi dell’umanità di padre Anselmo ci sono forniti dall’interessamento che ebbe per le vicende umane vissute da due reclusi. Il primo, professore e comunista aveva tentato, dopo la liberazione alleata dell’Italia meridionale, di costituire una repubblica rossa a Caulonia, mentre il secondo era stato comandante della guardia personale di Mussolini durante i giorni della Repubblica di Salò e per questo dapprima condannato a morte dal Tribunale del Popolo e successivamente a trent’anni di reclusione. Per questi uomini padre Anselmo inviò al Ministro di Grazia e Giustizia istanza di grazia, poi concessa. Negli anni Settanta, sempre a Bari, si fece apprezzare dai padri Domenicani e benché già anziano si iscrisse alla facoltà di Teologia Ecumenica, conseguendo, dopo quattro anni di intensi studi, la laurea con il massimo dei voti, ed ottenendo le congratulazioni dei professori e la pubblicazione della tesi. Fu successivamente chiamato a S. Fara, sempre a Bari, presso lo Studio Teologico Interreligioso Pugliese, ad insegnare ecumenismo. Nonostante l’impegno, trovò il tempo per dedicarsi allo studio storiografico, divenuto per lui una vera “vocazione”. Si interessò in particolare della sua Mesagne, e il frutto del suo studio è nelle seguenti pubblicazioni:
- Il più bel fiore della creazione, Bari 1945;
- Masaniello, Napoli 1972;
- Il Conciliarismo – Genesi e Sviluppo -, Bari 1978;
- Gian Francesco Maia Materdona, Bari 1978;
- L’accademia degli Affumicati, Bari 1978;
- Mesagnos: una città in mezzo alle vore?, Bari 1979;
- Il monastero di S. Maria della Luce, Bari 1979;
- Il Carmine nella realtà mesagnese, Bari 1979;
- Universitas e feudatari, Bari 1980.
Egli si distinse in questi suoi scritti oltre che per lo stile, anche per un’insolita sobria ricercatezza dei termini e per la potenza narrativa. Queste doti furono acquisite dopo una lunga maturazione quando cominciarono a prendere corpo in lui le linee essenziali della storia che egli portava in sé, in quanto scaturite dal continuo e prolungato contatto con un’enorme quantità di fonti che articolò in una serie di coerenti tesi. Nel 1981 fece ritorno a Palmi, in Calabria, dove rivestì la carica di priore. Nel convento della città calabrese guidò il Terz’ordine Carmelitano, istituì una scuola materna privata e realizzò un piccolo museo, oggi scomparso, che arricchì di pregevoli opere in bronzo. Nello stesso periodo fece realizzare due leoni di bronzo raffiguranti il Terremoto e la Fiducia del popolo nella protezione della Madonna, due sintesi storiche in bronzo ai lati del portico della facciata della chiesa. Insegnò Teologia, Ecumenismo e Patristica presso l’istituto di Scienze Religiose “Giovanni XXIII” di Palmi. Continuò anche in Calabria la sua produzione storico-letteraria e allargò gli studi all’Ordine Carmelitano presente in Calabria, in particolare a Palmi. Padre Anselmo si sentì totalmente immerso e coinvolto nella cultura calabrese che, come risulta dai suoi lavori, dimostrò di conoscere molto bene e di stimare profondamente. Sono di questo periodo le seguenti opere:
- Robertus dux fecit castrum in Meiana, Bari 1981;
- Mesagne, città dalle cinquanta chiese, Bari 1982;
- Calabria, radici culturali e religiose, Bari 1983;
- Lineamenti del monachesimo bizantino, Bari 1985;
- I Carmelitani di Calabria, Palmi 1987;
- Novembre 1894: il Carmine di Palmi al centro di un evento storico, Polistena 1988;
Conoscitore del rigore imposto dalla ricerca storica, padre Anselmo non si accontenta di riportare quanto da altri detto, ma verifica, controlla, prende contatto diretto con il documento storico in modo da fornire prove il più possibile sicure e certe delle sue affermazioni. Le sue ricostruzioni risentono della tipica preoccupazione dei ricercatori, che sommamente rispettosi della realtà che trattano, non cedono alla strumentalizzazione o all’apologetica. Per meriti acquisiti in campo culturale e diocesano ricevette a Palmi, dal vescovo Mons. Benigno Luigi Papa, il titolo onorifico di canonico della cattedrale di Oppido-Mamertina. I titoli e i riconoscimenti conseguiti nel corso della sua vita furono:
- Specialista in Paleografia e diplomatica;
- Premio Culturale della Presidenza dei Ministri;
- Cavaliere del Merito della Repubblica;
- Medaglia d’oro al Valore della Redenzione Sociale, datata 8/9/81 (questa medaglia padre Anselmo desiderava donarla, alla sua morte, al Comune di Mesagne, volontà confidata a padre Carmelo Vitrugno);
- Legione d’Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto;
- Commendatore dell’Ordine Militare del SS. Salvatore;
- Accademico Teatino e Tiberino;
- Presidente onorario dell’associazione Pro Loco di Mesagne;
- Cappellano d’onore dell’Ass. Reduci e Combattenti di Ostia.
Nel mese di dicembre del 1988 celebrò a Palmi il 50° anniversario del suo sacerdozio, alla presenza del Vescovo della Diocesi di Oppido-Mamertina, mons. Benigno Luigi Papa, del Provinciale dell’Ordine Carmelitano per la Provinciale Napoletana, il maestro reverendo padre Lucio Renna, e di numerosi confratelli ed autorità civili e militari. Alla liturgia furono presenti alcuni parenti, i rappresentanti ufficiali del Comune di Mesagne, molti amici e conoscenti delle comunità carmelitane di Mesagne e Torre S. Susanna, oltre a numerosi fedeli calabresi, i quali portarono personalmente l’attestato di amore al comune fratello. Purtroppo nei primi mesi del 1989 lo stato di salute di padre Anselmo cambiò improvvisamente, la sua robusta fibra fu minata da una grave spossatezza e fu costretto a ricorrere alle cure mediche. Al precipitare improvviso delle sue condizioni di salute, i suoi superiori disposero l’immediato trasferimento a Bari, presso l’Ospedale Cotugno. Dagli esami emerse la gravità del male. Fu, allora, trasferito presso il reparto oncologico dello stesso nosocomio, dove fu tentato il possibile per salvarlo. Furono consultati anche professori romani e americani, ma anche costoro confermarono l’infausta diagnosi. Da quel momento in poi, la costernazione invase gli animi dei confratelli, dei parenti e degli amici; il più sereno di tutti sembrò essere lo stesso padre Anselmo, che nel suo letto di dolore consumò il proprio sacrificio serenamente, mentre in ogni comunità carmelitana fu intensificata la preghiera per un confratello di tale valore. Lasciò la vita terrena, addormentandosi nel Signore, il 15 luglio 1989, vigilia della festività della Madonna del Carmine. Il 17 luglio 1989 le sue spoglie mortali giunsero a Mesagne per essere tumulate nella cappella cimiteriale dei padri carmelitani. Il suo loculo è contrassegnato da una semplice epigrafe: Padre Anselmo / Cosimo Leopardi / 30/9/1915 – 15/7/1989.
La vita di padre Anselmo Cosimo Leopardi è piena di avvenimenti e tappe importanti ed avrebbe sicuramente fatto carriera nell’Ordine Carmelitano se solo lo avesse voluto, seguendo le orme di un suo antenato vissuto nel XVIII secolo, padre Mauro Leopardi, divenuto padre Generale dell’Ordine dei Celestini. Padre Anselmo volle, invece, rimanere tra la gente comune, tra gli emarginati, tra gli ultimi, tra coloro che ebbero maggiormente bisogno della sua azione pastorale di evangelizzazione e promozione umana. Fu un uomo che seppe integrare la preghiera e l’azione ed in lui fu forte la duplice spiritualità del lavoro e della comunione. Da uomo instancabile seppe, all’occorrenza, indossare gli abiti del lavoro manuale, realizzando opere per il bene dei fratelli. Attorno a lui ci si raccolse con fraterno affetto. Padre Anselmo, infatti, seppe creare ovunque un clima di cordialità e rispetto, passando con estrema naturalezza dal tono affabile di amico a quello di maestro e uomo di sapienza. Fu sempre disponibile al dialogo e valorizzò con acume e attenzione i carismi personali di tutti coloro che gli furono accanto. L’attività più amata da padre Anselmo Cosimo Leopardi fu la predicazione. La sua parola facile e vibrante creò sempre grande emozione e affascinò gli ascoltatori. Fu spesso invitato in molte parrocchie a tenere omelie, panegirici e prediche di occasione. Ebbe senza dubbio le doti per essere un grande oratore e il fondamento principale della sua efficacia fu la sua stessa la sua vita, perché in essa tutti videro la conferma continua di quello che insegnò; a questo fondamento si unì l’accento di profonda convinzione che portò sempre la sua parola. Nelle sue prediche fu facilmente rilevabile la sua forte passionalità e fu solito abbondare di riferimenti polemici che accompagnò sempre con un alto tono della voce.
Soggetto delle sue predicazioni fu la Madonna, da lui tanto amata, al punto che le sue parole ed i suoi scritti risentirono di questo entusiastico legame d’amore che diede grazia e bellezza a tutte le sue pubblicazioni. Padre Anselmo non fu solo uno storico e un letterato ma anche un artista, nel cuore e nelle opere. Molti dei conventi carmelitani, dove egli visse, conservano un segno della sua predilezione mariana; prova ne sono, infatti, le varie tele raffiguranti la Vergine, ma più ancora il desiderio di sentire Maria presente nella storia quotidiana a guida e riferimento del suo popolo. Questo desiderio fu espresso attraverso l’erezione di varie statue mariane nelle piazze parrocchiali. Queste statue ci comunicano ancora oggi i sentimenti del suo cuore: come quella di Palmi che, ergendosi sull’umanità, con un tenero abbraccio sostiene il figlio (l’immagine della donna calabrese denota un’attenta lettura della vita e delle tradizioni locali) che dona insieme allo scapolare, come “segno di protezione”; o come quella di S. Giovanni a Teduccio (Na) che dall’alto domina la comunità parrocchiale, ai cui piedi i suoi figli si raccolgono in preghiera ogni anno. Anche la comunità carmelitana di Mesagne ha, nelle sue sale parrocchiali, una grande tela devozionale raffigurante la Vergine che stringe tra le braccia, con gesto di amore materno, il Bambino. Da buon mesagnese, padre Anselmo Cosimo Leopardi, coltivò questo vincolo profondo con la Vergine, ispiratrice di vita. [1]
[1] Per un approfondimento su padre Anselmo Cosimo Leopardi si rinvia a:
CAVALLO T., Padre Anselmo Cosimo Leopardo, Mesagne 1993;
EPISCOPO I., Padre Anselmo Leopardi, dattiloscritto, Mesagne 1989;
FILOMENA E., Padre Anselmo Cosimo Leopardi, in “Lu Lampiune”, Lecce 1989.
Cataldantonio Mannarino (1568-1621)
di
Mario Vinci
«E’ strano che i più che di lui si sono occupati non sono andati oltre il ricordo della città che gli diede i natali» [1]; così Angelo Galeone, in un suo articolo sul Mannarino, sottolineava la scarsità di notizie su questo illustre letterato e dotto medico tarantino.
“Consummatissimus medicus”, ebbe a definirlo Epifanio Ferdinando il vecchio, con il quale Catald’Antonio Mannarino collaborò alla soluzione di alcuni casi medici e per il quale scrisse la prefazione al libro Centum historiae, seu observationes et casus medici [2]. Catald’Antonio Mannarino, di Domenico, nacque a Taranto nel 1568. Trasferitosi giovanissimo a Mesagne, “qui fu educato” (dice Antonio Profilo nel libro Vie, piazze, vichi e corti di Mesagne) e nel 1592, sposò la nobile Porfida de Russis di Jacobo [3], dalla quale ebbe diversi figli, tra cui si distinsero: Ermanno, predicatore dell’Ordine dei Celestini, e Bonaventura, maestro dell’Ordine dei Domenicani [4]. A Mesagne dovette certamente dimorare per molti anni, dato che si dimostrò un attento conoscitore della sua storia. Al Mannarino, infatti, è attribuito un importante manoscritto conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli (XIV – G.18/2) dal titolo Memorie storiche su Mesagne.
L’opera in questione risulta mutila in quanto doveva comporsi con molta probabilità di almeno tre libri, come indicato dallo stesso autore nel libro I° alla carta 31v.; noi ne conosciamo solo il primo. Antonio Profilo [5] la data al 1592, altri [6] al 1595, ma, come segnalato in un recente lavoro [7], riteniamo più esatto datarla al 1596. Scrive infatti il Mannarino, alla carta 27r., in riferimento a Giovanni Antonio Albricci I: «Il titolo di oggi è di Marchesato di Salice, cinque anni sono posseduto per merito di serviggi resi […]»; e sappiamo che quel titolo fu conferito all’Albricci da Filippo II con diploma del 16 ottobre del 1591 a mezzo del Viceré don Iuan de Zuin. Dopo la morte della moglie, avvenuta intorno all’anno 1615, si fece prete e ottenne le insegne corali della Collegiata di Mesagne. Il dolore per la perdita dell’amata consorte rimase vivo nel poeta che chiese al suo amico e pittore rinomato Giampietro Zullo di dipingere il ritratto della sua Porfida, con il sonetto: «Zulli gentil, deh quel pinnel più fino, / ch’emulo di Natura i Morti avviva, / opra per me, acciò non resti priva / mia vita di quel volto almo e divino […]» [8].
Zullo ringraziò il poeta per il sonetto di lode, ma non realizzò il lavoro commissionato, tanto che il Mannarino con un altro sonetto tornò a pregarlo di dipingere quell’immagine: «Zulli, tu tardi ancor ? pingi, favella / né muti lini, e fa col tuo colore / che nasca a gli occhi miei due volte Amore […]». Morì il 28 luglio 1621.In quegli anni di pieno fermento per il mondo letterario e soprattutto scientifico, con l’apertura di nuovi orizzonti per la medicina, la botanica, la fisica, anche il Mannarino come il Ferdinando, contribuì nella medicina e nelle lettere [9]. Diamo, di seguito, un elenco non completo delle opere del Mannarino:
- Glorie di guerrieri e d’amanti in nuova impresa nella città di Taranto succedute. Poema heroico. Napoli, Gio. Giac. Carlino & Antonio Pace, 1596. In quarto. [In questo libro è inserito anche l’opuscolo Oligantea delle lodi di Alberto d’Acquaviva e datato Napoli 1596].
- Canzone al cardinale Gesualdo nel suo possesso all’arcivescovado di Napoli. Napoli, G. C. Carlino & A. Pace, 1596
- Memorie storiche su Mesagne, ms. 1596.
- Il Pastor Costante. Favola boschereccia. Bari, Giulio Cesare Ventura, 1605. In ottavo.
- Apologia in risposta del parere pubblicato sotto il nome Giambattista Leoni sopra il pastor Costante. Napoli, G.B. Sottile 1608.
- L’Erminia. Favola boschereccia. Venezia, Bernardo Giunti & Gio.Battista Ciotti, 1610. In-12°.
- Susanna, tragedia sacra, con quattro intermedi dell’historia di Susanna hebrea. Venezia, Bernardo Giunti & G. B. Ciotti, 1610
- Rime. Napoli, Tarquinio Longo, 1617 (colophon 1618). In quarto. (Quasi sicuramente questo libro è da identificarsi con il Rithmorum liber citato dal Villani in Scrittori ed artisti pugliesi).
Mesagne lo ricorda soprattutto per le Memorie patrie tramandateci. Di seguito diamo la trascrizione degli argomenti trattati nei singoli capitoli del manoscritto: il Libro I, mutilo di alcune carte, inizia dalla 18, in cui l’autore tratta della famiglia Beltrano feudataria di Mesagne, con ampi cenni genealogici:
Capo 6°: Del signor Gio:Antonio Albricci, ultimo suo signore, e suoi meriti. Ove del principe si tratta.
Capo 7°: Del sito universale e suoi confini.
Capo 8°: Del sito particolare ove la figura si vede di Misagne. Questo capitolo è degno di particolare nota perché il Mannarino vi esterna tutto il suo amore per la città di Mesagne, dicendo fra l’altro: “E quindi è ch’à caso per le diffigurate forme antiche / primieri siti hoggi una città rassembra la figura d’una nave / come la mia città di Taranto, un’altra una padella come la / città di Gallipoli, un’altra d’una testa cervo, come la città / di Brindisi, un’altra d’un arco come la città di Bari, un’altra / un’altra d’un arco, come la città di Napoli, et un’altra, tra mille, che / traccio d’un cuore humano, come questa nobilissima Terra di / Misagne ne senza ragione ritiene la forma d’un nobile cuore / questa leggiadra patria,perché così come il cuore risiede / nel mezzo del suo corpo, come membro più perfetto, così Misagne / risiede nel mezzo di questa provincia, come patria più nobile […]
Capo 9°: Dell’artificio e fortezza del castello, e sua torre.
Capo 10°: De giardeni più vaghi.
Capo 11°: De Sacri Tempij e luoghi pij [In questo capitolo l’autore descrive le chiese esistenti in Mesagne nel 1596; se ne contavano ben 33: «La maggior Chiesa sotto il titolo della festività di tutti i Santi, il tempio di San Bartolomeo, il monastero delle reverende monache osservanti Cappuccine, San Nicola, San Salvatore, Santa Maria della Greca, Santa Caterina, San Blasi, San Giovanni, San Cosmo, San Sebastiano, San Martino, il tempio di San Francesco dei frati minori conventuali, il tempio di S.Angelo (odierna Chiesa del Carmine) il tempio della SS.Annunziata, il tempio della Madonna di Stigliano, il tempio della Madonna della Grazia, il tempio della Misericordia, il tempio antichissimo di San Lorenzo, Sant’Antonio di Bienna, San Rocco, San Leonardo, San Vito, Sant’Andrea a Musano (di questa chiesa il Mannarino dice di aver parlato diffusamente nel cap. 2°, andato poi smarrito), San Paulo, San Vito discosto dalle mura, San Petito, Sant’Angelo (all’Ulfo), San Benedetto, San Nicola di Mulignano (ne parla diffusamente nel cap. 2°, andato purtroppo smarrito), Sant’Antonio di Padova, Santa Maria delle Vergini].
Capo 12°: D’alcune divotissime Reliquie.
Il manoscritto si interrompe alla carta 80; si segnala, inoltre, che su molte carte sono stati apposti degli appunti posteriori alla stesura originale del testo.
[1] A. GALEONE, Un medico poeta tarantino del seicento, in «Taranto», a. IV (1935), pp. 3-11.
[2] E.FERDINANDO, Centum historiae, seu observationes et casus medici, Venezia, Thomas Ballionus, 1621.
[3] ARCHIVIO DI STATO DI BRINDISI, Fondo Notarile di Mesagne, notar Cesare Guarini, a.1592, cc.58-70; i capitoli matrimoniali tra il magnifico Jacobo de Russis e Catald’Antonio Mannarino furono rogati dal notar Philippi Jacobi Taccari della città di Taranto nel 1592.
[4] A. PROFILO, Vie, piazze, vichi e corti di Mesagne, Ostuni 1894, pp. 208-13, n. ed. a c. di D. Urgesi, Fasano 1993.
[5] Ivi, p.15.
[6] G. GIORDANO e D.A. LEUCCI, La datazione della “Storia di Mesagne” ms. di C. A. Mannarino, in “Castrum Medianum”, n. 5 (1991-92), pp.39-45.
[7] D. URGESI, Annotazioni bibliografiche e documentarie, in A. PROFILO, op. cit., p.382.
[8] A. GAMBACORTA, Giampietro Zullo pittore di Mesagne (1557-1619), in «Almanacco Salentino», a. 1972, pp.255-60.
[9] D. E. RHODES, Un illustre letterato di Taranto: Catald’Antonio Mannarino, in «La Zagaglia», a.1973, n.59, pp.19-26.
Antonio Mavaro (1725-1812)
di
Mario Vinci
Da un’agiata famiglia originaria di Salice, Antonio Mavaro nacque nel 1725 [1] a Mesagne, dove si era stabilita nei primi anni del XVII secolo. Figlio di Rocco ed Anna Martucci, Antonio compì gli studi giuridici in Napoli, come anche il fratello Giuseppe Maria e ritornato a Mesagne si dedicò ad amministrare l’ingente patrimonio familiare, non trascurando la vita amministrativa e politica della città. Il fratello Giuseppe ricoprì nel 1767 la carica di Sindaco dei nobili (come annota Antonio nella Messapografia) e fu delegato presso il Regio Consiglio in Napoli a rappresentare e tutelare i diritti dei propri concittadini nella causa contro il marchese Giuseppe Barretta feudatario di Mesagne. Antonio esercitò con prestigio la professione forense, fu Giudice della Principal Corte nella città di Molfetta [2], come egli stesso dichiara in un atto di procura stipulato dal notaio Sergio Maggialletti il 5 luglio del 1762. Il 25 marzo del 1764 sposò la nobile Giusepp’Angela Miccoli di Putignano [3] e dal loro matrimonio nacquero i figli Rocco, Vincenzo, Stella ed Emilia.
Come accennato, egli non fu solo un valido uomo di legge ma anche un attento studioso e profondo conoscitore della storia ed un appassionato archeologo. Raccolse e conservò molti reperti archeologici rivenienti da sporadici ritrovamenti in paese, ma soprattutto, con molta probabilitàà, dalle località archeologiche oggi ben conosciute di Muro-Tenente e Campofreddo, masserie di proprietà della famiglia. Raccolse, inoltre, in volumi, ai quali diede lui stesso il titolo di “Responsa prudentium”, scritture, allegazioni, controversie e documenti riguardanti l’Università di Mesagne ed i vari feudatari che si erano succeduti nel corso degli anni. Tradusse dal latino la Messapografia di Epifanio Ferdinando seniore, arricchendola di varie notizie posteriori alla morte dell’autore, sino al 1794. Inoltre riportò in appendice tutti gli avvenimenti, ricchi di particolari, che caratterizzarono il Regno di Napoli durante la rivoluzione del 1799, perché vissuti da testimone. Fortunatamente questo voluminoso manoscritto non andò disperso come tutte le altre carte e reperti raccolti e gelosamente custoditi,. Nel testamento, infatti, il Mavaro dice: “E’ mia ferma volontà che la mia libreria esistente nel mio studio, con alcuni vasi antichi, e tutt’altro che ivi trovasi resti di conto di detto Vincenzo mio figlio”.
Purtroppo, dalla morte del figlio Vincenzo (arcidiacono della Chiesa Matrice di Mesagne), avvenuta nel 1830, non vi è più nessuna traccia dei documenti né tantomeno dei vecchi libri o dei reperti archeologici. Si potrebbe supporre che furono venduti o donati (alcuni di quei documenti potrebbero essere stati donati all’Archivio Capitolare). L’avvocato Antonio Profilo [4] scrisse che molti di quei documenti inerenti l’Università furono da lui consultati, pertanto è da ritenere che sul finire dell’Ottocento quei documenti fossero ancora esistenti, sicuramente presso qualche famiglia (com’è avvenuto per la Messapografia, che era presso qualche famiglia mesagnese e solo qualche anno addietro fu donata alla Biblioteca Arcivescovile “De Leo” di Brindisi). Baldassarre Papadia nel diario del suo viaggio, compiuto nel 1791 nell’alto Salento [5], scrisse del Mavaro: “fortunatamente conobbi il dottor d. Antonio Mavaro che gentile e pulito mi fece osservare i monumenti che ha raccolto attinenti ad illustrare la storia della patria. Mi lesse qualche pezzo della traduzione da lui fatta della Messapografia del celebre Epifanio Ferdinando che la scrisse in latino secondo il gusto dei suoi tempi. E’ il signor Mavaro ancora raccoglitore d’antiche monete, vasi ed antiche lapidi che gelosamente conserva”.
Nel 1804 la sua collezione fu visionata dal generale della truppa cisalpina Giuseppe Lechi. Antonio Mavaro si spense a Mesagne, oramai avanti negli anni, il 21 luglio 1812 e con lui scomparirono molte pagine importanti della nostra storia che diligentemente e gelosamente aveva per molti anni custodito. Dei figli di Antonio Mavaro, Vincenzo fu arcidiacono della Collegiata di Mesagne e morì nel 1830, Rocco nel 1783 sposò Saveria Nasuti, di agiata famiglia originaria di Manduria. Delle altre due figlie di Antonio, Stella sposò il nobile galatinese Francesco Tanza nel 1803, Emilia invece sposò a Fasano donato Marzolla. L’abitazione del Mavaro è da identificare con le case site alla Via Generale Falcone, comprese tra i numeri civici 33 e 43, come già dimostrato in un nostro precedente lavoro [6], ove si è avuto modo di mettere a confronto diversi documenti che hanno permesso di identificare in quei fabbricati l’antico e settecentesco palazzo Mavaro. Di seguito si trascrive l’indice dell’opera del Mavaro La Messapografia suddivisa in due libri:
Libro I
Prefazione – Avvertimento – De diversi nomi della Provincia presso gli antichi e perché fu chiamata pria Lucezia – Dell’altra denominazione detta Japigia – Dell’altra denominazione data a questa Regione di Messapia: di Messapo e della città della Messapia – Ove si fa parola della lingua e lettere Messape – Si esamina qual fosse stata la Polizia, e la forma di Governo di Messapia (Mesagne) dopo il dominio monarchico e quali fossero le guerre, nelle quali li Messapi ebbero parte – Se li Messapi e salentini sieno stati tra loro diversi o pure una sola popolazione chiamata mescolatamente Messapia e Salentina ? – Che la presente città di Mesagne abbia avute varie denominazioni e della di lei antica estensione – Se l’antica Messapia sia stata più antica di Brindisi – Chi sia stato il fondatore di Brindisi non essendo stato Ganez figlio di Jafet ne Brento figlio di Nettuno – Si dimostra che li Cretesi fondarono Brindisi – Chi sia stato il vero fondatore di Brindisi – D’Oria città montuosa dè salentini e delle sue varie denominazioni – Se per l’Iria della quale parla Erodoto debba sentirsi Oria posta sopra un colle – Del fondatore di Taranto – D’Otranto, Taranto, Mesagne, Lupia, Rudia, Brindisi ed Oria quali mai di queste città furono le prime state fondate e più antiche ? – L’antichità di Mesagne apparisce da sepolcri, dalle monete e d’altre antichità – De vari epitaffi ed iscrizioni degli Imperatori romani e uomini illustri esistenti in Mesagne – La stessa antichità della presente Mesagne rilevasi dalle antiche famiglie – De vari Casali a Mesagne sottoposti – Delle varie magnificenze – Dignità, e privilegi della città di Mesagne – Degli uomini illustri che fiorirono in Mesagne e in tempi susseguenti e, vivente l’Autore – Delle doppie Mura di Mesagne e delle di lei torri, Porte, Giardini; fondazione del Convento del Carmine; dei PP. Francescani; dei PP. Domenicani; dei PP. Cappuccini; dei PP. Riformati; del Monastero dei PP. Celestini; delle Monache Cappuccine; del Convento dei PP. Minimi; dell’Insigne Collegiata e Capitolo della stessa; del Monte dei Poveri; dello Spedale; della Cappella di S.Lorenzo; della Misericordia; di Mater Domini; di S. Antonio de Padova; di S.Leonardo; del Crocifisso; dei SS. Cosma e Damiano.
Libro II
Prefazione – Del clima Messapo e qual sia la perfetta ed ottima aria – Della grandissima necessità dell’aria e della di lei utilitate – dell’eccellenza del clima Messapo – Della fortezza o sia castello di Mesagne – Mesagne dall’Imperatore Carlo V viene concessa a Luigi Carroz de Villargut – Mesagne dall’Imperatore Carlo V viene venduta ad Alfonso Beltrani – Mesagne passa all’utile dominio della famiglia Albricci – Mesagne passa all’utile dominio della famiglia De Angelis – Mesagne passa all’utile dominio della famiglia Barretta – Mesagne passa all’utile dominio della famiglia Imperiali – Note e documenti vari e riguardanti il periodo dal 1794 al 1799.
[1] Il dato viene confermato dal Catasto Onciario di Mesagne del 1753, presso l’Archivio di Stato di Brindisi, che riporta:
- Ill.mo D. Antonio Mavaro dottore in leggi (anni 28)
- D. Giuseppe Maria fratello (anni 25)
- Donna Anna Martucci madre (anni 60)
- D. Bartolomeo Mavaro canonico zio (anni 60)
- Leonarda Tarantino della Vetrana serva (anni 50)
- Bartolomeo Riviezzo della Torre servo (anni 17)
[2] Archivio di Stato di Brindisi, Fondo Notarile di Mesagne, Notar Biagio Maria Pinto, a. 1762, cc. 56-71.
[3] A.S.Br., Fondo Notarile di Mesagne, Notar Biagio Maria Pinto, a. 1764, cc. 71-82.
[4] A.PROFILO, Vie piazze, vichi e corti di Mesagne, Ostuni 1894, n. ed. a cura di D.Urgesi, Fasano 1993;
[5] N.VACCA, Baldassarre Papadia e l’inedito suo viaggio nell’Alto Salento, in “Archivio Storico Pugliese”, XXII (1969), p.135.
[6] M.VINCI, Per una biografia di Antonio Mavaro (1725-1812), in “Lu Lampiune”, IX (1993), n.2, pp.
Giovanni Messe (1883-1968)
di
Marcello Ignone
Il futuro maresciallo d’Italia nacque a Mesagne il 10 dicembre 1883. Suo padre, Oronzo, era scrivano presso il panificio Semeraro e sua madre, Filomena Argentieri, era filatrice. La loro modesta abitazione era ubicata al n.12 di via Lavare, antica denominazione dell’attuale via Federico II Svevo. Il giovane Messe, dopo aver svolto umili lavori e dal momento che la terra natia non offriva molto, decise di partire volontario per la vita militare a soli diciott’anni, nel 1901. Fu assegnato al Plotone Allievi Sergenti del 45° Fanteria. Sei mesi dopo ricopriva il grado di caporale ed il 30 settembre del 1902 fu promosso caporale maggiore. Divenne sergente il 30 giugno 1903 e il 2 luglio fu assegnato al 5° fanteria. Il 5 settembre 1903, inquadrato nel Reparto Misto, si imbarcò a Napoli per la Cina, dove la rivolta nazionalista dei Boxer minacciava le legazioni straniere. Messe rimase in Cina, a difesa della legazione italiana, fino al 27 aprile 1905, quando si reimbarcò a Takù, sul mar Giallo. Il 31 dicembre di quell’anno fu nominato sergente furiere sempre nel 5° Fanteria. Il 1° gennaio 1907 fu promosso sergente maggiore ed il 31 dicembre maresciallo di compagnia.
Nel 1908, con il grado di maresciallo di 3ª classe, partecipò al concorso per l’ammissione al corso speciale per sottufficiali allievi presso la scuola militare di Modena. Si collocò al primo posto fra trecento candidati. Ne uscì due anni dopo, nel settembre del 1910, con il grado di sottotenente e fu assegnato all’84° Fanteria. Nel settembre del 1911 l’Italia dichiarò guerra alla Turchia ed inviò un Corpo di spedizione in terra africana per occupare la Libia. Il 9 ottobre Messe partì da Napoli diretto in Tripolitania. Il reggimento di Messe partecipò al combattimento di Sciara-Zanja, presso Tripoli, guadagnandosi una medaglia d’oro e Messe ottenne, successivamente, una decorazione al valore. Dopo un anno fu però costretto a rientrare in Italia per curarsi una malattia. Il 17 settembre fu promosso tenente ed un mese dopo ripartì per la Libia, dove fu assegnato al 3° Battaglione dell’84° Fanteria. Fu promosso capitano nel novembre del 1915 e fu per due anni al comando di una compagnia. Lasciò la Libia alla fine del 1916. Giunto in Italia fu subito destinato al fronte, nelle file del 57° Fanteria. Messe partecipò a molte battaglie e gran parte del suo futuro prestigio di soldato fu conquistato durante il primo conflitto sui campi di battaglia.
Nell’agosto 1917 assunse interinalmente il comando di un battaglione, guadagnandosi la seconda decorazione al valore. Nell’ottobre ricevette una terza decorazione al valore ed il 12 dello stesso mese fu ferito in combattimento. Ricevette la promozione a maggiore nell’ospedale di Udine. Il 24 ottobre 1917 l’Italia si trovò ad affrontare, a Caporetto, lo sfondamento causato dall’attacco austro – tedesco che minacciò di dilagare nella pianura padana. Per evitare l’accerchiamento le truppe italiane dovettero ritirarsi. Il 27 ottobre Messe fu trasferito all’ospedale di Milano. Rientrò in servizio a fine novembre ed il 3 dicembre riprese il comando del battaglione. Nel gennaio 1918 assunse il comando del IX Reparto d’assalto della 18ª Divisione. Il Comando supremo dell’esercito italiano aveva fatto tesoro dell’esperienza di tante dure battaglie. I tedeschi, al comando del giovane tenente Erwin Rommel (il generale della seconda guerra mondiale), avevano messo in crisi quattro divisioni italiane grazie all’adozione di una nuova tecnica. Grosse pattuglie si infiltravano nelle linee italiane, approfittando del cattivo tempo ed attaccavano alle spalle i reparti schierati a difesa ed abituati ad avere il nemico di fronte. Fu, allora, costituito il corpo degli “arditi”, reparti scelti d’assalto ed addestrati ad una simile guerra, fatta di rapide incursioni e senza il rispetto di tecniche militari antiquate che erano costate al nostro esercito migliaia di morti. Messe, con il suo reparto d’assalto, nel maggio-giugno del 1918, si guadagnò un’altra decorazione al valore a Grazigna. Nella battaglia del Solstizio, o seconda battaglia del Piave (una delle più sanguinose di tutta la Grande Guerra), impiegato con il suo battaglione di “Fiamme nere” nella zona di Col Moschin ad incalzare da vicino le retroguardie austro-ungariche, si meritò una prestigiosa decorazione: la Croce dell’Ordine Militare di Savoia.
Il 24 giugno, nella zona di Monte Asolone, si distinse in valore con i suoi arditi (spesso il combattimento era all’arma bianca) al punto da meritare un’altra decorazione. Il nostro esercito rimase praticamente inattivo per tutta l’estate del 1918. Si preparò un piano offensivo in grande stile perché si intendeva sconfiggere definitivamente gli austriaci, prima di un armistizio non desiderato con il nemico ancora sul territorio italiano. L’esercito italiano in meno di un mese abbandonò le posizioni difensive e mosse all’attacco di quelle nemiche del Grappa, cui seguì l’attacco principale alle linee austriache del Piave, davanti al Montello. Il 24 ottobre (un anno dopo Caporetto) scattò l’offensiva italiana, ma l’attacco italiano non poté effettuarsi per la piena del fiume. La battaglia si sviluppò sul Grappa e gli italiani impegnarono il grosso delle forze austriache del fronte settentrionale.
Il 29 ottobre Messe fu ferito ad una gamba da una bomba a mano e ricoverato in ospedale. Il 25 novembre, a guerra finita, fu inviato in convalescenza. Riprese servizio il 9 gennaio del 1919. Nel marzo successivo il suo reparto d’assalto fu sciolto ed egli fu assegnato al deposito di Padova. Il 13 maggio 1919 fu promosso tenente colonnello per meriti di guerra. Nel luglio successivo è assegnato al 1° Fanteria e promosso, ad agosto, comandante del reparto Arditi del Corpo d’armata della capitale, in forza al Deposito del 2° bersaglieri di stanza a Trastevere. Qui il tenente colonnello Messe incaricò un giovanissimo bersagliere di organizzare delle recite con i soldati. Quel giovane soldato che saldava i conti con la patria era Eduardo De Filippo! Il grande attore napoletano, non ancora ventenne, era abbastanza conosciuto, recitava da tempo ed aveva addirittura il privilegio della “serata d’onore”. Messe lo incaricò “di organizzare delle recite con i soldati” e lo stesso Eduardo, anni dopo, racconterà: «Scelsi gli elementi più adatti e mi misi al lavoro. I risultati furono eccellenti. Ogni sabato i bersaglieri rinunciavano alla libera uscita per assistere allo spettacolo dei loro commilitoni, opportunamente guidati e coadiuvati dallo stesso Eduardo e da sua sorella Titina.
Messe, destinato nel giugno del 1920 al 1° Reggimento d’assalto, si imbarca il 14 dello stesso mese a Brindisi per l’Albania e sbarca nel porto di Valona il giorno seguente. Qui si guadagna un’altra decorazione al valore. A causa di una malattia rimpatria in Italia ed è ricoverato il 27 giugno nell’ospedale di Francavilla Fontana. Nel settembre è assegnato al 2° Reggimento bersaglieri del quale comanderà, uno dopo l’altro, i tre battaglioni, nell’ordine IV, XVIII e II. Il 7 aprile 1921 si sposa con Maria Antonietta Venezze. Dal matrimonio nasceranno due figli: Filomena e Gianfranco. Nel luglio del ’21 è nominato giudice supplente del Tribunale Militare speciale di Roma, ufficio che conserva fino al 5 aprile del ’23, quando è promosso aiutante di campo effettivo di re Vittorio Emanuele III. Ricopre la carica per quattro anni ed al termine è nominato aiutante di campo onorario del re. Il 1° maggio 1927 è assegnato al 9° Bersaglieri in qualità di comandante facente funzione ed il 27 novembre è promosso colonnello e diviene comandante effettivo del reggimento.
Dopo otto anni, il 16 settembre 1935, lascia il comando del reggimento ed è posto a disposizione del Ministero della Guerra. Il 20 ottobre è incaricato del comando della III Brigata Celere di stanza a Verona. Ne diviene il comandante effettivo il 1° gennaio successivo, all’atto della promozione a generale di brigata. Il 26 febbraio del ’36 parte da Napoli per l’Eritrea, dove giunge il 4 marzo. Il 22 febbraio è nominato vice comandante della Cosseria e partecipa alle fasi finali della conquista dell’Etiopia (ottobre 1935 – maggio 1936). Rientra in Italia nel settembre e due mesi dopo è destinato all’Ispettorato delle truppe celeri. Il 1° aprile 1938 è comandante facente funzioni della III Divisione Celere “Principe Amedeo Duca d’Aosta” di Verona. Il 30 luglio successivo è promosso al grado di generale di divisione e ne diviene comandante effettivo. Nell’aprile del ’39 è nominato vice comandante del Corpo di spedizione in Albania e partecipa alle operazioni per la conquista del Paese delle aquile al comando della divisione “Centauro”. Durante queste operazioni ottiene l’ottava decorazione al valore.
La conquista dell’Albania “fu una passeggiata” ma rivelò «la miserevole condizione dell’esercito». Mussolini non tenne in nessun conto il rapporto del maresciallo Badoglio che poneva in rilievo gli errori compiuti durante la conquista, in particolare durante lo sbarco. Nel maggio del ’40 è destinato al comando interinale del Corpo d’armata Celere e nel novembre è di nuovo in Albania, dove viene nominato comandante del Corpo d’armata speciale e partecipa, dal dicembre all’aprile del ’41, alla «sciagurata campagna di Grecia». Durante questa campagna Messe ottiene la promozione a generale di corpo d’armata per “merito di guerra” con la seguente motivazione: «assunto in critica situazione il comando di una grande unità già duramente provata, riusciva a centuplicare le forze e la volontà ed a troncare così l’azione irruente del nemico proteso alla conquista di una delle più importanti basi marittime d’Albania. Organizzava quindi in breve una solida barriera difensiva, sulla quale il suo Corpo d’Armata esaltato dal suo esempio e dalle sue virtù incitatrici di capo, resisteva incrollabilmente ai rabbiosi, replicati attacchi dell’avversario. Dopo aver gradualmente troncato ogni capacità reattiva, balzava poi alla controffensiva, premendo ed inseguendo il nemico fino alla sua totale dissoluzione».
La Grecia però non era l’Albania e l’esercito greco si batté con coraggio e determinazione ed alla fine il prestigio di Mussolini e del comando militare italiano risultò profondamente scosso. I tedeschi si resero conto che l’alleato italiano, ancora fermo alle esperienze della prima guerra mondiale, non era in grado di affrontare autonomamente una guerra. Anche Messe dovette cominciare a nutrire simili dubbi. In verità un tentativo di riforma del vecchio ordinamento dell’esercito italiano c’era stato con il generale Baistrocchi, il quale aveva tentato di creare un esercito moderno, fatto di unità bene armate e, soprattutto mobili. Baistrocchi fu però destituito e tra i motivi ci fu anche la sua opposizione alla partecipazione dell’Italia alla guerra civile spagnola. Fu sostituito con il generale Pariani che volle ad ogni costo creare le cosiddette “divisioni binarie”, in pratica una brigata rinforzata con un reggimento di artiglieri. Le nostre divisioni rimasero inferiori come dimensioni rispetto a quelle di altri eserciti, senza riserve e, quindi, impossibilitate a manovrare in profondità. Ci si preoccupò, soprattutto, di mobilitare tutte le divisioni possibili in termini di quantità, ma senza dotarle di mezzi adeguati alla guerra moderna. Per Pariani sarebbero state sufficienti, in mancanza o penuria dei materiali, le sole “forze morali”. In queste condizioni l’Italia si avviò a combattere una guerra nuova, per la quale era impreparata, ma anche demotivata e con scarsa o nessuna simpatia per l’alleato tedesco, che ispirava, ad ogni livello, più timore che fiducia.
Fu così che entrammo in guerra , «senza una idea chiara di quello che dovevamo fare, con poco denaro, senza materie prime e con scarsezza di viveri, con forze armate strutturalmente inadatte alla guerra mediterranea, con esercito scosso da inopportune riforme, non addestrato ed armato in modo scarso ed arcaico» (MESSE, Come finì la guerra in Africa, Milano 1946). Se già le nostre forze armate erano “strutturalmente inadatte alla guerra mediterranea”, figuriamoci per una guerra tra colossi condotta in steppe sterminate e con temperature polari. Eppure si volle a tutti i costi l’intervento, a fianco dei tedeschi, nell’immensità delle steppe sovietiche. L’esercito italiano si accorse subito, dal semplice soldato al Comandante del Corpo di spedizione, che l’impresa era a dir poco folle, non solo inadeguata a causa dell’armamento piuttosto arcaico, ma anche per l’enorme differenza che v’era nel modo di condurre la guerra e nella mentalità dell’alleato tedesco. Anche la popolazione russa ed ucraina fu subito tratta a fare le debite differenze: il soldato italiano, in genere, non si macchiò di delitti e fu visto, perciò, senza particolare odio dalla popolazione, pur restando, comunque, un invasore da combattere.
Nel giugno del 1941 Messe rientrava in Italia e a Padova, sede del comando del Corpo d’Armata Speciale, riceve, la notte del 13 luglio, l’ordine telefonico di sostituire il generale Francesco Zingales, comandante del Corpo d’Armata autotrasportabile, ammalatosi durante il trasferimento in Russia. Così Messe si trovò a sostituire Zingales nel comando del Corpo di spedizione italiano in Russia. Il CSIR era formato da 3.000 ufficiali e 58.000 soldati, in tutto 62.000 uomini con 5.500 automezzi di ogni genere. Messe non ci mise molto a capire che il termine autotrasportabile era semplicemente un eufemismo che, se non fosse stata una tragedia immane, oseremmo definire ridicolo. Infatti mentre metà del Corpo di spedizione avanzava velocemente, l’altra metà lo seguiva a piedi, per centinai di chilometri, creando in mezzo un pauroso vuoto, con i magazzini, i depositi di munizioni, gli ospedali e le officine fermi per la scarsezza dei mezzi di trasporto. Il CSIR, secondo gli ordini del nuovo capo di S.M., generale Cavallero, avrebbe dovuto essere utilizzato in modo unitario, ma era praticamente impossibile mantenere unite le diverse divisioni che procedevano a “motorizzazione alternata”. Di questo Messe si rese conto, ma il suo potere decisionale era limitato dal fatto che il CSIR era incorporato nella I Armata tedesca. Nonostante la penuria di mezzi, in particolare di carri armati pesanti e di cannoni anticarro più potenti, i nostri soldati si comportarono, diciamo così, onorevolmente, se vi può essere onore nel combattere ed uccidere.
Il 15 settembre il CSIR al completo, ed era la prima volta, partecipava alla grande offensiva che aveva come obiettivo Kiev e l’accerchiamento delle forze sovietiche che la difendevano. Lo stesso Messe definì la battaglia come la «manovra di Petrikowka», alla fine della quale furono catturati ottomila soldati sovietici (MESSE, La guerra sul fronte russo, Milano 1947). Nel novembre i nostri soldati entravano a Stalino e a Gorlovka, ma il sopraggiungere del rigido inverno russo, determinò un arresto delle attività belliche. Messe, in una lettera a Cavallero, lamentava la scarsità di viveri e di vestiario, specialmente di scarpe. Solo alcuni reggimenti, per iniziativa personale dei loro comandanti, avevano i valenkij, gli stivali di feltro, in dotazione all’esercito sovietico, che facevano respirare il piede e consentivano al sangue di circolare; tutti gli altri avevano scarponi in cuoio e suola di gomma regolamentari, che si riveleranno una trappola. Messe, per far fronte a questa disastrosa situazione, fece acquistare in Ungheria e in Romania vestiario invernale. Fu, comunque, una misura insufficiente: il CSIR ha oltre 3.000 casi di congelamento. La strategia dello spazio con l’aiuto del “generale inverno” attuata dai sovietici aveva avuto di nuovo successo, prima con Napoleone ora con le armate nazifasciste. Hitler ha ora un disperato bisogno di uomini e mezzi e, perciò, accetta la sciagurata proposta di Mussolini di aumentare il contingente italiano ed elevarlo ad armata. Il fronte è senza confine e il territorio che le armate tedesche si lasciano alle spalle è immenso e deve costantemente essere presidiato. È preda tedesca e da esso i tedeschi traggono tutto quello che possono. Degli alleati non hanno fiducia, specialmente degli italiani che socializzano troppo con la popolazione locale.
I tedeschi premono e Mussolini non sa dire di no. Né Cavallero a Mussolini. Nasce così l’ARMIR, l’armata italiana in Russia, già in progetto da mesi. Altre divisioni male armate e poco equipaggiate, sono inviate nell’inferno russo, a morte certa. Le relazioni, i consigli ed i moniti di Messe, come quello di modificare gli automezzi per adattarli al clima polare, non sono presi in considerazione. La decisione dello Stato Maggiore di inviare sul campo di battaglia automezzi dipinti in giallo-verde, visibilissimi nella steppa innevata, ha del surreale ed è, per i nostri soldati, tragica. Il comando dell’armata è affidato al generale Gariboldi. È quasi certamente una manovra di Cavallero per bloccare Messe «che cominciava a crescere troppo nella considerazione del Duce e del Paese». Ma altri tre generali (Dalmazzo, Caracciolo e Gariboldi) sono più anziani e secondo il criterio dell’anzianità vigente nell’esercito italiano, hanno la precedenza sul generale mesagnese che, scoperto quello che si intende fare, si reca a Roma, parla con Mussolini e gli spiega che è un suicidio inviare in Russia un’armata senza mezzi, senza carri armati ed automezzi idonei. Ma Mussolini ha già deciso e per il Duce «al tavolo della pace peseranno assai più i 200.000 dell’ARMIR che i 60.000 del CSIR».
Nasce l’VIII armata italiana (ARMIR) e il CSIR, il 3 giugno 1942, riprende il suo precedente nome, 35° corpo d’armata. Altre sette divisioni arrivano dall’Italia per far parte dell’armata. Il 35° corpo d’armata (ex CSIR) è adesso aggregato alla XVII armata tedesca. Il 23 settembre Messe scrive a Gariboldi, dopo molte richieste verbali, e chiede di essere sostituito nel comando. In precedenza, e precisamente il 31 agosto, aveva avanzato la stessa richiesta a Mussolini. Il motivo è puramente personale: tra Messe e Gariboldi non c’è intesa né fiducia e i rapporti non sono dei migliori, con grave pregiudizio per la condotta della guerra. Due giorni dopo la richiesta è accolta e Messe rientra in Italia il 1° novembre. Il 30 novembre riceve la promozione a generale d’armata «per meriti di guerra». Al comando del CSIR aveva in precedenza guadagnato la croce di commendatore dell’ordine militare di Savoia e ben due croci di guerra tedesche. A metà dicembre riceve un’altra decorazione germanica. Gli uomini e il materiale inviati in Russia sarebbero stati utilissimi in Africa settentrionale, dove gli eserciti dell’Asse erano sul punto di capitolare perché allo stremo delle forze dal momento che di fronte avevano avversari di gran lunga superiori in numero, equipaggiamento ed armamento.
Cavallero, un bravo generale più preoccupato però delle beghe politiche romane che dei problemi militari, designa Messe quale comandante dell’armata in Tunisia. Questa designazione, comunicata il 21 gennaio 1943, parve a Messe, secondo quanto scrisse Ciano, «un colpo mancino tiratogli da Cavallero per sbarazzarsene, poiché anch’egli deve essere convinto che in Tunisia non ci sono per noi possibilità di sorta e vuole che Messe, in una partita disperata, perda la sua reputazione e magari finisca in un campo di prigionia» (CIANO, Diario 1939-43, Milano 1946). Una conferma indiretta si può avere dal colloquio, presente Cavallero, che Messe ebbe con Mussolini il 23 gennaio a palazzo Venezia. Il Duce disse a Messe che avrebbe trovato un esercito ancora in buone condizioni, con armi e mezzi sufficienti. Messe fece presente che a lui risultava una situazione diversa, specialmente riguardo agli automezzi, alla cui deficienza era da attribuire la perdita delle divisioni di fanteria durante la ritirata. Cavallero restò in silenzio: evidentemente, a dire dello stesso Messe, aveva male informato Mussolini al ritorno del suo recente viaggio in Tripolitania o, peggio, il Duce non voleva arrendersi di fronte all’evidenza ed ostentava ottimismo. Una decisione sensata, tra l’altro logica per chiunque, avrebbe fatto risparmiare all’Italia molti lutti. Mussolini, però, era ormai preda di un forte stato confusionale, al punto che pretese da Messe, e quindi dalle truppe italiane in Africa, una resistenza ad oltranza, almeno sino all’autunno inoltrato, e ciò per evitare uno sbarco angloamericano sul suolo italiano, ancora una volta sottovalutando le forze avversarie e, in particolare, la capacità bellica degli americani.
Messe raggiunse l’ultimo fronte dove ancora si resisteva, il 31 gennaio 1943, assumendo il comando della I armata, composta da quattro divisioni di fanteria italiane e due tedesche, oltre a ciò che restava del D.A.K. di Rommel ed altre forze minori, per un totale di poco più ci centomila uomini. Ma anche in Africa la partita era ormai chiusa, nonostante alcuni favorevoli contrattacchi e la costituzione di una testa di ponte in Tunisia. Anche per lo stesso Rommel «rimanere più a lungo in Africa è un vero suicidio». Lo dice a Mussolini il 9 marzo ed il giorno dopo ad Hitler. È tutto inutile e l’abile generale tedesco viene esonerato. Gli alleati premono, americani, inglesi e francesi dall’Algeria e l’VIII armata inglese dalla Libia. Messe, che difendeva con la sua armata il fronte sud, resiste bene sino al 10 maggio, poi si ritira. L’11 maggio si combatte ancora accanitamente, ma è un sacrificio inutile perché «l’enorme sproporzione delle forze ed il progressivo esaurimento delle munizioni di artiglieria, lasciano prevedere che la resistenza non potrà protrarsi a lungo» (MESSE, op. cit.).
Il 12 maggio Mussolini comunica a Messe: siccome «gli scopi della resistenza possono considerarsi raggiunti, lascio V.E. libera accettare onorevole resa». La sera stessa Messe è promosso Maresciallo d’Italia. Il giorno dopo Messe e ciò che resta della I armata sono fatti prigionieri. Messe, prigioniero degli inglesi, è trasferito in Inghilterra. Il 5 settembre l’Italia firma a Cassibile, in Sicilia, l’armistizio, reso noto l’8 settembre. La guerra, nell’ultimo periodo conosciuta in Italia a causa dei bombardamenti ma sino ad allora quasi estranea agli italiani eccetto che per coloro che avevano congiunti al fronte, si trasferisce rovinosamente sul nostro suolo. Hitler ha da tempo pronto il piano “Alarico”, cioè l’invasione ed occupazione dell’Italia. La resistenza sulla penisola italiana serviva ad evitare che la guerra giungesse sul territorio tedesco. Mussolini, precedentemente arrestato, era liberato al Gran sasso da paracadutisti tedeschi e, una volta libero, costituì la Repubblica di Salò. Al Sud occupato dagli angloamericani, operava il governo Badoglio. Messe è rimpatriato il 18 novembre 1943 e si pone subito al servizio del governo di Badoglio. È nominato capo di stato maggiore generale e ricoprirà tale carica sino al 1° maggio del 1945.
Il 27 marzo 1947 è collocato nella riserva, dopo 46 anni di servizio militare e dopo aver percorso tutti i gradi possibili, da soldato semplice a capo di stato maggiore generale. Alla fine della sua carriera militare, poteva vantare quattro promozioni per meriti di guerra, quattro decorazioni dell’ordine militare di Savoia, tre medaglie d’argento, una medaglia di bronzo, due croci di guerra al valor militare, quattro croci al merito di guerra. Era stato tre volte ferito in combattimento durante la prima guerra mondiale e aveva sostenuto, nel corso della sua lunga carriera, 19 campagne di guerra. Successivamente, si dedicò all’attività politica, divenendo anche scrittore di cose militari. Pubblicò due volumi di memorie: Come finì la guerra in Africa (Milano, Rizzoli 1946) e La guerra al fronte russo (id., 1947), rare eccezioni nel panorama della cosiddetta «memorialistica difensiva… di livello quasi sempre inqualificabile per disinvoltura e faziosità», in quanto i suoi libri sono «limitati alle onorevoli esperienze di comando dell’autore» (ROCHAT, Seconda guerra mondiale, in Storia d’Italia, Firenze 1978, vol. II). Nel 1953 è eletto senatore indipendente nelle liste della Democrazia Cristiana nel collegio di Brindisi. In seguito è eletto deputato nelle liste monarchiche e, successivamente, in quelle liberali (1963). Nel pieno clima della guerra fredda, nel marzo del 1955, insieme ad altri esponenti del combattentismo, tra cui dodici medaglie d’oro, aveva fondato l’Unione Combattenti d’Italia, con carattere spiccatamente anticomunista e ne aveva assunto la presidenza. «I due pilastri fondamentali», come li definì in suo discorso al Teatro Lirico di Milano il 4 dicembre 1955, erano la concordia e il patriottismo. Le polemiche che ne scaturirono furono roventi (MESSE, Il combattentismo nella vita politica italiana, Roma 1956).
A ben vedere la fondazione dell’UCI, con gli obiettivi che si proponeva, ad oltre un decennio dalla fine del secondo conflitto, ma nel pieno della Guerra fredda, anche alla luce di quanto sta emergendo dagli archivi americani, disegnano un quadro abbastanza fosco che pone non pochi interrogativi non del tutto chiariti. Messe era a conoscenza della proposta avanzata da Montanelli nel 1954, durante il governo Scelba, all’ambasciatrice americana in Italia, Clare Boothe Luce, di creare una organizzazione segreta anticomunista con il compito di fiancheggiare eventuali golpisti? Montanelli intende offrire a Messe la guida dell’organizzazione terroristica, fa il nome del maresciallo nelle lettere che invia a Clara Luce. Le lettere sono state ritrovate negli archivi della Library of Congress di Washington dallo studioso italiano Mario Del Pero e pubblicate recentemente dal periodico “Italia contemporanea”, organo dell’Istituto Nazionale del movimento di liberazione. In esse Montanelli fa presente che il maresciallo Messe era il più adatto per un simile compito, a differenza di altri, perché era «uno dei pochi generali usciti dalla guerra con onore». È logico supporre che la proposta di porre Messe a capo dell’associazione dei «100mila bastonatori» di comunisti sia stata avanzata da Montanelli o dopo che questi ne aveva parlato con Messe, e che quindi avrà conosciuto il progetto, oppure, ammesso fosse un’idea del giornalista, quest’ultimo era sicuro della risposta positiva del generale, tanto da proporlo a capo dell’associazione segreta, sia per il suo provato anticomunismo che per il prestigio di cui godeva negli ambienti militari e di destra.
L’ultimo maresciallo d’Italia moriva a Roma il 18 dicembre 1968. Fu uno dei «generali della dittatura», estratti da Mussolini «dai quadri dell’esercito regio che nell’ottobre del ’22 lo avevano portato al potere secondo il disegno della monarchia e della casta militare» (BUCCIANTE); giocò un ruolo non di secondo piano nel nostro Paese nel periodo delle due guerre ed oltre; fu un militare e un politico abbastanza famoso e controverso, ancora, come abbiamo visto, tutto da studiare e scoprire alla luce degli avvenimenti che lo videro protagonista di questo «secolo breve».

(1851-1919)
di
Marcello Ignone
Muscogiuri fu discepolo di Francesco De Sanctis, che lo volle Capo di Gabinetto del Segretario generale al Ministero della Pubblica Istruzione nel 1880, quando il grande critico letterario era ministro. In precedenza, ed esattamente nel 1875, era stato a Roma, chiamato dall’allora ministro Bonghi, per classificare i libri della Biblioteca “Vittorio Emanuele”. Francesco Muscogiuri nacque a Mesagne l’11 gennaio 1851 (il padre era di Torre S. Susanna e la madre di Mesagne), compì i suoi primi studi a Brindisi, successivamente frequentò il liceo “Palmieri” di Lecce, senza, però, conseguire la licenza liceale. Si trasferì, quindi, a Napoli, dove frequentò, tra il 1870 ed il 1874, la facoltà di Lettere, laureandosi. Intraprese, l’anno dopo, la carriera di professore. Insegnò nel ginnasio di Nicosia, nel licelo “Campanella” di Reggio Calabria, al “Palmieri” di Lecce, al liceo di Chieti, al “Genovesi” di Napoli, nella scuola Fonseca-Pimental e nel liceo di Padova. Nel 1889 fu eletto membro effettivo della Giunta Provinciale Amministrativa di Lecce, provocando non poco scalpore per le posizioni che spesso assunse contro i provvedimenti della G.P.A. stessa. Nel 1890 fu nominato delegato scolastico del mandamento di Mesagne e nel 1893 Ispettore onorario per i Monumenti e Scavi, carica che tenne sino al 1913. Nel 1894 gli fu conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia e, nel 1900, divenne Ufficiale dello stesso Ordine. Nel 1903 fu incaricato, presso la Biblioteca dell’Università di Napoli, di compilare un catalogo speciale delle opere riguardanti gli studi danteschi. La compilazione del catalogo lo tenne occupato sino al 1906. Dal 1907 al 1910 fu comandato a prestare servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione. Dopo un’altra breve parentesi d’insegnamento, chiese di essere collocato a riposo. Nel 1912 si ritirò in pensione e si trasferì definitivamente nella sua Mesagne, dove, in precedenza, ed esattamente nel 1882, si era sposato e dove aveva anche ricoperto la carica di Sindaco f.f. per due volte, dal 30.11.1893 al 19.7.1894 e dal 5.12.1894 al 16.1.1895.
In qualità di amministratore si distinse, come del resto aveva fatto in seno alla G.P.A., per correttezza e capacità amministrativa. Promosse opere di pubblica utilità, quali la trasformazione della palude Scarano in Villa Comunale, lo spostamento della colonna votiva della Madonna del Carmine, da piazza Municipio (l’attuale piazza IV Novembre) al Largo Scarano (l’attuale Villa Comunale). Fece costruire tre cisterne pubbliche per alleviare, almeno in parte, il problema dell’approvvigionamento idrico. Infine completò il Teatro Comunale. Presidente della Congregazione della Carità, si dimise per incompatibilità con la carica di sindaco, dalla quale si dimise per incompatibilità con la carica di Delegato Scolastico, almeno queste furono le motivazioni ufficiali. Il Consiglio Comunale respinse le dimissioni, ma il Muscogiuri fu irremovibile e allora si dimise da assessore effettivo e, quindi, da sindaco facente funzioni. Il 6 aprile 1919 morì l’amata moglie, Rosina Profilo. Il 3 dicembre dello stesso anno morì anche il nostro Muscogiuri. Aveva 68 anni. Non lasciò eredi e, perciò, volle destinare gran parte dei suoi beni alla Congregazione di Carità, non smentendo la sua famosa generosità. Volle, altresì, destinare la sua biblioteca alle scuole elementari di Mesagne, “a scopo di lettura e di studio per insegnanti e alunni”. Tale biblioteca comprendeva in origine oltre 1500 volumi e nel 1986, ciò che restava dei volumi, passò alla biblioteca comunale “Granafei”. Muscogiuri fu autore di molte opere di critica letteraria, tra le quali ricordiamo:
- Note letterarie (Lecce 1877);
- Il Cenacolo (Roma 1878);
- Wolfango Goethe ed il Faust (Roma 1883);
- Di alcuni caratteri meno popolari della Divina Commedia (Firenze 1889);
- Catulliane (Firenze 1889);
- Teodoro Körner (Firenze 1891);
- Due donne del primo impero (Napoli 1903).
Pubblicò, tra il 1873 e il 1902, anche numerosi articoli su varie riviste, quali Nuova Antologia, Rivista Europea (sotto la direzione del De Gubernatis), Gazzettino Letterario di Lecce, Natura ed Arte, Nuova Rassegna, Hesperia e molte altre. Studi, conferenze e traduzioni dal latino e dal tedesco, completano la figura intellettuale di Muscogiuri, che fu uomo di vasta cultura, anche se è considerato un critico minore. Per invitare a riflettere sulla figura di questo letterato mesagnese, si riporta un episodio, pubblicato dallo stesso Muscogiuri su Natura ed Arte nel 1893, nel contesto di un più vasto saggio biografico su Francesco De Sanctis, morto dieci anni prima, nel 1883. Un amico del Muscogiuri presentò al grande critico irpino, alcuni articoli del giovane intellettuale mesagnese apparsi sul Pungolo, scritti in occasione della traslazione delle ceneri di Ugo Foscolo da Londra a Firenze. Muscogiuri aveva appena vent’anni, ma la sua prosa era “tutta lampi e epifonemi”. Il De Sanctis lesse gli articoli a scuola. Disse che l’autore aveva “un’eccellente attitudine alla critica” e volle conoscerlo. Ma il Muscogiuri era assente, e solo la sera seppe del desiderio del maestro. Andò a trovarlo a casa per ringraziarlo del benevolo giudizio.
Il De Sanctis fu cordiale e lo intrattenne su molti argomenti. Poi gli disse:
– Perché non vi iscrivete alla facoltà di filosofia e lettere?
Muscogiuri, arrossendo e chinando il capo, rispose mortificato:
– Non posso. Non ho la licenza liceale. Sono stato riprovato in una materia, il greco.
– Male, caro mio. Avete dunque una decisa avversione per le lingue!
– Non credo, perché so il francese, il latino ed il tedesco.
Il De Sanctis sgranò gli occhi dubbioso e soggiunse:
– Spero non sia una jattanza.
– Provi, professore.
– E sia. Ecco qui un giornale tedesco arrivatomi ieri. Vi è un articolo che parla di me; traducete.
Il Muscogiuri tradusse con tanta perizia che il De Sanctis ne fu meravigliato. Lo stesso fece con un’ode di Catullo.
– Traducete. È la prova del fuoco!
Ma il giovane Muscogiuri se la cavò molto bene e il De Sanctis, stringendogli la mano, esclamò:
– Bravo! Se vi manca la licenza, vuol dire che ne farete di meno. Io non ho nessun titolo, e non pertanto…
– Ma per lei è diverso – osservò umilmente il giovane mesagnese.
– Andate, andate, caro, e non temete. Venite a trovarmi spesso, e frequentate la mia scuola. Penserò io al resto.
Da quel momento il Muscogiuri fu tra i più assidui e diletti discepoli del De Sanctis.
Dall’elenco precedente si può notare che l’ultima pubblicazione del Muscogiuri è “Due donne del primo impero”, lavoro già compiuto nel 1902 e poi pubblicato l’anno seguente. Ben sedici anni prima della morte, Muscogiuri aveva, quindi, esaurito la sua vena di scrittore e critico? In un appunto manoscritto dello stesso Muscogiuri si legge: «Ma, o forse per eccesso di lavoro – poiché egli ebbe costante il sentimento del dovere nel disimpegno del suo ufficio, come si rileva dalle relazioni annuali dei presidi dei licei di Chieti e di Napoli e da una deliberazione del Collegio dei professori del Liceo “Genovesi” – o per cagioni, nel gennaio del 1902 egli si ammalò gravemente, e fu costretto, per consiglio dei professori Fazio e Cappozzi, a chiedere l’aspettativa per motivi di salute». Successivamente, e precisamente nel novembre del 1902, Muscogiuri fu richiamato in servizio, ma di fatto non riprese più l’insegnamento attivo e nonostante fosse titolate di lettere italiane nei licei, fu comandato a prestare servizio dapprima presso la Biblioteca dell’Università di Napoli e, dopo, presso la Biblioteca di S. Pietro in Maiella, sempre a Napoli. Successivamente “fu chiamato in missione presso il Ministero della Pubblica Istruzione”. Si rileva, infatti, dallo stesso appunto manoscritto, che «il Muscogiuri non può tornare all’insegnamento senza il pericolo di vedere rovinata per sempre la sua salute ancora cagionevole». Alla luce di gravi motivi di salute, quindi, si spiega la fine delle pubblicazioni nel 1902, a soli 51 anni.
Questi motivi di salute, comunque, non impedirono al Muscogiuri, una volta a Mesagne, di dedicarsi all’attività politica. Per conoscere il suo pensiero politico è sufficiente riportare alcune notizie apparse su alcuni giornali del tempo. Il 6 novembre 1892 dovevano svolgersi le elezioni generali per il Parlamento. Va detto che dalla nascita dello Stato unitario i governi succedutisi avevano avuto tutti vita più o meno breve e mentre il Muscogiuri scrive, al governo c’era, dal maggio 1892, il Giolitti che aveva preso il posto del di Rudinì e vi rimarrà sino al novembre del 1893, quando sarà sostituito dal Crispi. I nomi dei candidati per il collegio di Brindisi erano quelli di Monticelli, Capece–Minutolo, Saturnino Chiaia e del nostro Muscogiuri. Da “Il Corriere meridionale” del 25 settembre 1892 (Anno I – n. 25) si apprende che Monticelli e Capece-Minutolo avevano già accettato la candidatura, mentre gli altri due non avevano ancora dichiarato pubblicamente le loro decisioni in merito. Da una lettera del Muscogiuri al Corriere”, pubblicata il 29 settembre successivo, si apprendono le ragioni del rifiuto di candidarsi al Parlamento. Ecco il testo della lettera pubblicata da “Il Corriere Meridionale” di Lecce il 29.9.1892:
LA PROSSIMA LOTTA POLITICA NEL COLLEGIO DI BRINDISI
Riceviamo e pubblichiamo:
Mesagne, 27 sett. 1892
Caro Bernardini,
mi domandi se, fra tante affermazioni e smentite, sono o non sono un candidato. Veramente prima che queste elezioni prendessero l’aspetto di traffico nel disprezzo di qualsiasi idea le avevo [manifestato] il proposito di porre la mia candidatura nel collegio di Brindisi. Mi confortavano nell’alto fine la maggior parte dei miei concittadini e molte persone ragguardevoli e amici di Brindisi, di Latiano e del mandamento di Salice. Mi ho dovuto ritrarmi dalla lotta, non so se più attonito o disgustato. Disgustato di vedere un Ministero, che pur non avendo dato al paese alcuna prova di sapienza politica ed essendosi mostrato abile solo nell’agguato parlamentare, chiede alla Nazione impoverita una Camera servile, un branco di giannizzeri, che uniformino ai suoi ignoti disegni; disgustato da dividere una fungaia di candidati moderati progressisti e radicali, che affratellati nella dolce ambizione di salire, si naturalizzano ministeriali e intonano una peana al governo; attonito infine di sapere che gli elettori di questa mia diletta provincia, già fieri e indipendenti, non si piegano più, come un tempo, alla forza della ragione ma alla ragione della forza. E così via. Io volendo rimanere qual ero, né sapendo accomodarmi alla circostanza, mi ritraggo dalla lotta, e fo voti che anche questa putrefazione, come dice il De Cesare, ridondi a fortuna della patria. E poiché dopo questa mia dichiarazione, che pubblicherai nel Corriere, il silenzio si farà sul mio nome, permetti che io rilevi una frase che, comparsa la prima volta nella Tribuna, ha fatto il giro di molti giornali. Han detto che io sono moderato intransigente. Ecco: se moderato vuol dire non avere più fede nelle vane e tumultuarie riforme politiche, e averne invece molta nella risurrezione di un partito che dette Roma all’Italia e la prosperità alla Nazione, e che superando infinite difficoltà politiche e finanziarie e trovando nella indipendenza diplomatica, l’isolamento non già, ma la considerazione delle grandi potenze d’Europa, lasciò lo Stato ordinato all’interno e rispettato all’estero – sono moderato, e me ne tengo. Ma se si chiamano radicali coloro che invocano semplificazione degli ordinamenti amministrativi, il ritiro delle truppe dall’Africa sterile e fatale, il distacco dalle potenze centrali e la politica delle mani libere, la riduzione delle spese militari e il miglioramento delle oneste classi lavoratrici sotto l’impero di una legislazione democratica, sapiente e progressiva – sono per questo verso un radicale anch’io, meno clamoroso forse dei radicali di professione, ma non meno fervido e sincero di essi. Questo sono e questo penso. A quei molti o pochi elettori del mio collegio che conoscono già, e apprezzano questi intendimenti, e che avrebbero onorato il mio nome del loro suffragio, tanto più nobile e solenne quanto meno sollecitato ed imposto, rendo grazie vivissime. Possono essi mandare al Parlamento un uomo che sappia interpretare i voti e i dolori di queste contrade, alle quali il governo nega il pensiero, la fortuna, il sorriso e Iddio la pietà.
Ti stringo cordialmente la man
aff.mo Francesco Muscogiuri
A questa lettera del Muscogiuri fece seguito un articolo molto critico, a firma di Raffaele De Cesare, pubblicato da “Il Corriere” il 2 ottobre. Si può comprendere il pensiero politico del Muscogiuri anche dalle deliberazioni consiliari del periodo in cui fu, appunto, consigliere comunale e sindaco, oltre che dalla corrispondenza e dagli articoli. Una deliberazione consiliare è particolarmente indicativa, non solo del suo pensiero politico ma soprattutto dei sentimenti di solidarietà che egli nutrì verso le classi sociali meno abbienti. Il 7.11.1893 si discusse animosamente, in seno al Consiglio Comunale di Mesagne, sulla proposta del Muscogiuri di elevare il tetto massimo della tassa “focatico” a lire 300 e, nel contempo, di esonerare dalla stessa tutti coloro che non figuravano nei ruoli delle imposte dirette. Il sindaco di allora, Antonio Profilo (lo storiografo), espose le difficoltà pratiche a cui si sarebbe andarti incontro accettando la proposta del Muscogiuri: non far pagare le tasse a tutti i non iscritti nei ruoli delle imposte dirette, avrebbe comportato un danno molto grave per l’erario comunale, a causa della perdita di 3 o 4 mila lire per effetto dell’esonero. E poi la difficoltà di chiedere ed ottenere l’autorizzazione reale per l’elevazione della tassa “focatico” era non di poco conto. Se poi pochissimi non iscritti nei ruoli delle imposte dirette avevano prestato reclamo, era, per il Profilo, segno che c’era stata assuefazione alla tassa, e perciò era ritenuta giusta.
Muscogiuri, nel suo intervento, ritenne che il Profilo avesse voluto fare della “rettorica”, in quanto se il sindaco avesse consultato i ruoli presso l’esattore, avrebbe rilevato che tutti i proletari, pur trovandosi riportati per due lire nel ruolo “focatico”, ne pagavano in effetti quattro di lire, con le multe e le spese, e ciò stava a dimostrare che alle scadenze la povera gente era impossibilitata a pagare. Il Nostro affermò allora che era fin troppo evidente e “non bisognevole di ulteriori dimostrazioni che la sua proposta si basasse su ragioni vere di equità e giustizia per le classi lavoratrici”. Ricordò che la percentuale imponibile per la tassa focatico era oscillante da un minimo di lire 0,90 ad un massimo di lire 1 per cento gravante sul lavoro, cosicché il limite massimo imponibile colpiva il reddito di appena diecimila lire, mentre coloro che possedevano un reddito superiore finivano per essere colpiti con una percentuale di molto inferiore a quella che gravava sul lavoro. Chiese se ciò fosse giusto e se rispondesse ai canoni della democrazia fiscale, che vuole che le imposte siano pagate in proporzione da chi più possiede. Rammentò, inoltre, che simile principio fu da poco bandito dal Presidente del Consiglio dei Ministri e ricordò, ancora una volta, che la sua proposta era basata sulla ragione che chi più ha più deve pagare e sul ricordo, dimenticato troppo presto dal sindaco, del brutto inverno (invernata infame) che le classi lavoratrici avevano dovuto affrontare. Richiamò alla memoria le inaudite sofferenze subite dal popolo nell’inverno precedente; rammentò che tutte le tasse (da quella sugli animali da tiro ai dazi sul consumo) gravavano sui proletari, i quali finivano così per sopportare i maggiori aggravi dello Stato e del Comune. Ribatté l’argomento dell’Amministrazione Comunale, che paventava la perdita di duemila lire accettando la proposta, osservando a tal proposito che alla perdita si sarebbe facilmente trovato rimedio, ma se anche così non fosse stato, non era, in definitiva una perdita importante, anzi era “irrisoria” ed in più l’accettazione della proposta avrebbe impedito un palese atto di ingiustizia contro le classi lavoratrici, “fonte della nostra ricchezza”.
Sperò, quindi, che giustizia fosse fatta per ragioni di equità e diritto oltre che per un atto di solidarietà concreta verso i poveri e si riservò, in sede di bilancio, di dimostrare che il Comune non avrebbe perso una sola lira una volta che la sua proposta fosse stata accettata (dalla deliberazione n. 66 del 7.11.1893). Dopo gli interventi di alcuni consiglieri comunali, il Muscogiuri presentò la seguente proposta: «Il Consiglio convinto che la tassa focatico com’è ora ripartita, non risponde ad equità e si risolve in danno delle classi povere, delibera di elevare il massimo della tassa focatico a lire trecento, esonerando dal pagamento della stessa tutte le famiglie che non figurano sui ruoli delle imposte dirette o che tali imposte non paghino, salvo notoria agiatezza». La proposta del Muscogiuri fu messa ai voti per appello nominale ed approvata. Nel Consiglio Comunale del 10.11.1893 si discussero le dimissioni da sindaco di Antonio Profilo, fatte pervenire l’8 novembre, e di quattro assessori componenti la Giunta. Le dimissioni erano motivate da impegni dei diretti interessati. Il Muscogiuri, durante la seduta, disse che tali dimissioni erano dovute sia alla crisi che era sorta all’interno della Giunta dopo l’aumento, che lui aveva proposto, del massimo della tassa focatico, e questo aumento riguardava solo alcune famiglie di Mesagne, che ad una interrogazione presentata dal dott. Cavaliere su certi “comportamenti” della Giunta Municipale (deliberazione n. 67 del 7.11.1893). Nonostante tutto, però, l’intero Consiglio Comunale, tra cui lo stesso Muscogiuri, pregò i dimissionari di soprassedere. Furono concesse 24 ore di tempo per la risposta, che giunse negativa. Il 12.11.1893, con deliberazione n.71, il Muscogiuri fu eletto assessore effettivo, insieme al dott. Cavaliere, per sostituire due degli assessori dimissionari, mentre in una seduta successiva furono surrogati gli altri due assessori dimissionari e il Muscogiuri, divenuto assessore anziano a causa della sua maggiore età sul Cavaliere, divenne presidente del Consiglio Comunale e, dal 5.12.1893 (deliberazione n. 75), Sindaco facente funzioni. Egli stesso ebbe subito a precisare che la Giunta era in carica per sentimento di dovere e che la stessa era speranzosa di poter affidare subito l’amministrazione della cosa pubblica “a mani più esperte”.
Guglielmo Nocera (giurista)
All’età di 92 anni è deceduto in Roma, a fine febbraio, un illustre figlio di questa terra, il prof. Gugliemo Nocera, insigne giurista. Era nato a Mesagne nel 1907 ed aveva compiuto, alla stregua di suoi coetanei, gli studi scolastici a Lecce, allora capoluogo dell’intera Terra d’Otranto. E dal capoluogo nella capitale, per seguire la propria vocazione: il diritto. Nocera infatti studia e si laurea nella Regia Università a pieni voti. A 24 anni doveva esser già laureato da un pezzo se il nostro, assieme a Barberio, viene indicato da Alfredo Ascoli nel frontespizio del suo “Corso di diritto civile: Delle obbligazioni”. Nocera, infatti, assieme al collega raccolse le lezioni del maestro, tenute nel corso dell’anno accademico 1930-31, le quali furono pubblicate nella collana della Regia Università della capitale alla fine dello stesso anno 1931 (Roma, Tip. Sanpaolesi, s.d., ma 1931, p. VI-376).
Ma la vita di studio è fatta anche di lunghi soggiorni all’estero con borse di studio. Le biblioteche e gli istituti giuridici di Praga, Parigi e Berlino hanno visto il giovane Nocera approfondire temi e sentieri di ricerca grazie a borse di studio poi, giovanissimo, vince il concorso per la cattedra di Storia del Diritto Romano e insegna in diverse università, tra le quali Perugia che lo ha visto apprezzato docente per 30 anni e preside della facoltà giuridica per ben quattro lustri.
Unanimemente apprezzato, Guglielmo Nocera, Commendatore e Grand’Ufficiale e medaglia d’oro alla cultura, dal 1964 al 1968 è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura e da quegli anni fino alla pensione venne chiamato ad insegnare la Storia del Diritto Romano nell’Università “La Sapienza” di Roma. Del resto, senza voler dare un quadro esaustivo della sua attività di studioso, sulla quale ci riserviamo di tornare, scorrendo gli schedari delle più note biblioteche italiane, notiamo agevolmente il suo percorso culturale, scandito sempre da nuovi sforzi, da quella “curiosità” culturale che spinge ad orientare la ricerca su nuovi fronti di indagine. Ed ecco che prima del secondo conflitto mondiale abbiamo “Il potere dei comizi e i suoi limiti” (Milano, A. Giuffrè, 1940, pp. XI-304) e ancora “Insolvenza e responsabilità sussidiaria nel diritto romano” (Roma, Ed. Italiane, 1942, p. VII-338), che viene inserito nella collana della Regia Università di Roma – Istituto di diritto romano, dei diritti dell’Oriente mediterraneo e di storia del diritto.
Subito dopo la guerra diede alle stampe “Jus publicum,(D.2.14.38), contributo alla ricostruzione storico-esegetica delle Regulae iuris” (Roma, Ed. italiane, 1946, p. 258). E negli anni Sessanta, poi, nel corso del suo lungo periodo di docenza nell’Università di Perugina, ecco “Ius naturale: nella esperienza giuridica romana” (Milano, Giuffrè, 1962, pp. 138; Pubblicazioni dell’Istituto di storia del diritto, Facolta di Giurisprudenza, Università di Perugia).
Come non ricordare poi “Iurisprudentia: per una storia del pensiero giuridico romano”, (Roma : Bulzoni, [1973], p. 100) e “Reddere ius: saggio di una storia dell’amministrazione della giustizia in Roma”, (Roma : Bulzoni, 1976, p. 266)?
L’ultima sua opera, in ordine cronologico, sembra essere “Il binomio pubblico-privato nella storia del diritto” (Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1989, p. 211) che ha avuto due ristampe, la prima nel 1992, la seconda nel 1996, sempre nella collana delle pubblicazioni della Facolta giuridica perugina, segno di un lungo impegno accademico, ricambiato da indubbie soddisfazioni e dall’affetto dei suoi collaboratori.
Luca Pacciolla (1638-1706)
di
Massimo Guastella
Sesto di dieci fratelli, Luca Antonio Paciolla nasce a Mesagne il 9 dicembre 1638 da Giovanni Battista e Caterina Pagliara. Viene battezzato tre giorni dopo la nascita nella Collegiata da Padre Francesco Capodieci; suoi padrini sono: il medico Daniele Scoditti e Francesca Marina. La ricostruzione biografica, in attesa di rintracciare carte d’archivio relative alla sua vita, si fonda su poche notizie documentabili e sulle sue opere datate e firmate. Secondo la storiografia locale il suo apprendistato avviene probabilmente nelle botteghe di pittori mesagnesi. Intorno ai vent’anni e probabilmente dopo la peste del 1656 si recò a Napoli. Nella capitale lo ritroviamo, dopo aver completato la formazione e già artista autonomo, iscritto alla Congrega dei pittori dei SS. Anna e Luca a partire dal luglio 1665.
A Napoli sposa Geronima Sarsale, che gli dà cinque figli: Domenico, che si reca per un periodo imprecisato in Spagna; Giuseppe, che diviene teresiano scalzo col nome di frate Alessio Maria di Gesù e muore missionario nel Monte Libano; Gennaro, che a seconda delle fonti è teresiano scalzo con il nome di fra’ Filippo di San Nicola oppure terziario domenicano che si reca in Spagna e muore a Napoli nel 1702; Antonella, sposata in Roma; Nicola, religioso domenicano a Napoli con il nome di fra’ Pio. Luca nel 1687 è a Napoli per consegnare un quadro di palmi 3 x 2 1/2 raffigurante l’Annunziata per la costituzione di un fondo cassa necessario ad istituire un monte che assicurasse i maritaggi alle figlie dei pittori iscritti alla Congrega partenopea.
Negli ultimi cinque anni della sua vita, rimasto vedovo, è a Mesagne per periodi sempre più lunghi. Nel paese d’origine è mantenuto dal fratello don Giovanni Leonardo Paciolla, come documentato dal testamento di quest’ultimo, che lo assiste fino alla morte, avvenuta nel 1706 a Mesagne dove viene seppellito nella chiesa di Santa Maria in Behtlhem. Tra le sue opere sinora note, il primo dipinto che reca la firma “Lucas Paciolla” e la data 1685 è L’apparizione della Vergine col Bambino a San Filippo Neri allogata nella cappella adiacente la zona presbiteriale del Duomo di Lecce. Nello stesso anno data il dipinto raffigurante la Predica di San Giovanni Battista e committente fanciullo oggi custodita nei locali della sacrestia della chiesa del Gesù a Lecce, segnato in calce “Luca Paciolla /F.cit”. Sempre nella chiesa leccese del Gesù è l’autografa Vergine con il bambino e i santi Giovanni Battista e Pietro Celestino, databile tra la fine del ‘600 e gli inizi del secolo successivo.
L’ultima sua opera certa è la pala posta sull’altare della chiesa di Santa Maria Maggiore a Maratea; il dipinto, eseguito a olio su tavola, raffigura Maria Immacolata e reca la data 1690 e la firma “Lucas Paciolla”. Da un documento, pubblicato recentemente, si apprende che nel luglio 1696 furono terminati gli affreschi della Sala del Palazzo del principe Carmine de Angelis a Mesagne, eseguite dal Paciolla con l’aiuto del pittore mesagnese Domenico dello Monaco. I dipinti periziati dai pittori leccesi Oronzo e Aniello Letizia sono perduti a meno che non li si voglia riconoscere nella teoria di stemmi araldici irreparabilmente degradati e abbandonati ancora in sito nella Sala del Castello.
Altre opere presenti a Mesagne vengono dubitativamente accostati alla produzione di Luca Paciolla in attesa di una più approfondita conoscenza della sua attività. Per la bibliografia, si rimanda a quanto pubblicato in Note su Luca Paciolla con una aggiunta e alcune proposte, inserito nel volume in onore del 50° di sacerdozio di mons. Catarozzolo, “Duc in altum”.

(1525-1597)
di
Mario Vinci
Lucantonio Resta nacque in Mesagne da Donato e Virginia Vernai nel 1525, (in merito si veda: R. JURLARO, Ricerca genealogica sulla famiglia Resta, dattiloscritto presso la famiglia Braccio di Francavilla). La sua famiglia, originaria dalla Dalmazia, si stabilì dapprima a Ragusa (dove troviamo il ramo dei Resta di Ragusa) e successivamente alcuni di loro si trasferirono in Mesagne nei primi del 1500 con Mariano Resta:
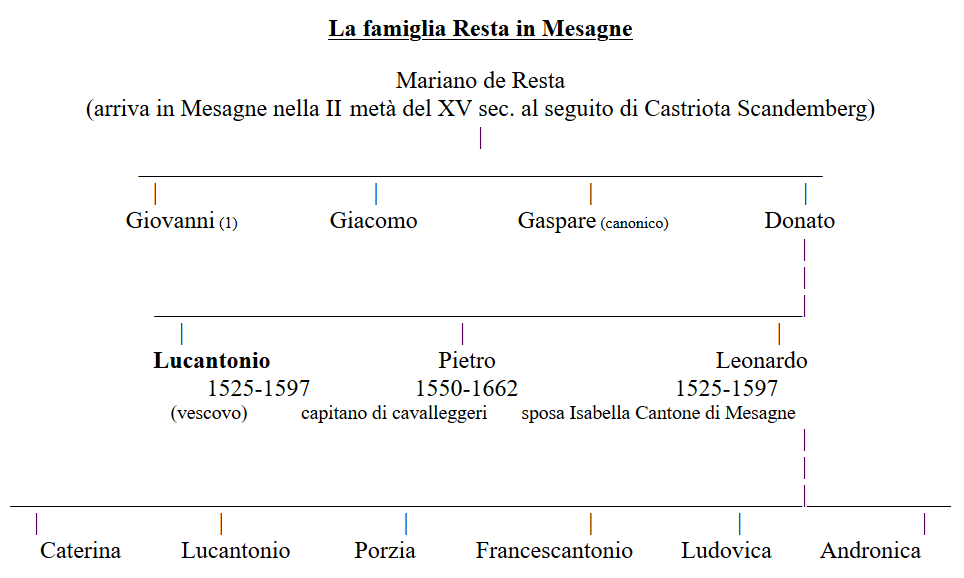
1593 – 1654
(1) da Giovanni si avrà il ramo di Francavilla
Sin da piccolo dimostrò inclinazione per gli studi umanistici ed il padre lo assecondò inviandolo a Nardò per apprendere la grammatica e le lettere, successivamente si trasferì a Napoli ove conseguì la laurea in scienze filosofiche e teologiche. Ritornato in Mesagne e resasi vacante la carica di arciprete di quella Collegiata vi concorse insieme a molti altri. Il Profilo (in Vie, Piazze, Vichi e corti….) afferma che la scelta cadde su Lucantonio Resta per le sue doti dottrinali e di bontà. Antonio Profilo dice anche che “in giovane età generò con donna libera quattro figli: Splandiano, Giovanni, Donato Orazio e Baldassarre”. In merito non abbiamo trovato documenti che potessero convalidare o smentire tale affermazione. Questo in ogni modo non pregiudicò al Resta di vestire l’abito talare, in quanto il Concilio di Trento solo nell’anno 1564 sancì il celibato dei chierici e quindi obbligatorio. La sua nomina ad arciprete avvenne nell’anno 1548, e fu in questo periodo che riuscì a conseguire la fiducia dei suoi cittadini, grazie soprattutto alla capacità di riuscire ad esprimere una forte carica spirituale, che si espresse nella realizzazione di molte opere, alleviando le sofferenze di molti fedeli, promuovendo la venuta a Mesagne dei Padri Cappuccini, offrendo loro protezione e contribuendo, con il suo denaro, alla edificazione del convento.
Si adoperò, anche, alla costruzione di un ospedale che potesse alleviare le sofferenze degli infermi, arricchì di molti paramenti la Sacrestia della Collegiata e alla stessa fece apportare sostanziali modifiche. Dimostrò particolare attenzione agli ammalati, ai quali esortò pazienza e devozione. Con il denaro che riuscì a raccogliere personalmente, insieme con altri nobili mesagnesi, fece costruire l’organo della Chiesa Matrice, per il quale furono spesi circa 700 ducati. Raccolse denaro e suppellettili sufficienti a maritare molte fanciulle povere. Fece eleggere sei persone che dovevano fare da pacieri per le liti che insorgevano e aiutò i frati dei cinque conventi esistenti in Mesagne nelle opere di carità. L’arcivescovo di Brindisi mons. Giovanni Carlo Bovio, il 26 ottobre del 1565 lo nominò vescovo di Castro. Resse come vicario anche la Chiesa Metropolitana di Otranto a causa dell’assenza di mons. Antonio de Capua, trattenuto tra i Padri del Concilio di Trento. Lucantonio Resta fu molto amico del vescovo di Nardò Cesare Bovio, fratello di Giovani Carlo, il quale lo onorò con alti incarichi. Durante un suo breve soggiorno a Mesagne, nel 1576, ebbe modo, mentre si celebrava la messa Pontificale dell’Ascensione e Pentecoste, di verificare l’esiguità di spazio a disposizione dei fedeli presenti e si adoperò affinché l’Università provvedesse ad apportare delle modifiche, spostando il Coro alle spalle dell’altare maggiore, nel contempo fece costruire sotto lo stesso, una Cappella dedicandola al SS. Crocifisso e decorandola con stucchi pregiati e reliquie di molti Santi, fondando anche un beneficio, di patronato della sua famiglia.
Durante la permanenza a Castro, Lucantonio Resta fu oggetto di accuse verbali e di vere persecuzioni da parte di alcuni maldicenti, probabilmente a causa del trasferimento della sede vescovile nella vicina Poggiardo, dovuta a motivi di sicurezza per le numerose incursioni dei turchi sulle coste salentini. Gli storici locali adducono anche un’altra motivazione, forse più attendibile, almeno a dire del Profilo, il quale dice che il Resta cadde in sospetto di luteranesimo e che non volle sottomettersi ai decreti tridentini per quanto concerne il celibato dei chierici e per questo la Curia romana lo assoggettò a procedimento inquisitorio. Le conferme di queste incomprensioni potrebbero ricercarsi nella corrispondenza che mons. Resta ebbe con Carlo Borromeo, allora Segretario di Stato del pontefice Pio IV. In una di queste lettere, infatti, si legge della disastrata condizione economica della diocesi di Castro, da molti anni abbandonata e distrutta dalle incursioni del 1537. È da ritenere, pertanto, che le incomprensioni tra clero, cittadini e il Resta furono frutto di pettegolezzi ben orchestrati, messi in giro da qualcuno cui mons. Resta risultava scomodo. È da evidenziare, anche, il fatto che molti si consacravano al sacerdozio non certo per spirito di vocazione, ma perché spinti da interessi materiali, sia economici che di prestigio sociale, dal momento che il clero era esentato da ogni gabella e godeva di immunità di ogni genere.
I mesagnesi, venuti a conoscenza delle offese rivolte al loro illustre concittadino, pensarono di dargli un valido aiuto attestando, in pubblico parlamento del 10 febbraio del 1578, con il sindaco, gli eletti e gli auditori, le doti e le opere realizzate in Mesagne da Lucantonio Resta. L’11 agosto del 1578 fu trasferito nella Diocesi di Nicotera. Vi rimase per tre anni, vi tenne due sinodi ed effettuò più volte delle visite pastorali nella diocesi. Nel 1580 intervenne al sinodo provinciale di Reggio. Il 30 aprile del 1582 Papa Gregorio XIII (1572-1585) decise di nominarlo Vescovo di Andria, per migliorarne le sue condizioni e per gratificarlo rispetto alle precedenti sedi assegnatole. “Mons. Resta fu uomo d’alta mente, di singolare santità e di straordinaria erudizione”, così esordisce il canonico Agresti nell’introdurre Lucantonio Resta nuovo vescovo di Andria. Appena arrivato in quella città diede alle stampe il libro “Costitutiones Diocesanae Synodi Andria Anno Christi 1582”. Con la pubblicazione di questo libro, mons. Resta si proponeva di attuare una riforma dei costumi, troppo libertini in quella diocesi. Infatti appena giunto in Andria aveva appreso di alcuni processi a carico di prelati, pendenti presso la curia; il duca Fabrizio II Carafa aveva furbescamente fatto sottrarre e sequestrare le carte di questi processi per coprire i gravi delitti di cui si erano macchiati i preti della diocesi. Ebbe, così, inizio una dura lotta tra il duca Carafa e mons. Resta, il quale fu indotto a ricorrere a papa Clemente VIII, che rivolse severi rimproveri al duca minacciandolo delle pene canoniche.
Il libro divenne celebre nella storia della Chiesa, fu stampato ed emendato dalla Santa Congregazione del Concilio ed inserito nell’ultima edizione dei Concili. Nel 1586 dava alle stampe la messa e l’intero Ufficio del Protettore S. Riccardo. Nel 1593 per i tipi Guglielmo Facciotti di Roma pubblicò la sua opera più importante “Directorium Visitatorum ac Visitandorum cum praxi, et formula generalis Visitationis”, una guida ai vescovi nelle loro visite pastorali. Nell’opera venivano anche inserite le regole da lui dettate per le monache Benedettine di Andria. Nel 1592 fu affetto da una grave calcolosi renale e, ritenendosi in pericolo di vita, invocò la grazia di S. Maria dei Miracoli di Andria. Riuscì ad espellere i calcoli e, considerandolo un miracolo, volle ringraziare la Vergine con pubbliche manifestazioni e processioni. Fece finanche costruire a proprie spese in Mesagne la chiesetta dedicata alla Vergine dei Miracoli nel nascente Borgo nuovo. In Andria costituì invece la Confraternita dedicata sempre alla stessa Vergine. Dopo una vita spesa al servizio della Chiesa e dei fedeli, si spense in Andria nel 1597. La sua salma fu seppellita nella Cappella di San Giuseppe in Andria.
In Mesagne non esiste più niente che possa testimoniare i fasti della nobile famiglia Resta e dello stesso Lucantonio. Le uniche cose ancora visibili che, per inciso, meriterebbero un adeguato restauro, sono due stemmi rimossi dal loro sito originale ed inseriti su nuovi edifici. Il primo lo troviamo sul portale del palazzo del XVII secolo, sito in Via Albricci, al civico 26, proprietà Scazzeri; l’altro stemma è poco distante dal precedente e si trova nella costruzione del XVIII secolo, ad angolo tra vico Braccio e Via Albricci al civico 35, di proprietà eredi Pasimeni. Su entrambi gli stemmi sono raffigurate le insegne araldiche di mons. Resta: di azzurro alla fascia arcuata di oro caricata del motto CHARITAS in lettere nere e accompagnate nel capo, a destra, dalla croce d’oro di Malta e, a sinistra, da una stella di otto raggi dello stesso, mentre, in punta, da una armatura d’argento. Non molto lontano da questa via, precisamente in via A. Profilo vi era il sontuoso palazzo appartenente alla famiglia Resta, demolito agli inizi degli anni sessanta per far posto ad un’area di parcheggio a servizio di una banca, senza che gli organi preposti alla salvaguardia dei beni architettonici e culturali opponessero alcuna resistenza. Un grido d’allarme, per il danno che si stava perpetrando, fu lanciato dallo storico mesagnese Antonio Franco con un articolo apparso sul “Corriere del Giorno” di Taranto del 27 dicembre 1963: «Così vengono curati i nostri antichi monumenti – A Mesagne per costruire una banca è stato abbattuto un palazzo del ‘500». A noi oggi non resta che un disegno, eseguito dal pittore francavillese Augusto Camassa. Una pregevolissima tela raffigurante monsignor Lucantonio Resta in abiti episcopali, di dimensioni naturali, è, invece conservata nell’antico palazzo Resta di Francavilla Fontana, proprietà Braccio. L’opera fu eseguita dal pittore Vincenzo Zingaropoli (1779-1836), e in basso a destra è riportata l’arma araldica dei Resta, mentre sulla sinistra vi è una legenda, ricavata dallo Zingaropoli quasi certamente da una vecchia pergamena.
Giovanni Rini (1836-1919)
di
Angelo Catarozzolo
Un palazzo in degrado in piazza IV Novembre, una fondazione benefica nota solo agli “addetti ai lavori”, è quanto restava fino a pochi anni fa della munificenza di un nobiluomo mesagnese, il cav. Giovanni Rini. Finalmente su quell’edificio restaurato è stata posta una lapide con il suo nome e l’Opera, da lui voluta a sostegno delle fanciulle rimaste orfane, è stata ripresa con attività sociali consone al volontariato del nostro tempo, grazie all’attuale consiglio di amministrazione. Ma della figura di Giovanni Rini manca un riferimento documentale che vada oltre i beni patrimoniali legati all’istituzione umanitaria e gli scarni dati anagrafici. Unico documento nel quale si possa cercare di “leggere” la sua personalità è il testamento istitutivo dell’ «Ente Rini-Scazzeri». Un suo profilo biografico si può delineare dallo spirito che pervade le articolate disposizioni testamentarie, dalle quali emerge indubbiamente la delicatezza dei sentimenti del suo nobile animo verso le creature provate dalla privazione degli affetti più cari e perciò esposte ai rischi e ai pericoli di una possibile emarginazione. Il suo gesto di attenzione umanitaria verso i minori è mirabile testimonianza cristiana di grande attualità, considerando quanto accade oggi nei confronti proprio di fanciulli e adolescenti.
Giovanni Rini, nacque a Mesagne l’11 settembre 1836 da Giuseppe e Teresa Piccinni. Al fonte battesimale ricevette i nomi di Giovanni Battista Antonio. La scheda anagrafica municipale annota: “Cavaliere della Corona d’Italia”. Le ricerche sino ad ora effettuate sulla sua personalità non hanno dato alcun utile risultato, e né ci sarebbe una sua fotografia, se le nipoti – le signorine Caterina e Raffaella Scazzeri – non l’avessero offerta. A loro, poi, va un particolare ringraziamento per il dono del bass9rllievo marmoreo dell’artista mesagnese Cesare Marino, ora collocato nella sede dell’Ente. Egli, dunque, gentiluomo mesagnese, emerse per censo e condizione sociale e si distinse per la nobiltà più vera, quella del cuore. Ebbe palpiti di paterna tenerezza per le fanciulle, provate dalla carenza degli affetti domestici, e pensò di accoglierle nella propria casa istituendo l’«Orfanotrofio de’ coniugi Rini e Scazzeri» (Testamento redatto il 4 maggio 1915).
Dotato di sani principi morali, indicò la finalità dell’opera “per l’educazione cattolica e civile delle orfanelle”, da istruire con la scuola primaria e professionale, e fornirle di dote, sedi buona condotta. Riscosse profonda stima per l’esemplarità dei costumi e semplicità di vita; breve e significativa, dunque, è la dedica nel ricordino di morte: “Dagli onesti rimpianto”. Avvertì con coscienza civica il senso dello Stato nell’Italia risorgimentale e democratica, e nell’atto costitutivo dell’opera fece chiaro riferimento alle istituzioni ecclesiastiche e civili. Scelse tuttavia il regime dell’autonomia per la fondazione, così come precisa nel testamento: “L’Istituto sarà Ente morale autonomo, soggetto alle disposizioni del Codice civile e delle leggi ecclesiastiche; ma assolutamente indipendente dalla Legge sulle Opere pie (IPAB) e da quelle affini, sia presenti che future”.
Fu cattolico convinto e coerente, come si evince dalla scelta dell’indirizzo educativo da dare alle convittrici: volle che la loro formazione fosse affidata alle suore della carità, cui affidava la direzione dell’Istituto, e riservò la presidenza e la sorveglianza all’Arcivescovo di Brindisi. La configurazione giuridico-cattolica dell’Ente viene confermata dalla clausola: “se si tenterà di mutare l’indirizzo cattolico o di sopprimerlo, il patrimonio passerà al Romano Pontefice che nomino fin da ora erede”. Sposo affettuoso, lasciò alla consorte la completa fruizione del patrimonio dell’Istituto “vita natural durante”, e la piena proprietà degli altri beni. Onorò i vincoli parentali, disponendo un vitalizio per la sorella Concetta e costituì legati di benefici spirituali per i genitori, per i fratelli Gaetano, Saverio, Adelaide, oltre che per sé e per la moglie. Manifestò ancora amore per la cultura e “legò a favore della Biblioteca «Ugo Granafei» l’intera libreria contenuta in due scaffali con la targa: Libreria Cav. Giovanni Rini“. Le numerose citazioni, attinte dalle volontà espresse dal testatore, offrono, dunque, una possibile lettura della personalità di Giovanni Rini, del culto che egli ebbe per i valori umani e cristiani, intrisi di fede e di morale, di giustizia e di solidarietà.
Morì il 29 aprile 1919. La fondazione eretta Ente Morale con Regio Decreto del 20 Novembre 1931 n. 1717 ed iscritta al Registro delle Persone giuridiche al Tribunale di Brindisi il 24 febbraio 1989, n. 155, fu resa autonoma, secondo il suo desiderio, con il decreto di privatizzazione della Regione Puglia del 22 aprile 1992, n. 99. Compagna della sua vita fu la nobildonna brindisina Raffaella Scazzeri, figlia di Gaetano e di Anna Mugnozza, nata il 3 settembre 1863 e deceduta in Mesagne il 15ottobre 1951. Di lei, tumulata nella tomba di famiglia, sulla lapide cimiteriale, tuttora esistente é stato scritto: “Unico scopo della sua lunga vita fu fare del bene e vi riuscì”. Il culto del focolare domestico vissuto nella comunione sponsale accrebbe la sensibilità di Giovanni Rini verso i minori provati dalle sofferenze della vita, a causa della privazione dei genitori.
Qualche anno prima di tale ultimo atto giuridico tuttavia è iniziato un faticoso lavoro a tutela del patrimonio dell’Ente con il recupero di beni immobili in città e di fondi rustici, destinati al degrado. Prima che all’incedere del tempo, tuttavia, per tutelare il patrimonio dell’Ente si dovette fare fronte all’assalto degli uomini che, nei primi decenni del secolo, poco oltre la morte del benefattore, tentarono di far annullare alcune volontà del defunto e di svilire quindi l’intero suo atto di ultima volontà (cfr. deliberazione n. 23 della Congregazione di Carità del 16 aprile 1925, nella trascrizione di Antonio Pasimeni).

(1897-1937)
di
Dino Levante
Il 26 marzo 1937 la Prefettura di Lecce invia a Roma, tanto alla Divisione di polizia politica quanto alla Direzione generale di Pubblica sicurezza, Divisione Affari generali e riservati, Casellario politico centrale del Ministero dell’interno, una informativa con oggetto: Radiotrasmissioni da Barcellona [1]. Nella comunicazione si fa riferimento ad una intercettazione radiofonica effettuata dal locale comando della 152ª Legione della Milizia volontaria sicurezza nazionale e si afferma che
“[…] ieri 21 corrente, da un apparecchio radio a 7 valvole, alle ore 23.45, sono state intercettate trasmissioni provenienti da Barcellona da una stazione ad onde corte sulla lunghezza di m 28. Le notizie furono trasmesse in lingua italiana ed alla stazione trasmittente si qualificò il fuoriuscito italiano Refolo Pietro [2] […]. Il detto Refolo Pietro ha dapprima commemorato un compagno comunista caduto in Ispagna in combattimento e poi ha letto un elenco di prigionieri italiani volontari combattenti, citando nome, cognome, luogo di origine fra cui due provinciali, uno di Melissano. Ha assicurato che detti prigionieri hanno fra i rossi ottimo trattamento che sarà pure riserbato ad eventuali altri prigionieri che potessero essere catturati. Ha pregato, infine, i radioascoltatori di avvisare di ciò le famiglie […]”.
Sempre in quella relazione il prefetto di Lecce, Pietro Bruno, afferma poi che “da corrispondenza testé inviata dai familiari, il noto fuoriuscito Refolo Pietro sarebbe tuttora residente a rue de Belleville 118, Paris, XX” e lo stesso indirizzo viene confermato anche nella lettera che il 4 aprile 1937 sempre la prefettura leccese invia nuovamente al competente Ministero “per cui lo stesso, non può aver parlato alla radio da Barcellona, la sera del 21 detto mese”; coglie comunque l’occasione per trasmettere uno stralcio della lettera inviata da Refolo alla moglie e proveniente da Parigi con la data 30 marzo 1937. Questo il brano: «Mi figuro quale sarà stata la tua sorpresa… e quella degli altri per la comunicazione della radio. A dirti il vero pero non so proprio come sia avvenuto ciò. Intanto sappi che i! morto non è Santo Semeraro, ma bensì il suo povero cugino Eugenio Santacesaria il quale, partito volontario in Spagna, è caduto pochi giorni dopo [essere] arrivato. Essendo il più anziano dei suoi comprovinciali ebbi il doloroso incarico di dire di lui a quelli che son restati» [3].
Nel carteggio di Pietro Refolo, attualmente custodito presso la “Bibliotheca Minima” di Novoli, è conservato un ritaglio di giornale (probabilmente si tratta dell’“Avanti!” del 7 marzo 1937), con il suo articolo commemorativo dal titolo Ricordi su “Carloni”, nomi di battaglia di Eugenio Santacesaria, che qui riportiamo integralmente:
«Ricordo come se fosse ieri il nostro primo incontro. Fu in un convegno del Partito socialista, verso la fine del 19 20. Avevi finito allora, Carloni, il tuo servizio militare nella Marina ed eri entrato nel movimento socialista con tutto l’ardore dei tuoi vent’anni, ma con la convinzione di un uomo maturo. Eri tornato dal Mar Nero ove avesti occasione – specie ad Odessa – di constatare con quanto entusiasmo si battevano i proletari russi contro le forze organizzate della reazione internazionale e pel trionfo della rivoluzione bolscevica. Non volesti restartene appartato e ti lanciasti a capofitto nel movimento con la sicurezza di compiere il tuo dovere. Ti ebbi cosi, quasi sempre, al mio fianco, il più audace e il più fido, in ogni occasione, in ogni battaglia, circondato sempre dall’affetto e dalla stima dei più vecchi i quali avevano riscontrato in te tutte le qualità di un futuro capo. Ma tu te la ridevi, sempre indifferente a tutti gli elogi, eri orgoglioso solo della grande opera compiuta, insieme a pochissimi altri nella tua Mesagne (in provincia di Bari) [sic], in quella Mesagne che da feudo riservato a pochi detentori di ricchezze, era diventata una delle città rosse della rossa Puglia. Passarono alcuni anni…, e quando tutta l’Italia ufficiale era già sottomessa al fascismo, la tua Mesagne non voleva cedere e non cedeva. Così arrivammo all’11 novembre del 1924. Il fascismo da oltre due anni deteneva il potere, e voleva che anche Mesagne si sottomettesse. L’11 novembre, giorno di «festa nazionale», era stato scelto per «fare il colpo», ma tu ed i pochi che erano rimasti fidi lo avevate preveduto ed avevate prese tutte le misure necessarie per contrapporvi con la forza. Indimenticabile gloriosa giornata. Il suono di Giovinezza si tramutò nel suono di Bandiera Rossa. La sede del fascio fu invasa; i contadini, da te diretti, erano ridivenuti i veri ed autentici padroni della loro cittadina. Dopo un’ora, a cercarlo con la lanterna di Diogene, in tutta Mesagne non si trovava più un fascista; erano tutti scappati. Poi… poi le centurie fasciste, ma a centinaia e centinaia, carabinieri, poliziotti e soldati invasero la tua bella cittadina, e la reazione fu terribile. Venisti all’estero, ma l’ira della reazione ti perseguitava anche in terra straniera, e fosti espulso da due o tre paesi. Col nome di Carloni che allora assumesti impararono ad amarti tutti i compagni; con questo nome continuasti a militare nelle file del Partito massimalista fino al giorno in cui, per l’entusiastica adesione data al Fronte unico, non fosti messo alla porta, insieme ad altri compagni i quali come te credevano e credono alla possibilità della unificazione di tutte le forze sane del nostro paese. Incapace di vivere senza la disciplina ferrea di un partito, ritenesti tuo dovere iscriverti al Partito comunista nel quale in pochissimo tempo non ti fu difficile accattivarti la stima ed il rispetto dei capi. E quando il popolo spagnolo fu costretto a prendere le armi per la difesa delle sue libertà, tu mi dicesti: «Il mio posto è in Spagna». Non appena arrivato in Ispagna stessa, tu chiedesti, con insistenza, di essere inviato sulla linea del fuoco. Il tuo desiderio fu soddisfatto, il tuo voto fu esaudito. E sei caduto, come cadono gli eroi, come seppero cadere nel passato i vecchi garibaldini: con la convinzione che dal tuo sangue versato per difendere la libertà della martoriata Spagna, germoglieranno altri mille e mille eroi che conquisteranno le libertà perdute dal nostro povero paese. Eugenio – ti chiamo oggi cosi come sempre ti ho chiamato -, il vuoto che tu ci lasci è immensamente grande, come grande è il sacrificio che tu hai compiuto. I compagni del Fronte Unico di Montmartre, quelli della Sezione XVIII dell’A.F.I.A.C. [Associazione franco-italiana antifascisti combattenti], tutti i militanti politici, tutti gli antifascisti oggi hanno scritto il tuo nome nel libro d’oro degli eroi. Io – pur essendo orgoglioso del tuo sacrificio eroico – trascinerò nei giorni che mi restano quello che è stato e rimarrà il più tremendo dolore della mia vita: il dolore della tua scomparsa. Eugenio addio!».
Abbiamo cominciato questo contributo su Eugenio Santacesaria con il lungo “ricordo” di Pietro Refolo, pubblicato nel 1937, per due motivi: primo, far immergere direttamente il lettore in quello che era il clima politico nel quale ha operato l’esponente mesagnese, iniziando proprio dalla morte; secondo, perché da quello stesso 1924, ricordato da Refolo nel suo articolo, parte anche la documentazione sul conto di Santacesaria conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato a Roma [4]. Sebbene dalla citata testimonianza di Refolo sappiamo che già “verso la fine del 1920” Santacesaria avesse partecipato ad un convegno del Partito socialista italiano, resta comunque incolmabile il vuoto per gli anni che vanno dal 1920 al 1924. Né la documentazione consultata ha fornito ulteriori elementi che potessero chiarirci quegli avvenimenti mesagnesi dell’11novembre 1924 ricordati da Refolo. Il fascicolo del Casellario politico centrale venne redatto il 10 agosto del 1925 dalla Prefettura di Lecce ma già al suo interno conteneva una prima segnalazione prefettizia nella quale si informava il Ministero dell’interno che il 16 dicembre 1924 il “sovversivo” Santacesaria “intervenne ad una riunione indetta fuori porta Napoli di quella città, nell’abitazione dell’amante del compagno di fede Monaco Ippazio, ma per l’intervento della polizia non ebbe luogo”. Dopo quattro giorni la Divisione affari generali e riservati del Ministero, in seguito a quanto riferito, chiede al prefetto leccese di disporre nei riguardi di Santacesaria “una conveniente ed oculata vigilanza, e di provvedere, nel caso diventasse elemento pericoloso, alla compilazione e trasmissione della di lui scheda biografica, corredata del relativo ritratto fotografico” [5]. Il prefetto di Lecce, Augusto Marri, invia quanto richiesto da Roma con lettera del 10 agosto 1925, cioè le informazioni ricevute dalla Sottoprefettura di Brindisi.
Eugenio Santacesaria, di Vito e Addolorata Semeraro, nato a Mesagne il 1° giugno 1897, di professione elettricista, viene definito “comunista”, ma anche “socialista massimalista” ed il fascicolo personale contiene inoltre altre qualifiche e indicazioni tra le quali quelle di “attentatore”, “pericoloso”, da “fermare” e “arrestare”, “iscritto nella Rubrica di frontiera” e nel “Bollettino ricerche”, strumenti, questi ultimi, destinati alle forze dell’ordine di frontiera impegnate nel rintracciare i rifugiati politici all’estero. La Scuola di polizia scientifica il 23 agosto 1925 provvede intanto a riprodurre, in sei copie, la fotografia di Santacesaria inviata da Lecce a Roma, in modo che si possa distribuire ad agenti e “fiduciari” al fine di ottenere notizie sul conto del sorvegliato che risultava già residente all’estero. Ed una prima conferma che lo schedato Santacesaria, alias “Raschidieddu” (probabile soprannome dialettale), si trovi fuori dall’Italia, si ha il 16 marzo 1928 quando il primo prefetto di Brindisi, Ernesto Perez, comunica a Roma che “attualmente trovasi nel Lussemburgo, e propriamente ad Esch, unitamente al suo compagno di fede Giovanni Poci”. Di conseguenza il 28 marzo il Ministero chiede alla R. Legazione italiana a Lussemburgo di “disporne il rintraccio e la vigilanza informando poi […] sull’attività politica che esplica nel Granducato”. Il 3 aprile 1928 il direttore capo della divisione di polizia politica invia un appunto alla Divisione Affari generali e riservati del Ministero riferendo che “nella revisione della corrispondenza postale la R. Prefettura di Brindisi ha rinvenuto una lettera, che si acclude in copia, del comunista Santacesaria Eugenio di Vito da Mesagne, residente nel Lussemburgo e diretta al fratello Americo, operaio presso quel deposito locomotive. Essa è stata trattenuta perché contiene frasi offensive per il regime […]. La lettera, inviata effettivamente da Esch, porta la data 6 marzo 1928 e contiene tre messaggi indirizzati al padre, alle sorelle e al fratello Americo. Questo il testo:
«Carissimo padre, ricevetti la vostra ultima a Bruxelles e non risposi subito perché avevo intenzione di venirmene qui. Ho cambiato di residenza ed anche di stato per essere insieme a Nino Poci. Qui la vita è migliore che a Bruxelles, si guadagna di più e si può mangiare la cucina italiana. Mi accennate della procura, vi feci sapere che ci vogliono circa 200 FR. ed io non sono affatto disposto a regalare questa somma proprio a chi 200 meriterebbero pallottole nello stomaco. Io sto bene, mi auguro che anche voi stiate bene. Indirizzate: 36 Rue Adolf Emil, Esch s/Alz (Luxemburg) Saluti e abbracci a tutti.
Carissime sorelle, se vi si darà l’occasione di incontrare qualcuna delle sorelle di Nino gli direte che non si preoccupassero affatto per lui, perché ritornerà quando potrà ritornare senza alcuna molestia Perciò non insistessero affatto sul suo ritorno, poiché sarebbe insensato solamente il pensarlo. Loro vivono nelle nuvole e non vedono neanche ad un palmo di distanza dal loro naso. Credo che quando si è tanto ingenui non vale la pena neanche di vivere. Inoltre gli farete questa domanda: preferiscono saperlo qui in buona salute al sicuro di certi mali, oppure in Italia in qualche luogo poco igienico per la salute pubblica? E intanto gli farete i miei saluti.
Carissimo fratello, ti sei spinnacchiato per la lettera smarrita? e se anche sia andata a finire nelle mani di quell’idiota e imbecille, cosa vuoi che ne faccia? Gli potrà servire ad un servizio e cioè quello del … Lui è stato l’ultimo a conoscere il mio indirizzo, figurati che anche il portinaio della Prefettura lo sapeva. Hai forse paura che mi inviasse qualche spedizione punitiva? Più di quello che mi hanno fatto non potevano farmi. Ma ormai ci sono tanto abituato che non mi fa più caso, arrabbiarsi per cosi poco non ne vale proprio la pena. Finiranno per stufarsi. Con un’altra mia ti domandavo se ti sei fissato a Brindisi oppure a Mesagne, e dove abiti, ma intanto ti sei sempre dimenticato rispondermi su questo soggetto. Non mi prolungo perché ho sonno. Abbiti i più affettuosi saluti unitamente a tua moglie
aff.mo Eugenio».
Il 7 aprile 1928 il Ministero dell’interno invia due lettere, nella prima comunica il nuovo indirizzo di Santacesaria alla rappresentanza italiana a Lussemburgo per le opportune verifiche, mentre nella seconda sollecita la Prefettura di Brindisi affinché informi sui “precedenti politici e sociali dell’operaio presso codesto deposito locomotive Santacesaria Americo, fratello al noto comunista Eugenio attualmente nel Lussemburgo”. A quest’ultima richiesta ministeriale il prefetto brindisino risponde il 17 aprile informando che Americo Santacesaria “è di buona condotta morale mentre politicamente ha professato principi sovversivi. Appartiene a famiglia i di cui componenti, ad eccezione di qualcuno, sono sovversivi ed uno, Eugenio, fuoriuscito, trovasi attualmente nel Lussemburgo. Il Santacesaria Americo è operaio aggiustatore presso il locale deposito locomotive ed è iscritto alla Sezione dei ferrovieri fascisti. Attualmente non esplica alcuna attività e tiene contegno molto riserbato”. La conferma della residenza lussemburghese di Eugenio Santacesaria giunge a Roma il 20 aprile dalla Regia Legazione d’Italia a Lussemburgo la quale tiene a precisare che il socialista è giunto ad Esch sur Alzette il 12 marzo dello stesso anno e a rassicurare il Ministero che non mancherà di segnalare ogni rilievo sul suo conto. Di quest’ultima notizia l’8 maggio 1928 il ministero mette a conoscenza anche il prefetto di Brindisi. Ma l’opera d’informazione sul conto dei componenti la famiglia Santacesaria non termina con le notizie su Americo. Infatti il 26 aprile la Prefettura brindisina invia al Ministero un’altra scheda. Essa inizia soffermandosi su Domenico, nato a Mesagne l’8 ottobre 1881, del quale afferma che «[…] per il passato era ritenuto in pubblico di idee sovversive, anche perché, nelle elezioni amministrative svoltesi in Mesagne nel 1921, fu eletto consigliere comunale nella lista dei candidati socialisti. Dopo l’avvento del fascismo insieme ad altri consiglieri della maggioranza fece domanda per essere iscritto al Partito nazionale fascista, ma la sua richiesta venne respinta per i precedenti politici suoi e della sua famiglia. Difatti, il fratello Eugenio, già emigrato in Francia ed attualmente nel Lussemburgo, è notoriamente sovversivo, e fa parte del gruppo fuoriusciti; il fratello Ernesto per un certo tempo, fu inscritto al Pnf ma, dopo qualche anno, fu espulso per indisciplina, ed un altro fratello a nome Americo, operaio aggiustatore presso il deposito locomotive di Brindisi, per il passato, ma non apertamente, si dimostrò ostile al fascismo. Nel luglio 1926, in una perquisizione nell’abitazione del padre furono rinvenute nascoste n. 5 fotografie del defunto on.le Giacomo Matteotti, un opuscolo intitolato “La mano occulta della massoneria” ed altro sulla rivoluzione russa, nonché molte copie del giornale “Avanti!”».
Che Eugenio Santacesaria sia un “sovversivo pericoloso, perché dotato di buona intelligenza e gode ascendente nelle masse”, lo conferma il 7 maggio 1928 il prefetto di Brindisi, Perez, al Ministero dell’Interno in una comunicazione nella quale si fa pure riferimento alla sua permanenza all’estero scrivendo che “[…] Dopo l’avvento del fascismo al governo, emigrò in Francia e dopo qualche tempo ritornò a Mesagne continuando a svolgere propaganda antinazionale. Vistosi però attentamente vigilato nel 1926 ritornò in Francia ed attualmente trovasi ad Esch nel Lussemburgo”. Uguale informazione viene poi inviata da Roma al R. Consolato Generale d’Italia a Charleroi il 22 maggio 1928. Continuano gli accertamenti sulla famiglia Santacesaria: il 30 agosto 1928, sempre la Prefettura brindisina invia al ministero una nota informativa a proposito di un’istanza (forse d’iscrizione al Pnf) a firma di Domenico Santacesaria, “facendo presente che, dagli accertamenti eseguiti, è risultato che in passato la famiglia del ricorrente, specialmente prima della morte del padre, era ritenuta sovversiva anche perché, proprio il Domenico fu consigliere di maggioranza nell’amministrazione socialista del Comune di Mesagne. Attualmente però i fratelli Santacesaria, residenti in detto comune, non danno motivo a sospetto sulla loro condotta politica ed anzi si sforzano di dimostrarsi fedeli al regime. Il Santacesaria Domenico, chiese, nel 1925, l’iscrizione al Partito fascista, ma la sua domanda non venne accolta. Il fratello Ernesto é iscritto al Partito fascista di Bari. Il fratello Americo, operaio meccanico presso questo deposito locomotive é iscritto a questa sezione ferrovieri fascisti. Gli altri fratelli, Armando e Vincenzo, non hanno precedenti politici. L’unico effettivamente sovversivo è il fratello Eugenio, che trovasi fuoriuscito in Francia. Un altro fratello, a nome Cosimo, è sottufficiale nella R. Marina. Per quanto sopra si può concludere che attualmente i fratelli Santacesaria residenti a Mesagne non sono da ritenersi elementi sospetti”. Il 6 settembre 1928 la Regia Legazione d’Italia a Lussemburgo informa il Ministero romano che il “comunista” Eugenio Santacesaria “è stato espulso da questo Granducato l’8 agosto scorso, per mene comuniste e perché già espulso dalla Francia e dal Belgio. Credo ch’egli si sia diretto nella Sarre”. Al R. Consolato italiano a Metz chiede informazioni il Ministero dell’Interno, inviando anche una riproduzione fotografica, il 24 novembre 1928, pregandolo “di disporre il rintraccio e la possibile vigilanza riferendo ogni utile conseguenza”. Nella stessa lettera viene richiesta alla Prefettura brindisina “la inserzione nella rubrica di frontiera per fermo, perquisizione e vigilanza nel caso di rientro” in Italia, provvedimento che da Brindisi viene confermato come già adottato con missiva del 3 dicembre 1928. Intanto il 18 agosto 1929 il Ministero dell’interno scrive nuovamente al R. Consolato italiano a Metz chiedendo di fornire sollecito riscontro alla richiesta di informazioni già inoltrata nel novembre dell’anno precedente.
Il compito degli organismi repressivi italiani, specialmente all’estero, non è tra i più facili e lo si evince da una fitta corrispondenza dagli esiti negativi tra Ministero, Consolati, Legazioni. Eugenio Santacesaria resta “irraggiungibile”, sebbene la sua presenza venga segnalata in più di un Paese. Il 25 novembre 1929 lo “schedato comunista” risulta espulso dalla Francia. Un ulteriore sollecito al R. Consolato italiano a Metz viene intanto inviato il 31 gennaio 1930 e da questi giunge risposta al Ministero il 14 marzo anno VIII. Il console nella lettera afferma che “malgrado le continue attive ricerche fatte esperire nel territorio della Saar (o Sarre?) non mi è stato finora possibile rintracciare l’individuo in parola. Non è escluso che egli si trovi egualmente in detto territorio nascondendosi sotto false generalità, come è pure ammissibile che egli non abbia fatto alcuna dichiarazione di residenza presso le locali autorità, ciò che rende estremamente difficile il suo rintraccio. Egli rimane nondimeno iscritto nella rubrica ricerche di questo R. Ufficio e mi farò premura di informare l’E.V. sulle eventuali emergenze”. Il 3 maggio 1930 al Ministero dell’Interno giunge una lista di comunisti residenti nel Belgio inviata al Ministero degli affari esteri dal R. Ambasciatore in Polonia, elenco fornito all’addetto militare a Varsavia dall’Ufficio informazioni dello Stato maggiore polacco. Nella lista di oltre 200 nominativi risulta iscritto Eugenio Santacesaria. Anche dal console generale a Parigi, il 5 maggio 1930, giunge la segnalazione al Ministero degli Esteri e da questo al quello dell’Interno che Santacesaria risulta tra gli iscritti alla sezione di Parigi del Psi. Il 10 maggio il prefetto di Brindisi, Perez, comunica che “malgrado le indagini e le più particolari ricerche esperite non è stato possibile precisare l’esatto recapito del comunista Santacesaria Eugenio fu Vito. Vuolsi risieda a Marsiglia o a Lione, ma ciò non è stato possibile assodare con dati di fatto, poiché egli non scrive nemmeno ai parenti da parecchio tempo”. Nella documentazione conservata nel fascicolo intestato a Eugenio Santacesaria vi è anche una “informazione confidenziale” datata 12 marzo 1930 della Divisione di polizia politica giunta al Ministero dell’interno il 12 maggio 1930; nel documento sono riportati i componenti la sezione del PSI di Parigi [6] e tra questi non compare Santacesaria sebbene vi sia un non meglio identificato Mario Canoni (in un ulteriore elenco del 17 maggio 1930 non risulta avere precedenti né negli atti del Consolato né in quelli dell’Ambasciata). Prende dunque consistenza l’ipotesi già avanzata dal console italiano a Metz, che cioè Eugenio Santacesaria vada ricercato sotto altre generalità, deduzione alquanto semplice ma per giungere alla quale i primi elementi arrivano dopo quasi sei anni di ricerche dagli esiti non proprio soddisfacenti. Il Ministero dell’interno il 15 giugno 1930 chiede all’Ambasciata italiana a Parigi di “voler disporre indagini per conoscere le complete generalità e luogo di nascita” del non meglio identificato Mario Carloni che risulta iscritto alla sezione del PSI di Parigi. Intanto, per facilitare le previste ricerche all’estero, lo stesso ministero il 25 giugno 1930 si preoccupa di far riprodurre in 10 copie la fotografia di Eugenio Santacesaria dalla Scuola superiore di polizia a Roma.
Il 3 luglio 1930 giunge al Ministero dell’interno la lettera datata 20 giugno 1930, con la quale il console d’Italia a Marsiglia comunica a Roma “che malgrado le più accurate indagini esperite non si è potuto addivenire al rintraccio del comunista schedato”. Manca ancora una risposta alla richiesta di informazioni inoltrata al Consolato a Lione ed il Ministero sollecita un riscontro il 7 luglio l93O. Esito negativo hanno anche le ricerche sul conto di Mario Carloni svolte a Parigi dall’Ambasciata italiana che invia a Roma un telegramma il 14 luglio 1930. Degli scarsi risultati ottenuti scrive il Ministero dell’Interno l’8 ottobre 1930 al prefetto di Brindisi pregandolo di tenerlo informato “di ogni utile notizia che venga a risultare circa l’attuale recapito del Santacesaria”. Il nuovo prefetto brindisino, Francesco Rosso, risponderà alla richiesta di Roma il 29 ottobre 1930 informando il Ministero che “dall’epoca in cui emigrò in Francia non ha dato più notizie di sé neanche ai propri congiunti”. Passano intanto tre anni prima di poter aggiungere qualche elemento in più sul conto di Eugenio Santacesaria. Il 18 maggio 1933 il Ministero dell’Interno invia un telegramma ministeriale ai prefetti del regno e al questore di Roma con il quale “Raccomandasi disporre attenta vigilanza per conseguire fermo, qualora tentasse entrare Regno Santacesaria Eugenio […] residente Francia ove est noto sotto cognome Carloni nato a Milano stop Santacesaria sedicente Carloni est elemento pericoloso et molto attivo nel campo antifascista stop Prenderebbe parte ad ogni tentativo di preparazione di attentati nel Regno stop Est anche in rapporti con pericolosi esponenti gruppi repubblicani et anarchici fuoriusciti residenti Francia stop”. Dopo quasi nove anni di ricerche si è giunti dunque ad alcune conclusioni: Eugenio Santacesaria sarebbe rifugiato in Francia sotto il nome di Mario Carloni.
In conseguenza delle ultime notizie acquisite il Ministero dell’Interno scrive al prefetto di Brindisi, richiamando particolare attenzione sul conto di Santacesaria, elettricista, “[…] attualmente residente a Parigi, in quanto elemento pericoloso e molto attivo nel campo antifascista, per la parte che suole prendere ad ogni tentativo di preparazione di attentati nel Regno. Il Santacesaria, che da codesti atti risulta comunista schedato, a Parigi risulta iscritto nel Partito socialista massimalista, del cui Consiglio direttivo è membro. D’altra parte, il Santacesaria risulta legato da intimità di rapporti con Raffaele Rossetti ed altri pericolosi esponenti di gruppi repubblicani e anarchici fuoriusciti in Francia, quali Refolo Pietro, Semeraro Sante, Diotallevi Angelo, Mastrodicasa Leonida, Nozzoli Quisnello. A Parigi, ove abiterebbe al n. 33, rue Angouléme, conduce vita apparentemente ritirata”. La lettera termina con la conferma che Eugenio Santacesaria “negli ambienti è noto sotto il nome di Carloni da Milano. Alla richiesta inviata dal Ministero dell’Interno alla Divisione di poli zia politica il 18 maggio 1933, nella quale si prega “di far conoscere se sia il caso di richiedere notizie sull’attività politica del Santacesaria all’On. Ministero degli affari esteri o se si debbano ritenere esaurienti, siccome provenienti da fonte attendibile, quelle fornite da codesta On. Divisione”. Il 2 giugno 1933 risponde quest’ultima fornendo ulteriori informazioni sulla permanenza in Francia di Eugenio Santacesaria: “Viene riferito che il noto socialista […], sedicente Carloni, ebbe dal fuoriuscito Rossetti Raffaele la proposta di andare a lavorare per conto suo unitamente ad altro individuo sconosciuto, in località fuori Parigi nei primi del corrente mese. Il lavoro in questione avrebbe dovuto durare diversi giorni e sarebbe stato compensato dal Rossetti con 50 franchi al giorno oltre le spese. Non è stato precisato dal fiduciario né di quale lavoro possa trattarsi né in quale località il Santacesaria intenda portarsi”.
Il 26 luglio 1933 in una comunicazione proveniente da “fonte fiduciaria” viene riferito al Ministero dell’Interno che «Ha recentemente avuto luogo a Parigi il congresso socialista massimalista, conclusosi con la elezione dei nuovi componenti la “direzione” nelle persone di: Balabanoff, segret. generale e direttrice dell’“Avanti!” (che sarà pubblicato ogni 15 giorni); Simonini (alias Mariani Dino) vicesegretario, il quale ritornerà a stabilirsi a Marsiglia; Monchelli; Burgassi; Taroni; Semeraro; Marchisio; Focardi; Massignan […]». Tra i rappresentanti per la sezione di Parigi vi è anche Eugenio Santacesaria (alias Carloni). Il 29 luglio 1933 sempre dal Ministero parte una richiesta al prefetto di Brindisi con la quale “Si prega di trovar modo di accertare il recapito attuale all’estero del soprascritto individuo, riferendo”. Conferma della residenza a Parigi in rue d’Augouleme al n. 39 giunge con una nota fiduciaria al ministero il 9 agosto 1933 che ne dà immediata comunicazione all’ambasciata di Parigi. Quest’ultima il 15 settembre 1933 informerà il ministero che «nulla è stato finora possibile accertare sul conto del connazionale in oggetto. Medesimo, infatti, è del tutto sconosciuto al n. 39 della rue d’Angouleme in questa capitale”. Del 9 ottobre 1933 è un’altra nota attendibile giunta da Parigi a Roma nella quale viene riferito che Eugenio Santacesaria, alias Carloni, “si è allontanato da qualche tempo dalla dimora di rue d’Angouleme 39, dov’era ospite di Semeraro Santo e della di lui concubina Dazzan Luigi [sic! – si tratta di Luigia Agnese Dazzan, futura moglie di Santo Semeraro – n.d.r.], rendendosi irreperibile. Di ciò s’informa codesta On. Divisione; ad opportuna notizia, significando che, in data odierna, è stato interessato altro fiduciario ch’è in rapporti col Santacesaria, ad accertare se il medesimo si trovi ancora a Parigi e, in caso affermativo, quale sia l’attuale suo recapito”. Intanto il Ministero non demorde ed il 15 novembre 1933 riceve una nuova comunicazione “fiduciaria attendibile” secondo la quale Santacesaria “abiterebbe attualmente a Parigi in rue Desson-des Berges, sembra al n. 59, insieme col cugino di lui Semeraro Sante, nel medesimo stabile ove dimora il noto Mombello Oreste” [7]; comunicazione della quale rende partecipe l’ambasciata d’Italia a Parigi il 23 novembre 1933. Ma il 30 dicembre 1933 dalla capitale francese giunge comunicazione che a Parigi “i nominati Santacesaria Eugenio, Semeraro Sante e Mombello Oreste, sono del tutto sconosciuti”.
Il 5 gennaio 1934 giunge, intanto, al Ministero dell’Interno un appunto pervenuto dalla Divisione di polizia politica nel quale «Viene fiduciariamente riferito che il noto Rossetti Raffaele si è associato nella sua attività antifascista, mascherata da ragioni commerciali, con il segnalato socialista Mauri Antonio di Luigi, elettricista. Questi ha Sostituito il noto Santacesaria Eugenio, sedicente Carloni, il quale avrebbe dichiarato di essersi allontanato da Rossetti per non sottoporsi “alla sua dittatura nell’opera che avevano iniziato, con scopi rivoluzionari”. Questa segnalazione deve avere riferimento con i progetti di attentati, mediante ordigni incendiari, attribuiti al Rossetti». Il 5 febbraio 1934 la Divisione di polizia politica informa il ministero che Eugenio Santacesaria, alias Carloni, abiterebbe a Parigi in rue Dessons des Bérges al n. 93 e non 59, di questa correzione si prende premura lo stesso ministero comunicandola il 16 febbraio 1934 all’ambasciata d’Italia a Parigi. Ma il 10 marzo 1934 giunge una nuova segnalazione al ministero secondo la quale Eugenio Santacesaria “ricercato dalla polizia francese, abita attualmente in rue de la Tour d’Auvergne (a Parigi) in casa di Salvi” [8]. Il 30 marzo 1934 l’ambasciatore italiano in Francia nel confermare a Roma che Santacesaria risiede nella regione parigina scrive pure che “ignorasi il preciso recapito. È esatto che il Santacesaria frequenti la casa del noto Salvi Giorgio insieme al quale è stato espulso ultimamente dal Partito socialista massimalista in seguito al loro passaggio nelle organizzazioni del Fronte unico. Il sedicente Carloni non sembra che in atto esplichi attività politica degna di rilievo”. Di tutt’altro avviso è invece la relazione del Ministero dell’Interno datata 5 maggio 1934 (inviata all’Alto commissario di Napoli, al Commissario speciale per l’agro pontino a Littoria, al questore di Roma e a tutti i prefetti del Regno), nella quale Eugenio Santacesaria, alias Carloni, risulta far parte del gruppo di sovversivi capeggiato da Giobbe Giopp e Raffaele Rossetti che “si propone, senza dubbio, l’esecuzione prossima di attentati”. Marino Mutinelli, nuovo prefetto di Brindisi, il 17 maggio 1934 invia al Ministero due lettere: nella prima sollecita l’inserimento del falso nome Carloni del socialista Eugenio Santacesaria nel Bollettino delle ricerche, nella seconda chiede di aggiungere il noto mesagnese “nell’elenco degli attentatori capaci di commettere atti terroristici” [9].
Si intensifica, intanto, l’attività di responsabile politico di Eugenio Santacesaria. Il 25 maggio 1934 giunge infatti al Ministero una segnalazione della Divisione polizia politica secondo la quale da fonte confidenziale viene riferito che Santacesaria “si sarebbe recato recentemente in Russia, insieme ad altri componenti di una delegazione operaia”. Il 26 ottobre 1934 in casa di Giorgio Salvi a Parigi si tenne una riunione politica alla quale presero parte Giuseppe Di Vittorio, Pietro Refolo, Virgilio Marchetto, Noemi Geninazzi (fu Pompeo), Armando Tedeschi e il noto Carloni. Il 17 novembre 1934 dalla Divisione polizia politica giunge al Ministero la notizia proveniente da “fonte fiduciaria” secondo la quale “nell’ultima decade di ottobre scorso vi furono a Parigi delle riunioni degli aderenti al Fronte unico, di emanazione comunista, dirette specialmente a protestare ed a stabilire accordi per ostacolare le manifestazioni fasciste del 28 ottobre” alle quali prese parte Eugenio Santacesaria [10]. Il 10 marzo 1935 in rue de Tretaigne a Parigi si svolge il Convegno e la festa delle donne contro il fascismo e la guerra al quale partecipa Eugenio Santacesaria. L’informazione giunge a Roma da una fonte confidenziale parigina il 3 aprile 1935. È del 9 aprile, invece, la lettera con la quale il Ministero è informato di una nota giunta dalla solita Divisione polizia politica il 20 marzo1935; nella missiva si fa riferimento ad una riunione del Fronte unico di Parigi alla quale sarebbe intervenuto Eugenio Santacesaria. Il 29 marzo 1935 la Prefettura di Milano informa il Ministero dell’interno della corrispondenza di Eugenio Santacesaria inviata da Parigi al fratello Alfredo, residente nel capoluogo lombardo presso Cermel, in via Ampére n. 40. Il prefetto milanese invia copia fotografica di due lettere, entrambe datate 23 marzo 1935, inviate rispettivamente al fratello e alle sorelle:
«Carissime sorelle
In risposta alla vostra lettera del mese scorso con la quale mi apprendevate del vostro ottimo stato di salute e delle vostre apprensioni circa le mie condizioni, debbo anzitutto farvi una preghiera e cioè di non impressionarvi molto facilmente, sia per una parola più o meno che io possa dire, oppure per quel che altri possano dirvi. Evidentemente non sono tutte rose, anzi vi sono più spine che rose, oggi è triste vivere ovunque e soprattutto per quelli che bene o male hanno avuto la velleità di mettere su una famiglia malgrado le tristi condizioni in cui si vive. Questo è il caso di Santo che anche se dovesse lavorare continuamente, ciocché oggi è molto difficile, non potrà giammai riuscire a varcare il lunario, perché sono 3 a vivere col magro salario che tocca. Un’altra difficoltà è che lui non ha un mestiere definito e quindi neanche la possibilità di guadagnare di più. Comunque cercate di non preoccuparvi di me, perché se anche le mie condizioni fossero cattive io me la caverò. Fate tanti saluti alla fornaia e ditegli che se avesse bisogno potrei mandargli una dentiera nuova, fate anche i miei saluti a tutti i fratelli e gli altri parenti e a voi un abbraccio
aff.mo Eugenio.
Carissimo fratello
Mi giunse la tua lettera e quella delle sorelle qualche settimana fa e ti rispondo con un po’ di ritardo come al solito. Mi compiaccio che stai bene dopo la breve indisposizione di cui mi accenni, anch’io sono stato indisposto qualche settimana fa ma adesso sto benissimo. La tua preoccupazione è anche la mia, oggi l’atmosfera è talmente carica di elettricità che un incidente qualsiasi può scatenare la bufera. Purtroppo il temporale non sarà cosi leggero come tu speri, la situazione internazionale è così complicata che un conflitto in Europa qualunque esso sia trascinerà tutte le potenze in una guerra mondiale con tutte le disastrose conseguenze che esso comporta. Credi pure che la guerra non risolverà nulla come d’altronde non ha mai risolto nulla, anzi essa aggraverà le condizioni generali delle popolazioni e soprattutto del popolo lavoratore. Evidentemente c’è chi trae degli enormi profitti dalla guerra, ma questi non sono che i grossi finanzieri industriali ecc. i quali si vedranno moltiplicare i loro capitali speculando sulla vita di milioni di esseri umani che si fanno trucidare esclusivamente per riempire le casse di questi pochi vampiri. Mi domandi cosa penso di fare se le cose si mettessero male? È una domanda, caro fratello, a cui non posso risponderti, è molto prematuro d’altronde su certe decisioni io non ci studio molto tempo, anche perché ho anch’io un’esperienza. Da certe notizie pervenute mi era nato il dubbio che tu fossi stato richiamato, intanto mi fa piacere che questo non sia avvenuto.
Ti saluto e ti abbraccio, aff.mo Eugenio».
Il 21 luglio 1935 una lettera circolare viene inviata dal Ministero dell’Interno all’ambasciata d’Italia a Parigi con la quale si chiedono notizie sulla residenza e sull’attività politica svolta “in questi ultimi tempi” da Eugenio Santacesaria. Sebbene non sia stato possibile accertare dove abiti, l’ambasciata parigina, il 5 agosto 1935, conferma che l’esponente politico mesagnese risiede ancora a Parigi “ove esplica attiva propaganda antifascista”. Reca la data 28 agosto 1935 il dispaccio della R. Ambasciata d’Italia a Parigi con il quale comunica a Roma che il comunista Eugenio Santacesaria, sedicente Carloni, “è stato arrestato dalle locali autorità di polizia alla sede delle Assicurazioni sociali ove si era recato in seguito ad un incidente sorvenutogli sul lavoro. Il Santacesaria, infatti, era in possesso di falsi documenti d’identità. In atto trovasi detenuto nelle carceri della Santé”. A seguito della segnalazione giunta dalla Divisione di polizia politica il 28 settembre 1935 il Ministero dell’interno il 4 ottobre 1935 invia ai prefetti del regno e al questore di Roma un “dispaccio telegrafico” nel quale informa che, sempre secondo fonti confidenziali, Santacesaria “residente in Francia, avrebbe manifestato intenzione rientrare Regno stop Trattandosi elemento meritevole rilievo rinnovansi disposizioni impartite con circolari […] per rintraccio arresto rigorosa perquisizione predetto qualora tenti rientrare Regno aut siavi già entrato […] Particolare raccomandazione rivolgesi Prefetti confine franco-svizzero et Prefetto Brindisi stop”.
Il 10 ottobre 1935 Santacesaria risulta abitare ancora in Francia insieme con Giuseppe Focardi, nel comune di Courbevoire, al n. 109 dell’avenue de la République, dopo essere stato rilasciato. L’11 gennaio 1936 il Ministero dell’Interno chiede notizie sul rilascio del Santacesaria e l’ambasciata risponde riportando sempre “riservate informazioni” secondo le quali l’“attivo antifascista e funzionario del Partito comunista italiano in Francia è uscito in questi giorni dal carcere ed abita attualmente al n. 42 della rue Berthe. Il Santacesaria cerca di non attirare troppo l’attenzione delle locali autorità con la sua condotta politica ma è sempre in contatto con queste organizzazioni sovversive. In questi giorni ha fatto anche regolare domanda per essere ammesso all’Associazione franco-italiana ex combattenti antifascisti”. Eugenio Santacesaria, intanto, risulta aver partecipato, il 4 aprile 1936, ad una festa organizzata dall’Associazione antifascista fra romagnoli all’estero “Fratellanza romagnola”, svoltasi nei locali della Gioventù repubblicana francese, al n. 160 della rue de la Roquette a Parigi. Ed il 24 novembre 1936 partecipa ad una “riunione per organizzare a Parigi una grande manifestazione in favore della Spagna” che si tiene nei locali del Partito socialista, al 103 Fbg. Saint Dénis, e alla quale “erano presenti i rappresentanti del Partito socialista massimalista, Comunista, Azione repubblicana socialista, ex combattenti antifascisti, Lidu, anarchici e Giustizia e libertà”; l’informatore, oltre a Santacesaria, segnala di aver notato, tra gli altri presenti, Aldo Colombo, Massignan, Pietro Magnani, Antonio Bondi, Luigi Tagli, Lazzaro Rafuzzi, Alessandro Bocconi. Quest’ultima riunione, alla quale parteciperà Eugenio Santacesaria, sarà quella decisiva per la sua scelta di recarsi in Spagna a combattere nella guerra civile a fianco dei volontari rossi contro la dittatura di Francisco Franco.
Passa un po’ di tempo e l’8 marzo 1937 giunge al Ministero dell’Interno la notizia, a sua volta riferita da “fonte confidenziale attendibile” alla Divisione di polizia politica, secondo la quale il noto Eugenio Santacesaria “sarebbe morto in Spagna” [11]. Anche l’ambasciata d’Italia a Parigi, il 12 marzo 1937, si affretta a comunicare a Roma che “il nominato in oggetto è rimasto ucciso in Spagna combattendo a fianco delle truppe del governo comunista. Il Santacesaria faceva parte del Battaglione Garibaldi”. La stazione radiotrasmittente della Pubblica sicurezza di Imperia il 15 marzo 1937 alle ore 20.30/21.00 intercetta una comunicazione proveniente dalla Stazione radiofonica di Barcellona Eaj n.1 calle Caspe 12 di propaganda antifascista in lingua italiana, questo il testo trascritto e inviato a Roma:
“[Omissis] È morto in questi ultimi giorni sul fronte di Guadalajara il grande eroe Carloni. Egli era il servo fedele al servizio del Partito comunista italiano. Nel 1920, allorché cessò di prestare servizio militare in Marina, fu tra i primi a iscriversi nelle file fasciste, allorché si accorse dei soprusi e delle angherie dei capi, si ribellò ad essi e, dopo aver messo a soqquadro la sede del fascio di Mesagne, passò a far parte del Partito socialista per poi passare, più tardi, nelle nostre file che per il suo modo di fare seppe ben presto farsi ammirare ed apprezzare dai comandanti. Canoni non è più. Egli si è sacrificato per una causa comune per la lotta della libertà contro l’oppressione fascista [Omissis]”.
Intanto il Ministero dell’Interno, il 30 marzo 1937, riferisce al prefetto di Brindisi che Eugenio Santacesaria “è rimasto ucciso in Spagna combattendo a fianco delle truppe del governo comunista. Il Santacesaria faceva parte del Battaglione Garibaldi”, secondo quanto comunicatogli dall’ambasciata d’Italia a Parigi il 12 marzo. Passa un anno ed il 18 maggio 1938 giunge al Ministero dell’interno copia del telespresso inviato dal Consolato generale d’Italia a Salamanca avente per oggetto “Connazionali deceduti in combattimento militanti tra le truppe rosse spagnole”. In quel primo elenco, fornito “dalla solita fonte fiduciaria che questo Regio ufficio ha in Barcellona”, sono indicati i “connazionali militanti nelle truppe rosse spagnole, morti in combattimento dall’inizio della guerra fino a tutto il mese di aprile 1937-XV”. Una fitta corrispondenza intercorrerà ancora tra Ministero dell’Interno, Ambasciata d’Italia a Parigi, Ministero degli affari esteri, Consolato generale d’Italia di Barcellona a San Sebastian e Prefettura di Brindisi, fino al 13 agosto 1939, con lo scopo di accertare il decesso in Spagna di Eugenio Santacesaria, alias Mario Carloni, anche con l’ausilio fotografico [12].
A distanza di due anni dalla morte di Eugenio Santacesaria, avvenuta presumibilmente nei primi giorni del marzo 1937, il prefetto di Brindisi, Silvio Ghidoli, il 6 maggio 1939 comunica al Ministero dell’Interno che “dagli accertamenti fatti eseguire non è risultato che il comunista in oggetto sia deceduto in Spagna. I suoi famigliari asseriscono che lo stesso trovasi a Parigi occupato in una fabbrica di costruzione di oggetti elettrici, di cui non sanno indicare il recapito”. Purtroppo la residua illusione dei congiunti di Eugenio Santacesaria viene definitivamente delusa dalla comunicazione che il 10 luglio 1939 il Ministero degli affari esteri invia a quello dell’Interno al quale riferisce il seguente rapporto giunto dalla R. Ambasciata d’Italia a Parigi: «[…] A quanto è stato possibile apprendere in questi ambienti antifascisti, il noto Santacesaria Eugenio, sedicente “Mario Carloni”, è deceduto in Spagna ove combatteva a fianco delle milizie rosse. […] Si allega un ritaglio del giornale comunista “Il grido del popolo” del 7 marzo 1937, riguardante la morte del Carloni e contenente la fotografia del Santacesaria». L’articolo ha per titolo L’omaggio del Partito comunista e del “Grido del Popolo” all’eroico compagno Carloni e questo è il suo testo:
«Il compagno Carloni non è più. La classe operaia italiana, il Partito comunista, le organizzazioni degli italiani emigrati in Francia hanno perduto uno dei loro migliori militanti. Sul fronte di Madrid, baluardo della lotta antifascista mondiale, combattendo nelle file del Battaglione Garibaldi, Canoni è caduto così come è vissuto: da rivoluzionario devoto ed eroico. Nelle Puglie “rosse” del dopoguerra italiano, negli anni duri della lotta estrema contro la feroce offensiva fascista, nelle tribolazioni dell’esilio, Carloni diede sempre tutto se stesso alla causa della lotta per la libertà dei lavoratori. Il suo attaccamento appassionato alle grandi masse operaie, che voleva portare unite alla lotta per il socialismo, non potevano non avvicinarlo sempre più al Partito che è stato sempre all’avanguardia della lotta per l’unità del proletariato, al Partito comunista. Il Partito comunista fu ed è fiero dell’adesione datagli da Carloni: e Carloni si dimostrò degno della fiducia testimoniatagli dal Partito chiamandolo a posti dirigenti in organizzazioni importantissime. Dopo aver organizzato e diretto la magnifica attività di solidarietà verso la Spagna del popolo data dai compagni e simpatizzanti della Regione Parigina, Carloni volle partire lui stesso come volontario per la Spagna. Con le armi in pugno continuò colà la battaglia per la causa fino al momento della sua morte eroica. La Redazione del “Grido del Popolo”, facendosi interprete del Partito comunista, invia il suo addolorato, ardente saluto alla memoria del compagno Carloni.
La Redazione del “Grido del Popolo”
Saluto del Comitato nazionale di Fronte unico alla memoria del compagno Carloni
Il Comitato nazionale di Fronte unico, saluta con commozione e orgoglio la memoria dell’amato compagno Carloni, caduto da eroe a Madrid, sul fronte della libertà, nelle file del glorioso Battaglione Garibaldi.
Il compagno Carloni era membro del nostro Comitato nazionale di Fronte Unico fin dalla sua costituzione, e fu sempre tra gli attivissimi e tra gli entusiasti.
Il Comitato nazionale, mentre decide di promuovere una degna commemorazione del compagno Carloni, in una data prossima da fissarsi, inchina riverente le sue bandiere davanti a questo nuovo caduto che onora il nostro movimento, la sua forte terra di Puglia e tutto il popolo italiano.
Il Comitato nazionale di Fronte Unico».
Fin qui il carteggio conservato nell’Archivio Centrale dello Stato a Roma. Di Eugenio Santacesaria resta il ricordo in una via a lui intitolata a Mesagne. Aldo Marangio, descrivendone l’origine toponomastica, scrive che “il nome d’origine di questa strada era via Teutonici (detta anche strada di Santu Linardu)” [13], aggiungendo poi alcuni elementi preziosi ricavati dalle testimonianze di anziani mesagnesi:
«Eugenio Santacesaria era uno di 14 figli, di cui due femmine. Erano tutti onesti lavoratori, quasi tutti meccanici e impiegati nelle ferrovie dello Stato, altri nella carriera militare; ne ricordo uno capitano dell’aeronautica, un figlio di quest’ultimo è generale della stessa arma, e vive a Roma. I suoi fratelli Domenico, Armando e Vincenzo furono sospesi dalle ferrovie, dal regime fascista, solo perché erano suoi fratelli. Eugenio conseguì il diploma di elettrotecnico, e riuscì un professionista di grande valore. Eseguiva lavori in proprio; una delle tante sue opere ancora esistenti è l’impianto elettrico della chiesa di Materdomini. Questo ingegnoso capolavoro d’arte gli fu commissionato dall’allora priore Antonio Pasimeni (Ntunuccio ti la nevi). Dopo aver realizzato questa opera di grande rischio, perché in quell’epoca non esistevano le scale semoventi o impalcature in ferro, gli fu affidata l’altra rischiosa impresa di installare alla cima della cupola la lampada che ancora è visibile la sera. Ideando una scala di corda con pioli di legno, superò l’impresa. Oltre ad essere dotato di una rara ingegnosità aveva un coraggio da leone, era caritatevole, difendeva i deboli, era ribelle a tutte le ingiustizie specie alla dittatura fascista. Preferì il volontario esilio. Esule in Francia, ebbe contatti con Bruno Buozzi, Togliatti, Pertini ed altri. Da questi era tenuto in grande considerazione tant’è che affidavano a lui incarichi pericolosi, come la staffetta che faceva tra Lugano e Parigi (a Lugano esisteva lo stato maggiore dell’antifascismo). Il suo nome di battaglia era Carloni. Era membro della Terza Internazionale, lo mandavano anche a Mosca e nella stessa Italia, col pericolo di essere arrestato dagli agenti dell’OVRA. Arrestato a Parigi, dopo due anni evase; poi andò in Spagna, ove imperversava la guerra civile. Fu volontario nella brigata Garibaldi, combatté valorosamente a fianco di Giuseppe Di Vittorio, Ferruccio Parri, Luigi Longo ed altri. Da questi era tenuto in grande considerazione. Immolò la sua giovane esistenza nella famosa battaglia di Guadalajara. Non si è mai saputo dove riposano i suoi resti mortali».
Sono evidenti le imprecisioni contenute nell’articolo di Marangio e sono anche comprensibili le esaltanti notizie raccolte però, come si diceva all’inizio, dalla viva voce di persone che avevano conosciuto direttamente l’allora giovanissimo Eugenio Santacesaria, “ritenuto uno dei primissimi attivisti comunisti di Mesagne” [14].
Di certo l’imprendibile Carloni, che per tanti anni era riuscito a beffare tanta forza pubblica non solo in Italia, aveva terminato la sua breve ma intensa vita catturato, rapito, dal vento acre della guerra che in Spagna alcuni italiani andarono a combattere guidati dall’amore per le loro idee.
[1] ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO (Abbr. ACS), Ministero dell’Interno, Direzione generale di Pubblica sicurezza, Divisione Affari generali e riservati, Casellario politico centrale, fasc. 4263.
[ N.d.r. : Il presente contributo è stato pubblicato su “Studi Salentini” (1997), con un maggiore e più approfondito apparato di note a corredo]
[2] Sulla figura e l’opera del magliese Pietro Refolo si veda: S. COPPOLA, Pietro Refolo (Maglie 1884 – Lecce 1958). Una vita per la democrazia. Origini della CGIL nel Salento, Argo ed., Lecce 1998; K. MASSAFRA, Il popolo al confino. La persecuzione fascista in Puglia, 2 voll., Ipzs, Roma 1991, vol. I, pp. 478-79.
[3] ACS, doc. cit.
[4] ACS, Ministero dell’Interno… ecc., fasc. 2773
[5] Della scheda biografica non vi è più traccia nella documentazione conservata presso l’ACS di Roma, mentre vi sono due fotografie segnaletiche (con i numeri 14.577 e 28.516)
[6] ACS, doc. cit.
[7] Fondatore della Camera del lavoro di Biella; si veda: S. COPPOLA, op. cit., p. 99
[8] Sul noto esponente politico socialista cfr. S. COPPOLA, op. cit., ad nomen, e, nell’Appendice, allo stesso vol., la corrispondenza con Pietro Refolo.
[9] A tutto il 1933 non risultava ancora inserito.
[10] A quelle riunioni prese parte, tra gli altri, anche Santo Semeraro.
[11] Il Ministero informerà il prefetto di Brindisi con lettera del 15 marzo 1937 (ACS, doc. cit.).
[12] Il 2 luglio 1938 il Ministero dell’Interno chiederà ulteriori notizie su Mario Carloni alla R. Ambasciata a Parigi; il 22 luglio 1938 quest’ultima informa il Ministero dell’Interno che «un certo Carloni Mario, come ha pubblicato l’“Avanti!” in data 7 marzo 1937 [probabilmente è l’articolo di Pietro refolo riportato all’inizio di questo lavoro], sarebbe deceduto sul fronte di Madrid, combattendo a fianco delle milizie rosse. Questo Ufficio ritiene che il predetto si identifichi con il nominato in oggetto che non è stato possibile rintracciare in questa capitale e di cui ignorasi le complete generalità»
[13] A. MARANGIO, Via Eugenio Santacesaria, in “Mesagne/Incontro”, A. I (1988), n. 7, p. 8.
[14] A. PROFILO, Vie, piazze, vichi e corti di Mesagne, Fasano 1993, p. 411.

(1896-1973)
di
Mario Vinci
Luigi Scoditti nacque a Mesagne il 17 febbraio del 1896 da Samuele e da Anna Guarini. Perderà l’affetto materno all’età di due anni e, come egli stesso ci racconta nel suo libro “Ricordi di un paese del Salento intorno al 1906” suo padre non si risposò e vissero “tutti insieme nella stessa casa con tre zie paterne che si occupavano di lui”. Frequentò a Lecce, presso il Liceo Palmieri, gli studi classici per poi proseguire gli studi universitari presso la facoltà di Lettere, che non terminò a causa dell’inizio della prima guerra mondiale, alla quale partecipò come ufficiale di Fanteria, guadagnandosi anche una medaglia d’argento al valor militare. Partecipò anche alla II Guerra mondiale. Finita la guerra volle continuare gli studi universitari, cambiando però indirizzo, si scrisse infatti alla facoltà di Agraria a Portici prima e successivamente a Pisa, dove si laureò nel 1923. Qualche anno più tardi si sposò con la professoressa Ada Gioia e nel 1925 partecipò ad un concorso nazionale per agronomi a Firenze, dove risultò vincitore. Iniziò quindi la sua carriera professionale presso le Cattedre Ambulanti di Agricoltura (gli attuali Ispettorati Provinciale dell’Agricoltura). Prestò servizio dapprima a Lecce, poi a Gallipoli, Francavilla Fontana, Cerignola (zona maggiormente interessata in quel periodo alle rivolte contadine, la terra di Di Vittorio), poi venne a Brindisi e di nuovo a Lecce.
Nel 1950 lasciò volontariamente il servizio ritirandosi nella quiete del suo paese natale, per dedicarsi con passione allo studio della storia e delle tradizioni locali, come ci dimostrano i suoi scritti, rimasti in gran parte inediti. Se ne contano all’incirca una novantina, alcuni di poche pagine, altri più corposi, comunque sempre apprezzabili ed interessanti, non solo per gli addetti ai lavori. Il suo studio in quel palazzotto di piazza Cavour, divenne ben presto un vero salotto culturale, frequentato da diversi amici e cultori della storia locale, tra cui l’avvocato Lallo Caracciolo, il pittore Antonio Franco, don Daniele Cavaliere, Annibale Cavaliere ed il prof. Gherard Rohlfs, che per i suoi studi di glottologia sul dialetto salentino ed in particolare sulla Grecia salentina, era spesso in Puglia e talvolta soggiornava in casa di Luigi Scoditti. Lo Scoditti è stato un ricercatore instancabile, ha tolto dall’oblio del tempo documenti e testimonianze che altrimenti sarebbero andati perduti, lasciandoci così un patrimonio che è ancora da scoprire. Purtroppo molti dei suoi lavori, come accennato precedentemente, non sono stati pubblicati per mancanza di fondi e per lo scarso interesse degli Enti preposti alla salvaguardia del patrimonio culturale (molte volte infatti, l’interesse alla pubblicazione e quindi divulgazione di determinate opere, che sono pur sempre frutto di accurate ricerche, sono oggetto di affrettato giudizio da parte di persone che con la cultura hanno poco o niente a che vedere, lasciando cadere nel vuoto anni di lavoro). Fortunatamente, però, molte opere dello Scoditti sono conservate presso le Biblioteche Provinciali di Brindisi e di Lecce e presso la Biblioteca Arcivescovile “A. De Leo” di Brindisi.
A sottolineare quanto detto precedentemente proponiamo un articolo del prof. Rohlfs apparso sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 5 gennaio 1962, dal titolo: L’opera sconosciuta di un autodidatta del Salento.
“Mi permetto di mandarvi per la terza pagina (nei quotidiani la terza pagina, come ben si sa, è dedicata alla cultura ed è chiamata elzeviro) del Vs. giornale, un piccolo articolo che ha lo scopo d’illustrare brevemente l’attività di uno studioso locale, il dott. Luigi Scoditti, di Mesagne, che, secondo me, merita di essere onorevolmente presentato ai vostri lettori, anche perché gli studiosi locali si rendano conto che le loro fatiche non sempre terminano nel grande dimenticatoio, come purtroppo spesso capita. La recente pubblicazione della professoressa Ada Gioia, dal titolo – Gli scritti di storia salentina e mesagnese di Luigi Scoditti – mi inducono a dare notizia, su di un quotidiano di vasta diffusione in Puglia e nel Salento, di uno sconosciuto e fecondo scrittore di storia salentina, tuttora vivente, qual è il mesagnese Luigi Scoditti. E ne dò notizia io, cittadino non italiano, perché nei miei frequenti viaggi e permanenza nel Salento, per lo studio dei dialetti salentini (vedi il mio vocabolario dei dialetti salentini), ho conosciuto e sono entrato in relazione con lo Scoditti che è stato poi uno dei miei più assidui informatori, per la compilazione del predetto vocabolario. E ne dò notizia io, anche perché vedo che nessun suo concittadino si è curato di segnalarne l’opera. Eppure l’opera storica dello Scoditti, se non altro per la sua vastità, merita di essere segnalata agli studiosi ed al pubblico colto delle Puglie e del Salento […]”.
Dopo la morte della moglie, avvenuta nel 1969, il nostro Luigi avrà un periodo di pausa nella ricerca storica, l’ultimo lavoro è datato 1970 e riguarda la chiesa della Misericordia. Luigi Scoditti si spense in Mesagne all’età di 77 anni, il 25 settembre del 1973. Sarebbe auspicabile dare a questo personaggio il giusto spessore culturale che merita, pubblicando un’antologia degli scritti, dei quali riportiamo i più importanti:
- L’origine e la denominazione dei centri abitati della provincia di Brindisi – Dattiloscritto, pagine 186, anno 1960;
- Bibliografia di Giovanni Antonucci, in Studi Salentini, Lecce, dicembre 1956, pp.90-160;
- Il castello di Mesagne, in Il Corriere del Giorno, Taranto, 17 agosto 1954;
- Storia di Mesagne, dalle origini ai primi anni dell’800 – Dattiloscritto, pagine 149, anno 1968;
- Note storico-topografiche sulla città di Mesagne – Dattiloscritto di pagine 50, con cinque piante, s.d.;
- Note storiche sulle contrade rurali di Mesagne e dintorni – Dattiloscritto, di pagine 248, s.d.;
- Scritti e scrittori di storia mesagnese, Dattiloscritto, pagine 40, s.d.;
- Le guerre dei Messapi con Taranto, in Il Tallone d’Italia, Lecce, 2 e 18 giugno 1955;
- La popolazione di Mesagne dal 1378 al 1961 – Dattiloscritto;
- Ricordi di un paese del Salento intorno al 1906 – Lavoro autobiografico, stampato per i tipi della Tipografia Ragione di Brindisi, 1966, di pagine 120.

(1900-1965)
di
Giuseppe Pastore
Uno dei mesagnesi che hanno contribuito a “fare” la storia e le cui esperienze politiche si intrecciano a filo doppio con le vicende del paese è senz’altro Santo Semeraro. Santo Filippo Neri, questo è il suo vero nome, nasce a Mesagne il 26 maggio 1900 da Francesco, impresario edile, e da Caterina Depasquale, casalinga: è penultimo di cinque fratelli (quattro maschi e una femmina) e tutta la famiglia risiede nella casa di via Generale Falcone. Sin da giovane dimostra impegno e grande attivismo: a 16 anni è già iscritto alla gioventù socialista. Nel maggio del 1917 è chiamato alle armi nel corpo dei bersaglieri e vi rimane sino alla fine della guerra. Al ritorno a Mesagne riprende l’attività politica e diviene segretario della locale sezione socialista. Nelle elezioni amministrative del novembre 1920 risulta eletto consigliere comunale nelle liste del partito socialista. È fra i più giovani consiglieri comunali d’Italia. Nel giugno dello stesso anno, intanto, aveva conseguito il diploma di capitano di lungo corso presso l’istituto nautico “Pitagora” di Bari. Nel gennaio 1921 parte per frequentare a Livorno il corso per allievi ufficiali di complemento dell’Accademia Navale. È costretto ad abbandonare l’accademia dopo poco tempo in profondo disaccordo con i vertici militari, in seguito ad un rifiuto opposto nella repressione di uno sciopero dei ferrovieri che bloccava la città toscana.
Ritorna a Mesagne ma il suo attivismo politico e la militanza nel Partito Socialista gli creano non pochi problemi: cerca di imbarcarsi, ma senza esito a causa della imperversante reazione fascista che lo ha preso di mira. Trova un impiego presso l’esattoria comunale di Mesagne all’inizio del 1923 ma ben presto i fascisti, con minacce fisiche, obbligano il direttore di licenziarlo nel maggio dello stesso anno, facendo poi assumere uno di loro al suo posto. Contro Semeraro si accanisce l’azione persecutoria degli squadristi, specialmente dopo l’assassinio di Matteotti, poiché l’impunità dei responsabili dà più arroganza ai facinorosi in camicia nera. Subisce aggressioni fisiche con bastonate e percosse ed è costretto a bere olio di ricino; è, inoltre, diffidato e ammonito dalla polizia. Minacciato continuamente e posto in condizione di costante pericolo, Semeraro abbandona Mesagne e, per evitare il peggio, il 7 luglio 1924 parte clandestinamente per la Francia e giunge a Cannes il 13 luglio. Come tanti altri dirigenti democratici esiliati si arrangia come può, alternando periodi di intenso lavoro a periodi di disoccupazione. Svolge diversi mestieri: manovale, operaio, meccanico, cambiando, per evidenti motivi di sicurezza, residenza e luogo di lavoro. Ma anche in Francia continua la sua opera politica; è nella direzione del PSI, insieme alla celebre Angelica Balabanoff.
Dopo un breve soggiorno in Belgio, nell’estate 1928 si trasferisce nel granducato del Lussemburgo. Lavora a Differdange come aggiustatore nel reparto elettrico della “Societé des Hauts Fourneaux et Aciéres de Defferdange, St. Ingbert, Rumelange” dal 18 agosto 1928 al 16 gennaio 1932. Qui conosce colei che qualche anno più tardi diventerà sua moglie, Luigia Agnese Dazzan, figlia di un friulano costretto anch’egli ad abbandonare la sua terra per motivi politici. Collabora, inoltre, al giornale “L’operaio italiano”. All’inizio del 1933 ritorna a Parigi: per dissensi politici, e sollecitato dall’amico Di Vittorio, aderisce al partito comunista e continua a svolgere sotto altre bandiere la sua militanza antifascista. Viene eletto alla direzione della massima organizzazione antifascista all’estero, l’Unione Popolare Italiana e ne diviene il segretario della regione Parigi-Nord; entra a far parte del Consiglio Nazionale dell’Unione Popolare Italiana, collaborando al giornale dell’UPI, la “Voce degli Italiani”. Oltre al suo impegno nell’organizzazione politica, Semeraro deve darsi da fare per mantenere la sua famiglia, che nel frattempo è andata aumentando con la nascita di due figlie, e svolge mansioni di operaio presso varie officine meccaniche: allo scoppio della guerra, nel settembre 1939, è “aggiustatore di lavorazione” nelle officine aeronautiche Amiot, ma sino al 10 giugno 1940.
Con l’invasione tedesca della Francia, per Semeraro, come per gli altri antifascisti, le cose si complicano notevolmente. È senza un lavoro stabile e con la minaccia di essere deportato in Germania; nel 1942, infatti, è arrestato dalla polizia franco-tedesca ed il 5 ottobre è consegnato alla polizia fascista alla frontiera italiana di Bardonecchia. Mentre il resto della famiglia riesce a rifugiarsi a Mesagne, Semeraro è “trattenuto” per quindici giorni nelle carceri di Susa, in attesa di disposizioni provenienti dal Ministero dell’Interno. È poi trasferito nelle carceri di Brindisi, dove rimane sino alla vigilia del Natale del 1942. Intanto la Commissione provinciale di confino lo condanna a cinque anni di confino da scontarsi alle isole Tremiti. Qui rimane dall’8 gennaio 1943 al 18 agosto dello stesso anno. Dopo la deposizione e l’arresto di Mussolini del 25 luglio, infatti, Semeraro è liberato e può far ritorno nella sua Mesagne dopo 18 anni di assenza. Riprende immediatamente la lotta politica democratica nel brindisino: è nominato segretario politico della Federazione provinciale del partito comunista (sino al 1948); fa parte della commissione per l’epurazione delle amministrazioni pubbliche della provincia di Brindisi, designato dall’Alto Commissariato per l’Epurazione; è assessore alla Sepral (ente per la distribuzione dei viveri). Nel ’44, in qualità di assessore anziano, è vice sindaco nell’amministrazione democratica di Mesagne, formata dai partiti antifascisti costituenti il CLN. Dal 1946 al 1951 è sindaco di una giunta popolare socialcomunista e si prodiga per la rinascita economica e morale del paese nel difficile periodo della ricostruzione. Candidatosi nelle file del PCI alle elezioni politiche del 18 aprile 1948, viene eletto Deputato al 1° Parlamento repubblicano nel XXV Collegio di Lecce – Brindisi – Taranto con 33.682 preferenze: proclamato il 25 aprile, la sua elezione è convalidata il 17 luglio. È assegnato alla V Commissione difesa dal 15 giugno 1948 al 18 febbraio 1949, poi passa alla VIII Commissione Trasporti – Poste e Telegrafi – Marina mercantile dal 18 febbraio (e segretario dal 1° luglio 1949).
Nelle successive elezioni del 7 giugno 1953 viene riconfermato alla Camera dei Deputati con 25.675 voti. È proclamato il 17 giugno 1953, convalidato il 6 maggio 1954 ed è assegnato alla Commissione Trasporti dal 1° luglio 1953. Anche dai banchi di Montecitorio, Semeraro si impegna costantemente sollecitando sempre il governo ad una più intensa azione risanatrice del Mezzogiorno. Nella seduta pomeridiana del 29 ottobre 1949 Semeraro affermava: “Una cosa è certa, onorevoli colleghi; da oltre un anno noi siamo chiamati a votare leggi d’urgenza che comportano una spesa di miliardi su miliardi di lire a beneficio del Mezzogiorno e delle isole, ma noi meridionali e in special modo noi pugliesi o lucani siamo costretti a dover constatare che ben poco è cambiato nella amministrazione ferroviaria da quando Brindisi per parecchi mesi fu scelta come capitale d’Italia da un governo in fuga. (…) Nei periodi elettorali, specie da parte di candidati di parte governativa, numerose sono le promesse; ma, passate le elezioni, nessuno più se ne ricorda. Per cui, onorevole ministro, vorrei invitarla, dato che dovrà essere fatto il doppio binario Bari – Lecce, a esaminare la possibilità di dare al tratto Monopoli – Brindisi un nuovo tracciato che si avvicini ai centri abitati (…). Voglio ora richiamare la vostra attenzione, e quella del governo, sul fatto che, mentre tanto si parla di industrializzazione del Mezzogiorno, sono proprio le poche officine del Mezzogiorno che, invece di prosperare, licenziano e minacciano sempre nuovi licenziamenti o sospensioni di operai per mancanza di lavoro”.
Nella seduta del 10 aprile 1951, Semeraro poneva all’attenzione del Ministro del Lavoro il problema “se nell’imminente programma del terzo anno del piano di attuazione alloggi I.N.A.- Casa verrà compreso il comune di Mesagne, escluso per il secondo anno, mentre la mancanza di alloggi si fa sentire e la disoccupazione diviene nella categoria edile ogni anno più grave”. Inoltre si batté contro la famigerata “legge – truffa”; nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 1952 criticava il meccanismo elettorale proposto dalla maggioranza governativa: “in quale situazione, onorevoli colleghi, si troveranno i milioni di lavoratori che appena sanno leggere, oppure sono analfabeti? Essi devono essere illuminati prima di esprimere il loro voto; devono conoscere dove questo loro voto andrà a finire col gioco delle varie moltiplicazioni, addizioni e sottrazioni dei vari decimali e dei vari indici. Onorevoli colleghi, avete presente la piaga dolorosa dell’analfabetismo che infesta le nostre popolazioni del mezzogiorno d’Italia sin dall’unità nazionale? Tale piaga si sta allargando sempre più dopo i sette anni di governo democratico cristiano, che, invece di porre dei radicali rimedi con lo stanziare i fondi necessari per la ricostruzione di nuovi edifici scolastici, consente che i figli dei nostri lavoratori siano, in numero sempre maggiore, respinti dalla scuola, perché non vi sono aule sufficienti. (…) Essi [i lavoratori meridionali] reclamano che l’imponibile di manodopera sia effettivamente applicato; esse reclamano la nuova legge sui contratti agrari con la giusta causa; essi domandano opere di bonifica affinché le acque, nei giorni di pioggia, non invadino [sic!] le loro case oppure grandi vastità di terreno distruggendone il raccolto, riducendoli alla disoccupazione e spingendoli verso la miseria più nera. (…) I senza tetto reclamano case degne di essere abitate. I giovani reclamano che sia impedita questa truffa elettorale ai danni delle masse lavoratrici e si applichi la Costituzione repubblicana nei suoi principi innovatori, facendo approvare leggi necessarie perché sia eliminata la disoccupazione giovanile, perché sia data a tutta la gioventù la possibilità di praticare lo sport dando ad essa i mezzi necessari per farlo”.
Nel frattempo dall’aprile 1957 al marzo 1958 è di nuovo a capo dell’amministrazione comunale mesagnese. Dopo i tragici fatti d’Ungheria dell’ottobre – novembre 1956, Semeraro si scontra con le posizioni ufficiali del PCI che si dimostra troppo filosovietico: viene isolato politicamente e accusato di protagonismo. Come molti altri che furono radiati o abbandonarono, Semeraro è espulso dal partito il 12 luglio 1958. Molti di essi costituirono il movimento degli ex-comunisti (che prenderà poi il nome di “Alleanza socialista”) guidato dal sen. Eugenio Reale e da Michele Pellicani. Semeraro entra nel Comitato Nazionale di tale movimento che organizza il suo primo convegno a Roma nei giorni 21-22 novembre 1958. In quella sede Semeraro, che faceva parte della presidenza, definiva il convegno “il primo tentativo a carattere nazionale di uomini che hanno avuto la stessa fede, che insieme hanno sofferto per ritrovarsi su una stessa piattaforma politica, per lottare di comune intento per il socialismo”. Al XII Congresso (tenutosi dal 16 al 20 novembre 1959) del P.S.D.I., il movimento di “Alleanza socialista” confluisce in questo partito e Semeraro fa parte del Comitato Centrale. Nel 1960 è eletto al Consiglio provinciale di Brindisi ed entra nella Giunta come assessore effettivo degli Affari generali; è consigliere comunale a Mesagne ed è consigliere al Consorzio del Porto di Brindisi. Inoltre è segretario della Federazione provinciale del P.S.D.I.. Nel 1964 viene rieletto al Consiglio provinciale di Brindisi e a quello comunale di Mesagne. Il 3 febbraio 1965 muore nella sua casa di via G. Falcone n. 17.
